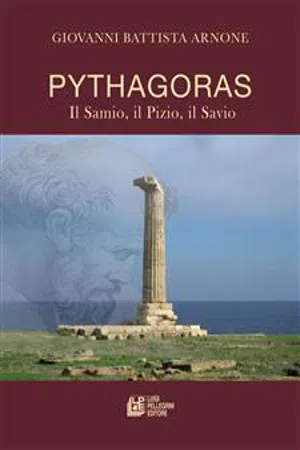Il mondo al tempo di Pitagora
Verso la fine del VI secolo a.C. lo sviluppo sociale di Mileto subì un notevole rallentamento, e così pure l’attività filosofica. Molti greci saranno spinti dalla minaccia persiana a migrare verso occidente, popolando così le coste della Magna Grecia che divenne in questo modo il nuovo teatro dello sviluppo del pensiero filosofico. Nel 499 a.C., nella Ionia ormai controllata dai persiani, si verificò una rivolta, un tentativo di rigettare il controllo straniero attraverso l’instaurazione della democrazia, onde poter ristabilire una situazione più favorevole allo sviluppo dei traffici e dei commerci, settori che attraversavano un periodo di crisi. Tuttavia nel 494 i persiani si impadronirono nuovamente del controllo delle città ioniche e diedero luogo ad una dura repressione. All’inizio del secolo V a.C., ormai alla vigilia dello scontro tra Ellade e Impero persiano, viene volgendo al termine l’età più innovativa e creatrice dell’intera storia greca, quel periodo più vecchio e precedente avviato con la rinascita del secolo VIII che aveva visto conquiste di enorme rilievo: dall’alfabeto alla monetizzazione, dalla città-stato alla storiografia. Contestualmente poteva dirsi concluso anche il processo di amplissime proporzioni che nel giro di due secoli e mezzo aveva condotto i Greci a fondare un gran numero di città sulle coste del Mediterraneo e del mar Nero. La peculiarità di tale fenomeno fu che non si trattò mai della costituzione di imperi coloniali quali la storia recente ci ha abituato a conoscere. Le nuove fondazioni erano comunità autonome e pienamente sovrane. Ne consegue che le colonie non nascevano in ossequio a concezioni strategiche, vasti disegni di politica internazionale ovvero interessi di carattere mercantilistico. È conveniente dunque distinguere la colonizzazione dei secoli VIII-VI dagli altri fenomeni di età posteriore. In questo contesto va crescendo il peso politico di Atene, che si candida sempre di più come città guida di un nuovo impero (non dimentichiamo che quella che chiamiamo Grecia in quell’epoca era un insieme di città-stato autonome, le quali si univano solo in caso di guerra). A premere affinché Atene non si accontentasse di semplici accordi con la Persia, ma combattesse per distruggerla, fu la classe dei mercanti, borghesia imprenditoriale e mercantile, la quale vedeva nella possibile espansione l’occasione per nuovi e più ampi guadagni. Ma a guidare l’alleanza (Symmachia) che doveva far fronte alla minaccia persiana fu Sparta, caratterizzata all’epoca da un governo forte e autoritario, e non democratico come ad Atene. Solo lentamente Atene avrebbe conquistato quel ruolo di guida che ne avrebbe fatto il centro politico e culturale della Grecia. Questi avvenimenti ci aiutano comunque a comprendere perché ad un certo punto il centro della riflessione filosofica non fu più nelle colonie dell’Asia Minore, ma nella Magna Grecia, dove emigrarono anche pensatori che avevano già iniziato la propria attività nelle colonie. Nella metà dell’VIII secolo si assiste al decollo della vera e propria colonizzazione da parte dei greci dell’Italia meridionale e della Sicilia. Nascono così Cuma in Campania, Zancle (Messina) e Reggio a dominio dello stretto, e, sulla costa orientale di Sicilia, Nasso, Catania, Leontini. Intanto Corinto invia coloni a Corfù e Siracusa; gli Achei della costa settentrionale del Peloponneso fondano sulla costa ionica Sibari (fine dell’VIII secolo) e, pochi anni dopo, Crotone. L’ondata colonizzatrice aveva cause molteplici: il dinamismo e l’accelerato sviluppo del mondo metropolitano, che stava definitivamente uscendo da una fase di ristagno e di ripiegamento su se stesso; una forte crescita demografica; squilibri strutturali connessi ai mutamenti in corso. Simile ondata di colonizzazione si verificò sulle coste del mar Nero. La nostra attenzione è rivolta, però, alle vicende dell’Italia meridionale dove l’occupazione stabile e sempre più sistematica ebbe luogo solo successivamente, nel corso del VII secolo. Si consolida il mondo acheo della costa ionica d’Italia, con la fondazione di Metaponto (metà secolo VII); si espande Siracusa. I calcidesi fondano Imera (Termini Imerese); i Colofoni dell’Asia minore ionica si stabiliscono a Siris (nei pressi dell’attuale Nova Siri), tra Sibari e Metaponto; genti delle Locridi, nella Grecia centrale, danno vita a Locri Epizefiri. A partire dai decenni successivi alla metà del secolo VII la vicenda dell’insediamento coloniale greco in Italia viene assumendo connotati diversi: è l’epoca dello sviluppo territoriale, talora assai considerevole, economico e civile delle colonie, alcune delle quali (Sibari, Gela e Siracusa tra tutte) devono essere considerate tra i centri più cospicui dell’intero mondo ellenico contemporaneo; se queste fondano a loro volta sotto-colonie e organizzano vasti ambiti di dominio, viceversa le nuove fondazioni dei centri metropolitani sono poche. Vanno ricordate la megarese Selinunte (circa 628 a.C.) ed Elea, sulla costa della Campania a sud di Paestum, stabilita poco dopo il 540 a.C. dai Greci d’Asia di Focea che già si erano insediati a Marsiglia (circa 600 a.C.) e avevano animato una nuova stagione dell’attività commerciale greca soprattutto nel Tirreno. Le colonie ebbero un progresso così rapido e così qualificato che, a partire dalla 50° edizione olimpica (580 a.C.), superarono la madre patria. La loro supremazia fu tale che il secolo successivo fu denominato il secolo coloniale di Olimpia. In particolare i crotonesi dominarono incontrastati le corse di velocità nella 51° Olimpiade, piazzando ben sette corridori ai primi posti nella gara dello stàdion. Le affermazioni dei crotonesi continuarono con regolarità per circa un secolo; su 25 edizioni dei Giochi, per ben 18 volte la città della Magna Grecia si impose con un suo atleta. Dopo il predominio dei crotonesi, per varie edizioni nessuna città riuscì a prevalere decisamente sulle altre; è questa l’epoca durante la quale i Giochi conobbero il loro migliore momento di penetrazione in paesi sempre più lontani.
Dal punto di vista morale, un quadro analitico del periodo preso in considerazione lo fa Schuré nel suo libro “I grandi iniziati”:
«Il livello morale e intellettuale dei templi era scaduto. I sacerdoti si vendevano al potere politico; gli stessi Misteri cominciarono a corrompersi. Era cambiato il volto della Grecia. All’antica regalità sacerdotale e agricola era subentrata qui la pura e semplice tirannia, là, l’aristocrazia militare; altrove, la democrazia anarchica. I templi erano ormai impotenti a prevenire la dissolutezza che si addensava all’orizzonte. Occorreva uno strumento nuovo, una volgarizzazione delle dottrine esoteriche. Perché la concessione orfica potesse vivere e schiudersi in tutto il suo splendore, era necessario che la scienza liturgica passasse nelle mani dei laici. Sotto varie forme, essa dunque si fece strada nella mente dei legislatori, nelle scuole di poesia, sotto i portici dei filosofi, nei cui insegnamenti affiorava la stessa necessità che Orfeo aveva riconosciuto alla religione: quella, cioè, di due tipi di dottrina, una pubblica e l’altra segreta, che esponevano la stessa verità, in forme diverse, a seconda delle capacità intellettuali dei discepoli. Questa evoluzione diede alla Grecia i suoi tre grandi secoli di creazione artistica e di splendore intellettuale; consentì alla concezione orfica – impulso primigenio e sintesi ideale della Grecia – di concentrare la sua luce diffondendola in tutto il mondo prima che il suo edificio politico, minato da contrasti interni, vacillasse sotto i colpi della Macedonia per poi infine crollare sotto il pugno di ferro di Roma… la dottrina pitagorica ci appare come un tutto mirabile, un meccanismo composito le cui parti sono collegate da un concetto basilare. In essa ritroviamo una rielaborazione ragionata della dottrina esoterica induista ed egizia alla quale Pitagora seppe dare la chiarezza e la linearità ellenistica, accompagnandola con un senso più vigoroso, un’idea più precisa, della libertà dell’Uomo».
Lo Schuré, saggio interprete della condizione politico-culturale-filosofica di quegli anni, è strenuo sostenitore della saggezza e dell’operato di Pitagora.
Panorama politico
Le città greche, e quelle dai greci fondate, in quest’epoca (VII-VI secolo a.C.) sono centri in cui c’è fermento economico, sociale, commerciale e culturale che denota interesse in tutti i campi del vivere umano. Nasce la civiltà intesa in senso moderno. La città greca, oltre alla piazza, agli artigiani, ai commercianti e ai filosofi che la popolano, è caratterizzata da un altro elemento, peraltro dominante: si tratta dell’acropoli, con il suo tempio, governata dalle grandi famiglie aristocratiche che detengono anche le supreme funzioni sacerdotali, l’amministrazione della giustizia e il potere politico. La ricchezza proviene loro dai grandi possedimenti terrieri e dalla loro conoscenza intorno agli dèi, che trova il suo principale luogo dispensatore nel santuario di Apollo a Delfi. Si tratta di quel connubio fra sapere sacro e potere politico che aveva una lunga tradizione alle spalle, relazione che è stata messa seriamente in discussione dai filosofi appartenenti al nuovo ceto sociale nato dai commerci e dall’artigianato. Proprio per reagire a questa minaccia il sapere aristocratico-sacerdotale si rinnova, cercando di proporre una nuova forma di sapere all’altezza dei tempi, ma che lasci al tempo stesso intatti i privilegi della suddetta casta. Nelle polis i diritti e i doveri del cittadino comprendevano l’attività politica, il servizio militare e la partecipazione alla vita religiosa della comunità. Il godimento dei pieni diritti politici spettava solo ai figli maschi adulti di status libero che erano considerati politai, ossia in possesso del diritto di cittadinanza in base a diversi criteri. Dal godimento dei pieni diritti erano escluse le donne, gli stranieri residenti liberi e gli schiavi. Sul piano politico i diritti fondamentali consistevano nell’esercitare la sovranità e le magistrature, praticare l’attività giudiziaria, partecipare alle assemblee. Essere cittadini comportava una serie di vantaggi di carattere puramente economico, dalla retribuzione delle cariche pubbliche, al possesso di beni immobili, all’accesso ai sussidi statali e alle distribuzioni di denaro, grano e carne. Il ruolo di militare nelle città greche era molto importante e la guerra costituiva una delle attività principali del mestiere dell’abitante della polis. La condizione di soldato coincide con quella di cittadino: chi ha il suo posto nella formazione militare della città lo ha parimenti nella sua organizzazione politica.
Tra il VII e il VI secolo a.C. i continui contrasti sociali, acuiti dal malcontento delle classi meno abbienti, portarono da un lato alla codificazione scritta delle leggi, iniziata nelle colonie, dall’altro al sorgere della tirannide. Così figure semi-leggendarie, e non, di grandi legislatori, quali Zaleuco di Locri, il giurista Diocle di Siracusa, Caronda di Catania con le sue rigide leggi, e Dracone di Atene si affiancarono a uomini ambiziosi e senza scrupoli, come Gelone di Siracusa e Policrate di Samo, che con colpi di stato si impadronirono del potere in moltissime città greche. Ben presto alcune di queste, come Corinto, Tebe, Sparta ed Atene, salirono alla ribalta della scena ellenica, espandendo la propria influenza sulle città limitrofe. Ad eccezione di Sparta, una polis estremamente conservatrice che rimase per lungo tempo legata alla costituzione di Licurgo e non conobbe, se non in minima parte, rivolgimenti sociali e fenomeni di emigrazione, le altr...