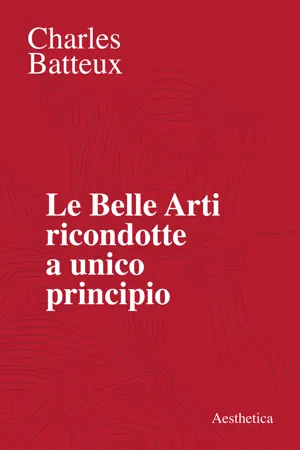
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Le Belle Arti ricondotte a unico principio
About this book
Pubblicato nel 1746, Le Belle Arti ricondotte a un principio influenzò considerevolmente il pensiero estetico della seconda metà del '700. In esso, richiamandosi alla filosofia cartesiana, Batteux cerca di ricondurre l'insieme eterogeneo delle regole che presiedono alla creazione artistica a un unico principio: l'imitazione del bello di natura. Ogni opera d'arte non deve però limitarsi a rispecchiare la natura, ma deve sceglierne le parti più belle "per comporre un insieme perfetto".
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Le Belle Arti ricondotte a unico principio by Charles Batteux in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Philosophy & Aesthetics in Philosophy. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
PhilosophySubtopic
Aesthetics in PhilosophyParte terza
Dove il principio dell’imitazione è verificato mediante la sua applicazione alle diverse arti
Questa parte sarà divisa in tre sezioni, nelle quali proveremo che le regole della poesia, della pittura, della musica e della danza sono tutte comprese nell’imitazione della bella natura.
Sezione prima
L’arte poetica è compresa nell’imitazione della bella natura
L’arte poetica è compresa nell’imitazione della bella natura
I | – | Dove si confutano le opinioni contrarie al principio dell’imitazione |
Se le prove che abbiamo addotte sin qui sono state trovate sufficienti per fondare il principio dell’imitazione, è inutile che ci soffermiamo a confutare le diverse opinioni degli autori sull’essenza della poesia: e se vi ci soffermiamo un momento, non sarà per combatterle, secondo le regole, quanto per darne una breve esposizione che sarà sufficiente a togliere tutti gli scrupoli che potrebbero sorgere nell’animo del lettore.
Alcuni hanno creduto che l’essenza della poesia fosse la finzione. Non si tratta che di spiegare il termine e di mettersi d’accordo sul suo significato. Se per finzione s’intende la stessa cosa che “fingere” (fingere presso i latini), il termine finzione non può significare che l’imitazione artificiale dei caratteri, dei costumi, delle azioni, dei discorsi, ecc. Così che fingere sarà la stessa cosa che rappresentare o piuttosto contraffare: e allora questa opinione rientra in quella che abbiamo stabilita.
Se essi poi restringono il significato di questo termine, e mediante finzione intendono il ministero degli dei, che il poeta fa intervenire per mettere in gioco le molle segrete del suo poema, è evidente che la finzione non è essenziale alla poesia; perché, altrimenti, la tragedia, la commedia, la maggior parte delle odi cesserebbero di essere dei veri poemi, ciò che risulterebbe contrario alle idee più universalmente accolte.
Infine, se mediante finzione si vogliono significare le immagini che prestano vita alle cose inanimate, e danno corpo alle cose insensibili, e che le fanno parlare ed agire, quali le metafore e le allegorie, la finzione allora non è altro che un artificio poetico che può convenire alla prosa stessa. Ed il linguaggio della passione che sdegna l’espressione volgare; l’ornamento e non il corpo della poesia.
Altri hanno creduto che la poesia consistesse nella versificazione. Il popolo, colpito da questa misura sensibile che caratterizza l’espressione poetica e la separa da quella della prosa, dà il nome di poema a tutto ciò che è messo in versi: storia, fisica, morale, teologia, tutte le scienze, tutte le arti che devono essere il naturale fondamento della prosa, divengono così argomenti di poema. L’orecchio, colpito da cadenze regolari, l’immaginazione scaldata da qualche ardita figura che ha bisogno di essere autorizzata dalla licenza poetica, talora anche l’arte dell’autore, nato poeta, ha comunicato una parte del suo fuoco a materie aride che sembrano rifiutarsi alle grazie, tutto ciò seduce gli spiriti poco istruiti sulla natura delle cose; e dal momento che si vede l’esterno della poesia ci si arresta alla scorza senza darsi la pena di penetrare più oltre. Si vedono dei versi e si dice, ecco un poema, unicamente perché non è prosa.
Questo pregiudizio è antico quanto la stessa poesia. I primi poemi furono degli inni che si cantavano, e al canto dei quali si associava la danza. Omero e Tito Livio ne diedero la prova 46. Ora per formare un concerto di queste tre espressioni, delle parole, del canto e della danza occorreva necessariamente che esse avessero una misura comune che le facesse cadere tutte e tre insieme, senza di che l’armonia sarebbe stata sconvolta. Questa misura era il colorito: ciò che colpisce subito tutti gli uomini. Mentre l’imitazione che ne era il fondamento e come la ragione, è sfuggita alla maggior parte degli occhi che la vedevano senza notarla.
Tuttavia, questa misura non costituì mai ciò che si dice un vero poema:
…Neque enim concludere versum,
Dixeris esse satis 47.
E se questo bastasse, la poesia non sarebbe che un gioco da bambini, un frivolo accostamento di parole che la minima trasposizione farebbe scomparire:
Eripias si
Tempora certa modosque et quod prius ordine verbum est,
Posterius facias, præponens ultima primis 48.
Allora la maschera è tolta; si riconosce la prosa in tutta la sua semplicità e nudità: il poeta non c’è più.
Ma non è così della vera poesia. Si ha un bel rovesciare l’ordine, scompigliare le parole, rompere la misura: essa perde l’armonia, è vero, ma non perde la sua natura. La poesia delle cose rimane sempre; la si trova nelle membra disperse:
Invenias etiam disjecti membra Poetæ 49.
Ciò non impedisce che non si convenga che un poema senza versificazione non sarebbe un poema. Lo abbiamo già detto, le misure e l’armonia sono i colori senza di cui la poesia non è che una stampa. Il quadro rappresenterà, se volete, i contorni o la forma, e tutt’al più le luci e le ombre locali; ma non vi si vedrà il colorito perfetto dell’arte.
La terza opinione è quella che pone l’essenza della poesia nell’entusiasmo. L’abbiamo definita nella Parte prima e ne abbiamo rilevato le funzioni che si estendono ugualmente a tutte le belle arti. E questo si addice anche alla prosa, perché la passione, con tutti i suoi gradi, non si eleva meno sulle tribune piuttosto che sui teatri. Cicerone vuole che l’oratore sia ardente come la folgore, veemente come un uragano, rapido come un torrente, e che egli si precipiti, e che sconvolga tutto con il suo impeto. «Vehemens ut procella, excitatus ut torrens, incensus ut fulmen, tonat, fulgurat et rapidis eloquentiæ fluctibus cuncta proruit et proturbat» 50. L’entusiasmo poetico ha niente di più travolgente e violento? E quando Pericle
Tonnoit et foudroyoit et renversoit la Grèce 51
l’entusiasmo regnava forse, nei suoi discorsi, con meno imperio che nelle Odi pindariche?
Ma questo grande fuoco non si sostiene sempre nell’orazione: si sostiene allora nella poesia? E se si rispondesse affermativamente, quanti veri poemi cesserebbero di essere tali?
Si cita in favore dell’entusiasmo il famoso passo di Orazio:
Ingenium cui sit, cui mens divinior atque os
Magna sonaturum, des nominis huius honorem 52.
Questo passo non decide la questione: non vi si tratta della natura della poesia, ma delle qualità di un poeta perfetto. Due cose diverse, così come il pittore e il dipinto. In secondo luogo, supposto che questi versi debbano riferirsi alla natura della poesia, non stabiliscono necessariamente l’opinione di cui si è detto. Aristotele, che fa consistere l’essenza della poesia nell’imitazione, non esige meno di Orazio questo genio, questo furore divino 53.
Orazio non aveva lo scopo, in questo passo, di definire esattamente la poesia. Ha colto una parte, ma senza volere abbracciare il tutto. E una di quelle definizioni che non sono né tutte vere né tutte false, che si usano quando si vuole chiudere la bocca a coloro che non si ritengono degni di una confutazione seria: ed era questo il caso in cui il poeta latino si trovava.
Alcuni censori, di merito mediocre, animati forse da un interesse personale a prendere posizione contro le sue satire, gli avevano rimproverato di essere un poeta mordace. Orazio risponde loro al modo di Socrate, non tanto per correggerli, quanto per mostrare la loro ignoranza. E li ferma alla prima parola: vuole far loro intendere che non sanno nemmeno che cosa è la poesia. Per questo ne traccia un quadro che non conviene per niente a ciò che essi avevano chiamato poesia mordace. Per confermare questa idea ed accrescere il loro imbarazzo, egli cita l’opinione di coloro che si erano domandati se la commedia fosse propriamente un poema, quidam quæsivere 54. Posto ciò, è chiaro che Orazio non pensava certo a definire rigorosamente la poesia, ma solo a porre in rilievo ciò che essa possedeva di più grande e di più splendido, e che conveniva di meno alle sue satire. E che così sarebbe risultato un abuso il voler commisurare tutti i generi poetici mediante questa pretesa definizione.
Ma, si dirà, l’entusiasmo ed il sentimento sono la stessa cosa, ed il fine della poesia è provocare il sentimento, commuovere, piacere. D’altronde, il poeta non deve provare egli stesso il sentimento che vuole suscitare negli altri? Quale conclusione trarre dunque da tutto ciò? Che i sentimenti e l’entusiasmo sono il principio e la fine della poesia? Potrebbe esserne questa l’essenza? Certo, se si vuole che la causa e l’effetto, il fine ed il mezzo siano la stessa cosa: perché qui si tratta di essere precisi.
Atteniamoci dunque all’imitazione, che è tanto più probabile in quanto comprende l’entusiasmo, la finzione, la stessa versificazione, come mezzi necessari per imitare perfettamente gli oggetti. Lo si è visto sinora, e lo si vedrà sempre più nei particolari che seguiranno.
II | – | Le distinzioni della poesia si ritrovano nell’imitazione |
La vera poesia consiste essenzialmente nell’imitazione: e perciò nella stessa imitazione si debbono trovare le sue varie distinzioni.
Gli uomini acquisiscono la conoscenza di ciò che è fuori di loro mediante gli occhi e le orecchie: che vedano le cose direttamente essi stessi, o le odano narrare dagli altri. Questo duplice modo di conoscere produce la prima divisione nella poesia e la distingue in due specie, di cui l’una è la drammatica, in cui vediamo le cose rappresentate dinanzi ai nostri occhi e udiamo i discorsi diretti delle persone che agiscono; l’altra l’epica, ove non vediamo né ascoltiamo niente direttamente, e dove tutto è narrato:
Aut agitur res in scænis, aut acta refertur 55.
Se di queste due specie se ne forma una terza che sia mista, cioè unione dell’epico e del drammatico, dove sia presente lo spettacolo e il racconto, allora tutte le regole di questa terza specie saranno contenute in quelle delle altre due.
Questa distinzione, che è fondata solo sul modo in cui la poesia mostra i suoi oggetti, è seguita da un’altra, che deriva dalla qualità degli oggetti stessi trattati dalla poesia.
A muovere dalla divinità, e sino agli insetti più infimi, tutto ciò a cui si può attribuire azione è sottoposto alla poesia, in quanto lo è all’imitazione. Così, come vi sono gli dei, i re, i semplici cittadini, i pastori, gli animali, così l’arte si è compiaciuta di imitarli nei loro atti veri e verosimili; vi sono così opere in musica, tragedie, commedie, pastorali, apologhi. Ed è questa, la seconda distinzione, all’interno della quale ogni membro può essere ancora suddiviso, secondo la diversità degli oggetti anche se situati nello stesso genere.
Tutte queste specie hanno le loro regole particolari, che esamineremo dettagliatamente in rapporto ai nostri fini. Ma poiché ve ne sono anche di comuni, sia per quanto concerne il fondamento delle cose, sia per la forma dello stile poetico, cominceremo da quelle generali, e proveremo che sono tutte comprese nell’esempio della bella natura.
III | – | Le regole ge... |
Table of contents
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Presentazione
- Le Belle Arti ricondotte a unico principio
- PARTE PRIMA: Dove si fonda la natura delle arti mediante quella del genio che le produce
- PARTE SECONDA: Dove si stabilisce il principio dell’imitazione mediante la natura e le leggi del gusto
- PARTE TERZA: Dove il principio dell’imitazione è verificato mediante la sua applicazione alle diverse arti
- ADDENDA: Le passioni sono l’oggetto principale della musica e della danza
- Note
- Appendice biobibliografica