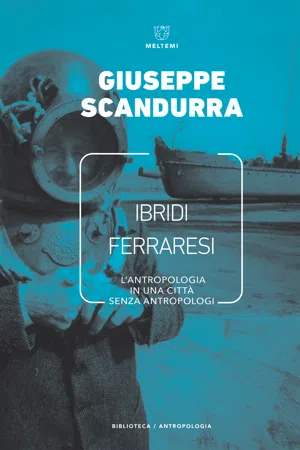![]()
Capitolo quarto
4.1 Lo sguardo esterno
Esplode il paesaggio italiano con una vigoria e una drammaticità nuove […]. I confini ancora ristretti entro i quali si era esercitato il gusto pittorico e paesaggistico dei migliori fra i formalisti, vengono spezzati e valicati con coraggio per un’esplorazione avventurosa e ardita. Le strade e le pianure assolate dell’Emilia, il corso maestoso del Po, e i suoi argini prolungati verso orizzonti interminabili, le vie contorte e le piazzette delle città di provincia, affollate di mercanti e di biciclette, la fiera all’aperto […], sono elementi che danno al film prospettiva e respiro inconsueti. A questi esterni, il film alternava ambienti altrettanto nuovi: osterie, alberghetti di terz’ordine dalle camere squallide, terze classi dai sedili di legno, uffici di polizia dalle pareti spoglie e bianche e dalla mobilia triste. (Lizzani su Ossessione, 1992, in IBC 2008, p. 54)
Quando ho iniziato a spiegare a quelli che sarebbero con il tempo diventati miei preziosi collaboratori i miei obiettivi di ricerca ho ricevuto diversi consigli. Roberto Roda, per esempio, avrebbe voluto che io circoscrivessi il periodo storico sotto osservazione dentro una finestra temporale che avrebbe dovuto partire dalla fine del Diciannovesimo secolo, quando tutto, a Ferrara e nella sua provincia, era ancora non “strutturato”:
Non ti puoi affidare a una ricerca, devi produrre delle cose. Non c’è una letteratura già pronta, devi costruire una squadra di ricerca e avere un ufficio dove raccogliere del materiale che non è sistematizzato, non ti basta andare in biblioteca. Bisogna produrre dei dati che poi serviranno alla città. La domanda deve diventare: “Cosa muoveva tanta cultura laddove le istituzioni comunali ancora non erano strutturate?” […]. Da questo punto di vista io partirei da fine Ottocento... . (Roda, intervista settembre 2018)
Lo storico ferrarese Pietro Pinna, quando ho iniziato a raccogliere materiali trascorrendo intere giornate nella principale biblioteca pubblica, l’Ariostea, mi ha suggerito di non fare troppo affidamento a testi pubblicati, perché la storia che volevo raccontare andava in qualche modo scritta daccapo:
La videoarte, il direttore Farina, Nello Quilici… queste storie sono conosciute ma nessuno ha mai ricostruito la relazione tra queste cose. Rimangono studiate come momenti isolati quando invece una struttura sicuramente ci deve essere. Per esempio oggi sappiamo che c’è stata una rete di documentaristi, cosa che prima non si sapeva, pur sapendo che molti giravano a Ferrara. Ci sono molti micro nuclei di conoscenza storica; manca l’idea che queste cose non erano piccoli episodi staccati. (Pinna, intervista dicembre 2018)
Lo storico dell’arte Ranieri Varese, docente presso l’Ateneo di Ferrara per diversi anni, confermando lo scetticismo di Pietro Pinna mi spinse a cercare documenti presso l’archivio dell’Istituto di Storia Contemporanea e l’archivio Storico:
Non ci sono tanti libri su questo. Ci sono i volumi curati da Moretti [La cultura ferrarese tra le due guerre mondiali (1980), n.d.a.], poi ci sono i due volumi su Ferrara curati credo da Renzi [i due volumi dal titolo Ferrara (1969), n.d.a.]. Poi c’è questo volume di Lugli su un allievo di Capitini [mi mostra il libro pubblicato da Lugli (2017), n.d.a.] che dà uno spaccato di Ferrara del Dopoguerra fino agli anni Cinquanta; poi non ci sono altre cose di questo tipo. C’è un volume di Sitti sulla chiusura dell’Eridania [Processo all’Eridiana (1970), n.d.a]. Una bibliografia non c’è su questo. (Varese, intervista gennaio 2019)
Quello che però tutti denunciavano, nel momento in cui segnavo sul mio diario i miei primi movimenti, era la mancanza di un materiale sistematizzato. Da una parte la “frammentarietà” sembrava la parola più appropriata per descrivere la tipologie di opere che potevo studiare – tra archivi, pubblicazioni raccolte nelle biblioteche cittadine, articoli di giornale, volumi conservati da singoli cittadini –, dall’altra, come sottolinea Patrizia Fiorillo, tale frammentarietà sembrava avere a che fare con storie e racconti orali autoreferenziali dove il confine tra leggenda e avvenimento reale è sempre molto labile. La docente di Storia dell’Arte contemporanea di Ferrara, Fiorillo, mentre iniziavo a raccogliere i primi dati di ricerca, aveva pubblicato il suo testo Arte contemporanea a Ferrara (2017) in cui, scegliendo come finestra temporale Ferrara dai primi anni Sessanta alla fine del XX secolo, ha ricostruito le vicende storico-artistiche del capoluogo estense – un’altra storia poco raccontata:
Io volevo conoscere maggiormente il territorio e trasferire questa storia ai nostri studenti. Io vengo da un insegnamento universitario in cui il contatto con gli artisti era importante e continuo; poi questa è una storia raccontata con troppa frammentarietà, molte relazioni rimangono opache oppure vivono solo nel campo della mitologia. Ci sono delle cose poi che non riesci a capire, ed è una città particolare da questo punto di vista. Quello che abbiamo cercato di fare è anche andare da fonti dirette, non solo indirette. Ovvero, verificare di prima mano. La frammentazione era grande. (Fiorillo, intervista marzo 2018)
Un altro problema era relativo al fatto che gli studi contemporanei a Ferrara non hanno mai avuto troppo peso, soprattutto nel campo delle scienze sociali. Per quanto riguarda ricerche di natura qualitativa, etnografiche e contemporanee, il libro della Salkoff è l’unico testo accademico che ha concentrato il suo sguardo di ricerca sul territorio ferrarese. Come sottolinea lo storico Franco Cazzola, la contemporaneità non è mai stata oggetto di studio in città – in questo senso l’operazione di ricerca condotta da Fiorillo segnava un punto di novità e la mia intenzione era quella di continuare a battere quella strada:
Carducci, D’Annunzio e Bassani, certamente […]. Rimane duro fare un discorso sull’antropologia urbana, perché qui rimane solo il discorso di “Quando Ferrara era grande”, quando rubarono a Ferrara il Po dentro un grande scontro politico con Bologna […]. Qui la sociologia non c’è mai stata. (Cazzola, intervista giugno 2018)
Sarebbe bello continuare questa ricerca, indagare ancora meglio, magari su un piano socio-antropologico. Bisognerebbe integrare questo tipo di sguardi, a partire per esempio da quello che manca nel mio libro… per esempio sulle relazioni e il ruolo degli intellettuali. Basti pensare alla figura di Renato Sitti, tutta secondo me ancora da scoprire. (Fiorillo, intervista marzo 2018)
Dal punto di vista storico, risultava difficile ricostruire un periodo che andava dai primi anni del Dopoguerra a fine anni Ottanta. Alle volte i diretti testimoni conoscevano solo un arco di tempo molto limitato, in altri casi il materiale consultabile era depositato in case private e ottenerlo era realisticamente impossibile. Da questo punto di vista la prima scoperta è stata quella dei giornali e del ruolo che hanno avuto nel territorio ferrarese per grande parte del Novecento. I primi documenti che ho analizzato sono stati pubblicati su riviste locali e hanno avuto molto peso nel produrre rappresentazioni di questo territorio. Studiosi ferraresi di nascita come Ranieri Varese ricordano come la loro stessa formazione sia passata per la lettura o la scrittura di articoli ed editoriali su riviste che hanno fatto la storia della città.
Nei libri di Bassani, per esempio, in molte occasioni i giornali sono al centro della narrazione per raccontare avvenimenti storici legati a questo territorio:
Perché non riconoscevo, infatti, che dopo il comunicato del 9 settembre, e perfino dopo la circolare aggiuntiva del 22, le cose, almeno a Ferrara, erano andate avanti quasi come prima? Verissimo – ammise, sorridendo con malinconia –: durante quel mese, fa i settecentocinquanta membri della nostra Comunità non si erano verificati decessi di tale importanza che fosse valsa la pena di darne notizia su “il Corriere ferrarese”. (Bassani 1999, p. 73)
L’esempio più significativo è il “Padano”, il luogo dove si sono conosciuti e formati molti intellettuali che poi sarebbero diventati protagonisti della vita culturale ferrarese, come scrive Walter Moretti (1980). Da una parte, i giornali ferraresi sono quelli provinciali su cui si abbatteva già nei primi decenni del Novecento De Pisis: “Nella città dalle 100 meraviglie, specie in certi periodi dell’anno, è un pullulare di gi...