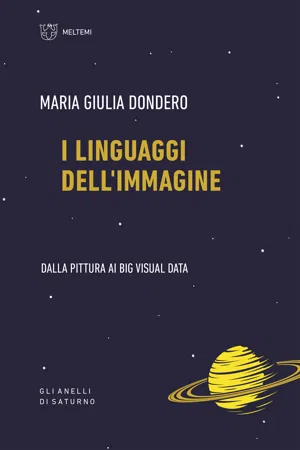![]()
II. L’enunciazione come appropriazione: produzione e osservazione
La seconda accezione di enunciazione concerne l’atto di appropriazione della langue via una selezione individuale che confluisce in un prodotto linguistico chiuso e compiuto (la parole) chiamato enunciato. L’enunciato è il risultato di un atto oggettivato su un supporto.
L’enunciato, sia esso verbale, pittorico, fotografico, filmico, è inteso come totalità significante: questi differenti tipi di enunciato condividono il fatto di essere stati prodotti da un atto enunciazionale, da un gesto di débrayage. Un enunciato si caratterizza per il fatto che è stato prodotto a partire da un atto che gli ha assicurato i limiti e le frontiere (la cornice, nel caso del dipinto; la copertina e la quarta di copertina nel caso del romanzo, i titoli di testa e i titoli di coda nel caso del film, ecc.).
Nella semiotica greimasiana si postula che gli enunciati visivi siano analizzabili come sistemi di significazione a partire dai rapporti differenziali tra forme, colori e posizioni. Tali rapporti differenziali permettono di comprendere la costruzione del punto di vista e la posizione che l’osservatore dovrebbe occupare – spaziale, pragmatica, cognitiva e passionale. Come abbiamo anticipato poco sopra, l’enunciato prefigura una presa di posizione, dei percorsi dello sguardo, così come un insieme di valori da condividere con l’osservatore.
Se l’enunciazione concerne, nel linguaggio verbale, il modo di asserire qualcosa (débrayer) e di assumere una responsabilità nei confronti di ciò che è stato enunciato (embrayer), nel caso dell’immagine essa concerne piuttosto il fare corporeo, che articola in maniera coestensiva un fare della produzione (dipingere, fotografare, disegnare, ecc.) e un fare dell’osservazione (contemplare, guardare, percepire, ecc.). Come abbiamo già affermato, la semiotica si dedica allo studio dei simulacri della produzione e dell’osservazione, chiamati enunciatore ed enunciatario. Questi simulacri hanno lo stesso ruolo dei pronomi io e tu utilizzati nel discorso quotidiano. Si tratta di simulacri della soggettività nelle forme della presa d’iniziativa (l’io) e dell’appello/del rivolgersi a (il tu) all’interno della costruzione discorsiva del dialogo. L’enunciatore e l’enunciatario sono infatti identificabili tramite delle configurazioni testuali che prendono il loro posto e che offrono all’interprete in carne e ossa dei modelli possibili di percorsi di lettura: è ciò che viene definita enunciazione enunciata.
L’enunciatore e l’enunciatario formano una coppia di simulacri discorsivi e la loro relazione si caratterizza come una forma di reciprocità. L’enunciatore si costituisce in contemporanea all’enunciatario. Evidentemente, si tratta di due soggetti dell’enunciazione che possono non corrispondere ad alcun personaggio rappresentato nell’immagine, né alla coppia produttore/spettatore empirici; al contrario, li si individua nelle differenti declinazioni dello spazio, nelle prospettive utilizzate, nell’incrocio dei punti di vista, nei ritmi dei fenomeni rappresentati.
Fermiamoci su questo punto. L’enunciazione come istanza semiotica logicamente presupposta dall’enunciato è da distinguere dall’enunciazione come atto non linguistico, di tipo referenziale, legato alla situazione di comunicazione in praesentia. La semiotica classica non cerca di analizzare l’atto di enunciazione in se stesso, ossia gli atti di parlare, dipingere, fotografare – intesi come processi in atto all’interno delle pratiche –, ma di studiare l’enunciazione enunciata, cioè le marche enunciative della soggettività e dell’intersoggettività depositate nel discorso. Lo abbiamo già segnalato: i simulacri del produttore e del lettore/osservatore di un enunciato non coincidono con gli atti dei produttori e destinatari in carne e ossa, ma con le molteplici strategie di cui i soggetti dell’enunciazione dispongono per mettersi in scena, per costruire una retorica del sé e degli altri, secondo tempi e spazi variabili. Il soggetto è quindi un prodotto del discorso, e ciò vuol dire che possiamo studiare la soggettività e l’intersoggettività a partire degli enunciati e non l’inverso.
Una spiegazione convincente della nozione di enunciazione enunciata in immagine ci è offerta dal semiologo e storico dell’arte Louis Marin. In Opacità della pittura (1989), Marin ha chiarito la differenza tra enunciazione enunciata e atto enunciazionale all’interno di una situazione di comunicazione, prendendo spunto da alcuni esempi di dipinti religiosi. Questi ultimi ci sono utili a descrivere, in maniera diversa rispetto a come farebbe un linguista, la differenza tra “enunciazione ristretta” ed “enunciazione estesa” sulla quale ritorneremo in seguito.
Secondo Marin, le Annunciazioni italiane simbolizzerebbero un’omologia tra la struttura di comunicazione dell’Incarnazione di Dio e la struttura dell’enunciazione enunciata. L’idea che fonda questa analogia tra la teoria dell’enunciazione enunciata e la rappresentazione dell’Annunciazione consiste nel fatto che, essendo a fondamento dell’avvenimento singolo dell’apparizione dell’enunciato, l’enunciazione come atto è un “inconoscibile” delle scienze del linguaggio, nello stesso modo in cui l’Incarnazione di Dio è un inconoscibile per le scienze dell’uomo. L’enunciazione così come l’Annunciazione non possono che essere approcciate indirettamente, a partire dalle marche, dalle tracce o indizi che l’avvenimento singolo (l’atto enunciazionale, l’Annunciazione) deposita negli enunciati: in un certo senso, l’enunciazione si manifesta in quanto irrimediabilmente nascosta e inafferrabile, e per sempre, come il segreto nel caso dell’Annunciazione. L’atto dell’Incarnazione di Dio e l’atto d’enunciazione sarebbero entrambi impossibili da comprendere, e non ci resterebbe che studiarne le marche discorsive, i loro residui. A questo proposito Marin prende l’esempio dell’Annunciazione di Domenico Veneziano (1445-1450, Fitzwilliam Museum, Cambridge), che mostra che il segreto dell’Annunciazione è solamente raccontato sull’asse della storia (enunciazione-storia secondo Benveniste), da sinistra a destra, alla terza persona. Infatti l’Angelo Gabriele e Maria sono di profilo e l’accesso al loro sguardo ...