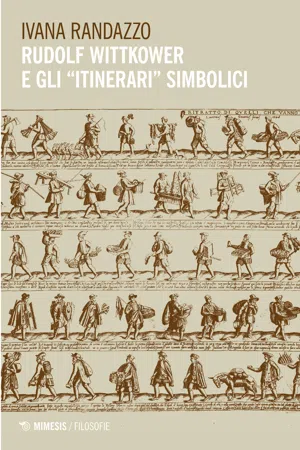![]()
CAPITOLO QUARTO
WITTKOWER E L’ARTE ITALIANA
4.1 – Gli studi su Michelangelo
Il metodo interdisciplinare, che aveva condiviso con i colleghi dell’Istituto Warburg, venne applicato da Rudolf Wittkower anche nel campo dell’architettura, le cui realizzazioni concrete venivano considerate specchio delle elaborazioni teoriche: “È indubbio che la vita di Wittkower è stata consacrata in gran parte a studiare grandi personalità ed opere insigni; è altrettanto vero però che il tipo di analisi condotta da Wittkower, attenta ai legami più che ai tratti distintivi, ai documenti più che ai luoghi comuni, alle implicazioni culturali più che all’isolamento dei caratteri irripetibili, costituisce un grande esempio di metodo”1.
Al periodo londinese ed agli anni in cui fu direttore del Journal del Warburg and Courtauld Institutes (1937-1956) risalgono le pubblicazioni di alcuni saggi che poi sarebbero stati a fondamento di ulteriori, importanti lavori: tra tutti si distingue quello che probabilmente è il suo scritto più celebre, vale a dire Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo2, nato da una serie di articoli su Palladio ed Alberti per il Journal del Warburg and Courtauld Institutes (editi tra il 1940 ed il 1945) e successivamente raccolti in un volume che Fritz Saxl fece stampare nella serie degli Studies of the Warburg Institute3.
I Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo ebbero grande popolarità negli anni ’50: la moglie Margot ricorda che per due anni le lezioni Wittkower rientrarono persino nel programma serale di storia dell’architettura curato dalla BBC. Grazie ai suoi studi si venne sviluppando un nuovo interesse per Palladio e, soprattutto, per la storia dell’architettura4. A contribuire al successo del testo fu anche l’interesse per la ricostruzione degli edifici dopo la guerra, con particolare riguardo per il tema delle proporzioni nell’architettura contemporanea5. Come afferma Howard Hibbard nel necrologio di Wittkower il testo è da considerarsi “il lavoro più originale, così conosciuto da non abbisognare di ulteriori commenti, a meno di ricordare il suo impatto non solo nella storia dell’arte ma anche nelle altre discipline, compresa la progettazione architettonica”6.
Wittkower chiarisce sin dalla Premessa che il suo intento non era quello di sviluppare una storia dell’architettura rinascimentale o di offrire al lettore una monografia su Palladio o su Leon Battista Alberti, quanto quello di chiarire, grazie al lavoro di questi artisti fondamentali dell’epoca, i principi architettonici per lo più seguiti nel periodo rinascimentale7. I due aspetti fondamentali riguardano l’architettura sacra (ora le chiese non vengono più costruite con la pianta a croce latina, ma a pianta centrale) e la proporzione degli edifici8. A cominciare dalla metà del Quattrocento, e soprattutto dalla fine del secolo, in Italia settentrionale si costruisce una vasta quantità di edifici a pianta centrale9. Quest’ultima, basata sulle figure del cerchio e del quadrato, rappresenta un ideale tipico del Rinascimento e della sua simbolica; Wittkower sottolinea, a questo proposito, l’importanza della matematica per l’architettura: “La convinzione che l’architettura sia scienza, e che ciascuna parte dell’edificio, all’interno come all’esterno, debba integrarsi in un unico e identico sistema di rapporti matematici, può essere definita l’assioma fondamentale degli architetti rinascimentali”10.
A partire dagli anni giovanili, dopo avere studiato a Monaco ed a Berlino, Wittkower si trasferisce a Roma, dove collabora con il direttore della Biblioteca Hertziana11 alla raccolta della bibliografia di Michelangelo (1510-1526). Negli anni ‘30 scrive due articoli su Michelangelo: uno sulla Cupola di San Pietro e l’altro sulla Biblioteca Laurenziana, considerata “l’edificio profano più importante e ricco di ripercussioni dell’intero XVI secolo”12. Wittkower ricorda che prima che venisse restaurata, in epoca moderna, la facciata della biblioteca risultava essere frutto di due progetti diversi: inizialmente, infatti, biblioteca e vestibolo dovevano costituire un unico blocco, sotto lo stesso cornicione e lo stesso tetto (il vestibolo, in una prima fase, non era più alto della biblioteca). La biblioteca doveva essere costruita sopra i preesistenti alloggi dei monaci e le nuove mura sopra le vecchie. Michelangelo si preoccupava della stabilità dei muri e ciò sicuramente determinò il problema dell’illuminazione, visto che egli decise di mantenere una fila di finestre chiuse a prosecuzione di quelle della biblioteca.
Wittkower riporta la documentazione attestante le discussioni tra il papa e Michelangelo in merito al luogo ed alla data di avvio della costruzione. In un primo progetto13 le finestre in basso erano cieche, mentre per il piano superiore, di nuova costruzione, erano previste finestre complete e funzionali: “Ma come funziona il progetto d’insieme? Entrando nella biblioteca il visitatore può osservare ancor oggi dal corridoio centrale l’ambiente nella sua intera altezza, dal pavimento al soffitto. Ma il visitatore percepisce anche la superficie superiore dei banchi, che in una visuale fortemente scorciata assume il valore di un secondo livello su cui s’imposta l’ordine. In tal modo diviene possibile collocare le finestre a 2,50 metri da terra (ossia la quota minima consentita dalla posizione del tetto del chiostro) senza che si avverta alcuno scompenso visivo”14. Uno dei punti di maggiore interesse relativamente alla costruzione della biblioteca riguarda lo scalone che doveva colmare il dislivello tra il vestibolo e la biblioteca (il vestibolo pare fosse stato sopraelevato per volontà del papa): dalle lettere pervenute sembrerebbe che il papa desiderasse una singola rampa di scale che occupasse l’intera larghezza del vestibolo, piuttosto che uno scalone doppio, così com’era, invece, nell’idea originaria di Michelangelo15.
Le idee per lo scalone cambiarono a più riprese. Nel 1526 pare che Michelangelo si fosse orientato per una scala libera, dal momento che una scala sulla parete sarebbe stata incompatibile con il progetto di un basamento articolato, ma, a causa di mancanza di fondi, tale progetto venne ripreso soltanto nel 1533. Tra il 1533 e l’anno di fine dei lavori (1559) figura un tentativo (poi fallito), da parte di Nicolò Tribolo, di portare a termine lo scalone. Michelangelo creò, a questo proposito, un tipo di struttura che venne poi ampiamente ripresa nel Rinascimento: “Prima dello scalone del vestibolo, tutte le sale consimili del Rinascimento italiano formavano un’assoluta unità spaziale. Le scale erano sempre a ridosso delle pareti, e l’idea di uno scalone libero non si era ancora presentata. Il vestibolo della Laurenziana, affrontando una situazione del tutto nuova, si apre invece su nuove dimensioni. Questa è la prima vera sala con scalone, ed è all’origine di tutti gli analoghi ambienti del Barocco”16. Altro progetto previsto ma non realizzato fu la creazione di piccoli ambienti di studio, separati dalla biblioteca vera e propria17. La biblioteca venne inaugurata ed aperta al pubblico nel 1571.
Wittkower insiste a lungo sullo stile veramente nuovo del vestibolo, diverso tanto da quello barocco quanto da quello rinascimentale, di fatto inquadrandolo nel manierismo (dunque nel periodo compreso tra il 1520 ed il 1600), sebbene non debbano farsi, a tal proposito, distinzioni troppo nette: “La Laurenziana si pone all’inizio di un modo totalmente nuovo di intendere l’architettura. Le idee qui formulate ed elaborate oltrepassarono di gran lunga quanto gli altri architetti avevano mai osato immaginare”18.
Wittkower studia anche la progettazione della cupola di San Pietro, simbolo per eccellenza della cristianità, tra l’altro sostenendo che l’attuale cupola non corrisponda al progetto definitivo di Michelangelo, e lo fa analizzando i documenti in modo innovativo, per esempio raccogliendo tutti i pagamenti e “raggruppandoli secondo i nomi delle singole maestranze e aggiungendo la definizione del lavoro per il quale il pagamento era stato corrisposto”19. Da una lettura attenta e approfondita dei documenti viene fuori che i lavori erano stati interrotti, sia per la parte interna che per quella esterna, dal 1556 al 1561. Inoltre, risalta l’indecisione di Michelangelo tra l’idea di una cupola semisferica e quella di una struttura a sesto acuto. Infine, il progetto di Michelangelo, poi proseguito da Giacomo Della Porta, venne per certi aspetti modificato: “Le sue modifiche, per quanto sostanziali, hanno alterato ma non cancellato il progetto di Michelangelo, e noi possiamo scandagliare la profondità della mente del maestro, anche se, forse, come in uno specchio oscuro”20.
La personalità di Michelangelo viene poi ampiamente descritta con numerosi aggettivi, peraltro raramente positivi (permaloso, avaro, tormentato etc.): “La demoniaca frenesia creativa di Michelangelo; la sua facoltà pressoché unica di esprimere le proprie idee con altrettanta forza nella scultura, nella pittura e nell’architettura, e ancora nella poesia; il suo fortissimo attaccamento ai pochi amati veramente, e l’incapacità d’essere appena formalmente cortese con la gente di cui non si curava”21. Egli aveva condotto, fin da quando era giovane, una vita solitaria e moderata, di introspezione e sofferenza22.
Guardando al David (la sua celebre opera di proporzioni gigantesche, alta circa cinque metri), emerge come Michelangelo abbia fatto largo uso del trapano, soprattutto per quanto riguarda i capelli e le pupille degli occhi, così come usò tale strumento per scolpire Bacco. Anche nella sua opera per certi versi più rifinita, vale a dire la Pietà sita in San Pietro23 egli fece uso del trapano per scolpire i capelli. Tuttavia, a parere di Wittkower, Michelangelo non utilizzò più, per circa sessant’anni (1504-1564), il trapano come strumento atto a conseguire maggiore perfezione. Nei suoi disegni, come nelle sue sculture, egli sapeva rivelare la vita pulsante del corpo, dei tendini, della pelle, adoperando meglio di chiunque altro lo scalpello dentato (gradina), di fatto utilizzato come se fosse una penna sulla carta ed atto a delineare in maniera più naturale i tratti del volto, della pelle, dei muscoli24. Nessuno ha mai avuto, secondo Wittkower, una così piena padronanza del lavoro della pietra come Michelangelo: “Non vi è da meravigliarsi che molto tempo prima della sua morte Michelangelo si fosse guadagnato l’‘epiteto’ di ‘divino’ e che egli abbia esercitato sugli altri scultori, sull’intera professione degli artisti e persino sull’intera sua epoca, l’influsso più profondo”25. La sua maestria nella scultura come nella pittura era anche legata al concetto di proporzione, secondo cui un corpo o un oggetto qualsiasi appaiono più armonici e belli se le loro parti sono in qualche modo simmetriche: “Nessuno può negare che il concetto di ordine, e in particolare di ordine matematico, sia alla base della nostra conformazione psicofisica”26. Tale visione, che apparentemente può sembrare frutto della civiltà europea più matura, è rintracciabile, secondo Wittkower, anche in altre civiltà27; il problema della proporzione nasce, nel XIX secolo, dal fatto che ogni artista si è di fatto comportato come se esistesse un’unica prospettiva, sia essa ispirata alla sezione aurea o al cerchio o all’esagono.
Nel corso della storia si sono privilegiati sistemi proporzionali diversi: ad esempio, in Egitto la costruzione delle piramidi o dei templi rifletteva l’atmosfera dell’arte sacra, mentre nella polis greca si privilegiava il logos come cifra ultima dell’universo. Dalla Grecia e dal ruolo lì attribuito ...