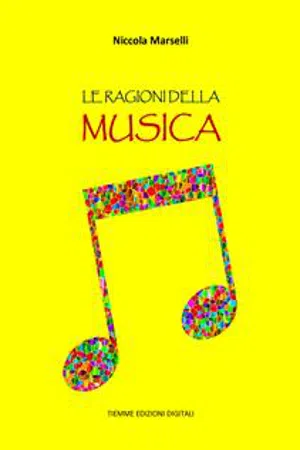
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Le ragioni della Musica
About this book
Nel 1859, alcuni decenni prima dell'avvento delle "dissonanze" novecentesche, Niccola Marselli pubblicò La ragione della Musica moderna: un ampio saggio dal quale è tratto il presente libro, che ripropone la prima parte ( La Musica ) e la seconda parte ( Svolgimento storico della Musica nell'età moderna ). In questa nuova e speciale edizione il testo è stato emendato da numerosi refusi, nonché lievemente e prudentemente attualizzato nel linguaggio formale.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Le ragioni della Musica by Niccola Marselli in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Media & Performing Arts & Music. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Subtopic
MusicIL PRESENTE DELLA MUSICA
Gli Artisti che ai dì nostri tengono lo scettro della Musica e colle loro creazioni occupano gli animi della Società vivente sono il Mercadante, il Meyerbeer e il Verdi. Il Rossini liba spensieratamente i piaceri della gloria e tace. Il sonno ch’egli dorme reca dolore all’Arte, ma forse bisogna ch’egli dorma, poiché nell’infinito Dramma dell’Arte ogni artista grande segna una forma, getta un germe e va via, lasciando una parola vivente ed insieme una tradizione che i successori feconderanno. E il germe diviene pianta, e la pianta dà vita al frutto. Così nell’Arte un nuovo elemento genera coll’andar del tempo un mondo intero. Né questo mondo posa solitario in mezzo al fermento degli elementi circostanti, ma nuovi atomi produttori vi si cacciano dentro, straniere creature vengono anche a popolarlo, e per contra dal suo terreno si sprigiona una materia che va ad arricchire gli altrui campi. Questa solidarietà artistica forma la grandezza dell’Arte, la quale, rimanendo presso ciascuna Nazione con una propria impronta, tende nientedimeno la mano alle altrui creazioni, se ne assimila quel che vi è di grande, e leva così una voce armonica che desta non questo o quel Popolo, ma l’Umanità intera. L’Arte italiana si giova dunque dell’alemanna, e questa di quella, ed insieme fecero palpitare le genti, l’una commovendo colle sue inspirate e spontanee melodie, l’altra facendo meravigliare per la sua verità drammatica e per la perizia dell’armonia. Che cosa farà il vecchio Rossini al sorgere di questo mondo novello? Presenterà di nuovo quella statua sbozzata che i suoi successori dirozzarono, e dirozzando arricchirono, modificarono, determinarono? Ed allora noi gli volgeremo le spalle, e anzi che occuparci dei vecchiumi, e provare alcune sensazioni meramente erudite, vorremo abbandonarci spontaneamente ai più giovani artisti, alle più nuove forme dell’Arte. Forse l’antico Maestro, sicuro della sua titanica forza, abbandonerà i suoi ozi, si getterà in mezzo alla mischia e scompiglierà la nuova legione usando delle armi medesime di questa? Ciò non interviene nell’Arte. L’Artista quando è grande, quando ha segnato davvero un’Era novella, non cambia stile, non usa lo scalpello dei suoi successori. Né da questo rimutamento il ritiene infantile testardaggine, ma piuttosto la natura del suo animo, il quale vede l’Arte racchiusa nella forma che egli le ha data, e rigetta ogni ulteriore svolgimento. Il Kant verso gli ultimi anni della sua vita non comprendeva le critiche degli altri pensatori. Egli stesso scriveva al Reinhold, nel 1794, che da tre anni l’età aveva reso il suo Spirito incapace di cogliere l’incatenamento e il sistema delle idee altrui. Ora se noi ci rechiamo alla memoria la grande facilità dell’ingegno del Kant, e le opere che dettò nella vecchiezza, come a dire il suo Disegno di Pace perpetua , i lavori sul Preteso diritto di mentire per l’Umanità , e sulla Rivalità delle Facoltà , le quali opere rivelano una mente vigorosa, ci accorgeremo agevolmente che quel che impediva il Kant di comprendere gli altrui pensieri, era l’essersi affatto intrinsecato col proprio Sistema. Nientedimeno egli aprì quella via che si è continuata sino all’Hegel. Ora se ciò interviene nella Scienza, la quale ha per istrumento la fredda meditazione, e quanto più non interverrà nell’Arte, in cui domina il sentimento caldo ed esclusivo? Mi si obbietterà che il Rossini ha tentata la nuova via ed ha scritto il Guglielmo Tell . Sì, ma dal Guglielmo al Dramma moderno corre un intervallo grande assai più di quel che altri non pensi. Il Rossigni dunque col ritirarsi ha dimostrato una forte conoscenza della Società e dell’Arte.
Tra le nubi dell’Alemagna si eleva il Wagner. Di questo maestro neanche parlerò, perché egli non è ancora pervenuto nella schiera degli eroi dell’Arte. Inoltre di lui non ho inteso altro che il Brautzug dell’opera Lohengrin, eseguito dall’Orchestra di strass al Giardino del Popolo ( Volksgarten) di Vienna. In questo pezzo predominava l’armonia lasciando di tempo in tempo scappar fuori un raggio di melodia. In generale si può dire che la sua Musica è realistica, intendendo sopra ogni altro a sposarsi col Dramma.
Dunque i tre grandi artisti che abbiamo nominati di sopra formeranno il soggetto delle nostre indagini, le quali saranno brevi, perché del Mercadante e del Verdi discorrerò più per esteso nel seguito. Qui è da cogliere propriamente il punto che individualizza ciascun maestro, e la relazione che corre tra essi. Nel flusso della Musica moderna saper scoprire i corifei, e tra le opere di costoro cogliere il lato rilevante, forma propriamente la difficoltà e la natura d’uno studio critico.
a) Musica classica . L’Italia tra le moderne Nazioni raccolse l’Arte siccome eredità della Grecia caduta. Se l’Alemagna fu destinata dallo Spirito del mondo a meditare il problema dell’Universo, se la Francia alla vita dell’azione, alla propaganda, se l’Inghilterra allo sviluppo dell’Industria e del Commercio, l’Italia ebbe per ufficio di nutrire il fuoco santissimo delle Arti. Ed ogni Popolo sortì natura capace a compiere l’alta deputazione, anzi la sua indole gli determinò la via da battere, la meta a conseguire. Nel cielo, nell’aura che lo circonda l’Italiano beve l’Arte, e nel suo animo temprato a caldo e vivace sentimento avviva le inspirazioni che gli desta la circostante Natura. Ogni Italiano ha i suoi Ideali, e su di questa terra pellegrina furono donne che morirono d’amore. Il fuoco del sentimento rende le individualità taglienti ed esclusive, dove che la calma della Ragione frena i moti dell’istinto, spunta in qualche modo le differenze che corrono fra i caratteri, e li rende più acconci al consorzio, all’associazione. Pertanto una Nazione artistica si rompe in parti, e le parti si guardano in cagnesco, dove che le pensatrici si fondono, e se una cagione diversa le disgrega, corrono a confederarsi in stretta lega. Così gli Stati dell’Alemagna formano una confederazione. L’Italia dopo un concitato lavorio si levò gigante e conquise l’Umanità collo splendore della Pittura e poi della Musica. Ecco il suo regno, ecco le sfere in cui ella si afferma come grande Nazione. Dunque non la Lega lombarda, ma quella degli Artisti grandi, non la sconfitta di Barbarossa, ma la vittoria compiuta sullo Spirito dell’Umanità formano la maggior gloria dell’Italia. Raffaello, Michelangelo, il Pergolese e il Rossini stampano un’orma non peritura e destano pei campi dell’etra un’eco che scuoterà le più lontane generazioni. Ora l’esclusivismo del sentimento generò le discordie, e queste produssero il fastidio del presente. Cosiffatte condizioni e un certo erudito sentimento artistico rivolsero al passato le menti italiane. Atene e Roma furono la Patria di questo Popolo di eruditi. E sino a non guari tempo si perpetuò questo movimento, anzi al presente ancora continua. L’Alfieri e il Leopardi, figliuoli del secolo, non l’intendono, lo dispregiano, e credono vivere fra le ombre adorate dei greci e romani eroi. L’Aleardi, ultima espressione della Poesia italiana, quantunque sia artista per molti rispetti moderno, nientedimeno sotto nuova forma torna a vagheggiare l’Idea latina, ed è sempre incalzato dal classico desiderio d’infarcire con obbligata mitologia il suo carme, del resto pieno di vita e di profondità. Ciò mi sconforta. Un nuovo Poeta ha l’Italia, ma la vecchia canzone non è stanca, né il vecchio uomo disparito. Accanto al naturalismo geologico io vedo errare gl’immaginari esseri ipercosmici. Forse ancora lungo tempo peneremo innanzi di renderci persuasi che il Poeta deve respirare l’aura infinita dell’Umanità e dell’universale Associazione anzi che quella angusta del Comune; che deve cantar glorie moderne meglio che ripetere nuovamente e a sazietà le avite; che bisogna parli il linguaggio delle anime nostre senza impacciar con miti il libero corso del pensiero. Certamente non vi è più nobile ufficio del cantar le patrie glorie, ma si veda una volta accanto alla Patria l’Umanità, ed insieme all’amor di sé si nutre quello alla Fratellanza universale. Dunque quasi comune a tutti gli scrittori italiani è questo anelito ad una vecchia Patria, il quale Spirito conservatore invade ogni maniera di coltura, tanto che nel Dramma noi siamo stati, e forse siamo tuttavia, più teneri di ogni altro delle tre unità. Ecco le ragioni che rendono l’Italia la terra del Classicismo. Volgiamoci alla Musica e adoperiamoci a scorgere in essa questa tendenza classica, badando che io uso questa espressione in un senso diverso dell’ordinario.
Io tengo che tra i maestri viventi il Mercadante rappresenti la Tragedia classica, anzi mi pare che nella Storia dell’Arte egli dia a questo genere l’impronta fortemente drammatica. Lo Spontini ha composto una Vestale, è vero, ma ai tempi dello Spontini la Musica non si era per anco arricchita di tutti quei mezzi che la rendono capacissima, per quanto è in lei, ad individualizzare la passione. La strumentazione della Vestale non può avere quella potenza che il Rossini, il Weber e il Meyerbeer le hanno trasfusa poi. Un Artista moderno poteva solamente dipingere le passioni eroiche della ferrea Età romana, poiché alla grande opera una ricca tavolozza si richiedeva. Dopo un tentennare tra varie forme il Mercadante trovò la sua Poesia. Alla sua forte fibra sorrise quella Roma fondata da Romolo, nel cui Spirito si agitava il Marte italiano, il quale ad altro non piegava che alla forza. Il mito della lupa parla abbastanza dei figliuoli di Roma. Il modo grave con cui il Mercadante concepisce la Musica il rese acconcio a colorire, coi mezzi della moderna Musica drammatica, l’antica Età degli Orazi e delle Vestali, ed a svolgere nell’Arte musicale il momento del Classicismo italiano. Ingegno potente e vario, egli accompagna l’Arte nel suo svolgimento, e si adagia così nella candida forma melodica, del che fa testimonio il Giuramento, come nella moderna tendenza fortemente drammatica, il che dimostra il suo Pelagio. Singolare fenomeno è questo Pelagio, il quale rivela che la canizie non ha estinto nel Mercadante la freschezza dell’inspirazione e la robustezza del concepimento. L’introduzione, la romanza del tenore ed il terzetto del Pelagio basterebbero a formare la grandezza d’un Artista. Ingegno multiforme, come il Mozart e il Rossini, egli non si tiene pago alla Tragedia, ma volge la sua varia attività alla Commedia, alla Musica sacra, alla Musica per camera, alla Musica strumentale e perfino alle Canzoncine popolari. Ed in tutto eccelle. Da questo lato il Mercadante si eleva alto sul Meyerbeer e sul Verdi, poiché questa universalità è indizio di grandezza singolare, come Aristotile stesso insegna, ed è quel che rende principi della propria Arte lo Shakespeare, il Mozart e il Rossini. Attraverso alle sue peregrinazioni l’accompagna però sempre il Genio di Roma. Sin nei motivi più spensierati voi avvertite la frase larga, degna solo di quell’Età che nel suo amplesso strinse i più lontani Popoli. L’abitudine di dipingere il Popolo sulla scena fa sì ch’egli tratti l’Individuo come il Popolo, e porga ad una passione solitaria ed intima la veste delle passioni popolari e forti. Ciò non l’impedisce però di creare spesso leggiadrissime melodie. La perizia musicale lo spinge ad amare di soverchio le complicazioni di orchestra e lo svolgimento compiuto delle frasi. In conseguenza il peso e la lunghezza fanno degenerare qualche volta in maniera il suo stile. Sempre vi si fa dinanzi il lato individuale dell’Autore. Ciò non interviene ai grandissimi, i quali scompaiono nell’opera di Arte, ovvero vivono affatto in essa. Per sforzi che facciate voi non saprete mai quale sia l’intimo, il carattere soggettivo dello Shakespeare. Voi avete dinanzi Giulio Cesare, Otello, Riccardo, Amleto, Macbeth, Giulietta e Romeo, Falstaff, ma non vedete mai l’Autore che fa capolino, dietro l’opera di Arte. Al contrario nella Violetta del Mercadante scorgete l’autore degli Orazi. Però è l’Arte che va verso di lui, ma non è lui che si modifica secondo i soggetti artistici, e il Mercadante è grande perché ha trovato una poesia che ha fatto diventar stile vero e bello la sua maniera individuale.
A difesa del Mercadante dobbiamo soggiungere che questo rilievo soverchio della propria individualità è natura degl’Italiani, ed è una conseguenza necessaria delle nostre condizioni. Dante stesso non se ne preservò. L’Alfieri ha composto alcune Liriche in cinque Atti. Tutti i personaggi rivelano l’animo maschio dell’Autore. Tanto colui che ama quanto quegli che odia non hanno che un solo accento, la bestemmia contro il nemico dei propri amori e contro la cagione dell’odio. Ciascuno vuol dominar solo, non sopporta ostacoli, e per necessità dev’entrare in lotta cogli altri, i quali alla lor volta non sono uomini socievoli. Mettete Alfieri contro Alfieri e voi avrete che l’uno si precipiterà furioso sulla spada dell’altro. Due Alfieri sarebbero stati nemici fra loro; e difatti egli bestemmiava quella Rivoluzione francese di cui era figliolo primogenito. A questo modo la Tragedia è finita al 1° Atto, poiché i caratteri si pongono con tanta ruvidezza che si distruggono in pari tempo. Nientedimeno vi sono ancora quattro atti da percorrere. Che resta all’Autore? Tener modo che i personaggi disfoghino la loro ira in ingiurie sempre nuove, sempre più pungenti, sino a quando dalle contumelie si passa al brando. Indi il difetto di azione, e da ciò le tre unità. Noi leggiamo Alfieri con amore perché egli adagia le proprie passioni in un’età e su di alcuni eroi che sopportano il duro peso, ma se egli avesse dovuto tragediare Giulietta e Romeo, la Francesca da Rimini, la Pia dei Tolomei, allora non si potrebbe resistere allo sconcio di vedere la modesta Pia coll’elmo e col coturno romano. Con minor durezza incontra lo stesso al Mercadante.
E ciò è ben naturale. Gli Italiani sono un aggregato d’Individui. Divisi dalla vita politica ed esteriore si compongono un mondo tutto proprio; tanto che la Scienza, le credenze politiche e religiose sono sistemi individuali, il grido di una coscienza separata dal mondo. I nostri riformatori religiosi parlano a se stessi o ai pochi, dove che gli Alemanni traducono nella vita dello Stato i loro pensamenti. Il Bruno apre la via alla Scienza moderna, ma per gl’Italiani il suo Panteismo è consunto dal rogo che incenerì l’ardito novatore, dove che i Tedeschi ne svegliano le scintille, lo fecondano e lo bevono largamente. Il Vico è pianta esotica sul suolo napoletano. Ora se il consorzio genera la pieghevolezza, l’individualismo produce la rigidezza; se l’associazione fa sì che nelle opere di ciascuno s’infiltrino gli elementi estranei, tanto che s’imitino sino gli altrui modi, d’altra banda l’austera solitudine di necessità opera che noi portiamo in tutto quel che facciamo noi stessi, i nostri capricci, il mondo che ci siam formato, la nostra soggettività. Per cui l’Inglese, l’Alemanno come lo Shakespeare e il Goethe possono meditare lungamente il soggetto, e sottoporre se all’Arte, ma il caldo sentimento italiano, la dura forza individuale imprime la propria orma sul soggetto. L’artista moderno in generale, a causa della forza individuale invigorita nella nostra Società dalla Cavalleria, dalle Scoperte, dalla Scienza, dai Viaggi, dal Commercio, dall’Industria e simili, reca nelle sue opere la propria individualità, a differenza dei Greci che vivevano nel petto di Prometeo, di Edipo, di Antigone, ecc. Il freddo Goethe, capace di dipingere insieme l’incomposta passione di Werther e l’affetto ritenuto e vorrei dire diplomatico di Claviio, la candida Margherita e lo scettico Faust, Mefistofele e Marianna, lascia scappar fuori senza volerlo la propria natura. Wolfgang è tutto nella prima scena del Fausto. Così lo Schiller parla per mezzo del Marchese di Posa, e il Lirismo non scarseggia nella sua Drammatica. Il Byron è Caino, Don Giovanni, il Corsaro, ecc. Nel Teatro francese, salvo alcune eccezioni che s’incontrano soprattutto nel Corneille, troviamo questo Lirismo disceso ad una bassezza antiartistica, poiché i suoi tragici coprono gli eroi di Roma colle parrucche incipriate dei tempi di Richelieu, Mazzarino e Luigi XIV. Solo Shakespeare si leva gigante su di tutti e sommerge il suo animo in Roma, nell’Inghilterra, in Italia. Ora questo carattere, comune agli artisti moderni, signoreggia di più appresso gl’Italiani. Tra i moderni oltre all’Alfieri è da por mente al Foscolo ed al Manzoni siccome gli artisti che non nella Lirica ma nel Romanzo lasciano leggere tutta l’anima loro. La sdegnosa e superba natura del Foscolo è trasfusa nell’ Ortis, come il candore del Manzoni fonde in un’unità di amore le creature che popolano il suo Romanzo. Tutte hanno il cuore temprato a carità cristiana, e chi non l’ha si converte. Il Lirismo dunque si muove in fondo all’Arte moderna.
Rivolgendomi alla Musica dico che l’anima beffarda del Rossini penetra in tutte le sue Opere. Il Rossini al pari del Goethe compone con fronte serena e col fuoco alle mani, di sorta che tu vedi muovere sulla scena alcune bellissime ombre, ma quasi mai una viva creatura vittima della passione traboccante. L’anima sua non perde mai la serenità, tanto che egli crea uno Sta...
Table of contents
- Copertina
- LE RAGIONI DELLA MUSICA
- Indice
- Intro
- Prologo
- Introduzione
- LA MUSICA
- SVOLGIMENTO STORICO DELLA MUSICA NELL’ETÀ MODERNA
- IL PASSATO DELLA MUSICA
- IL PRESENTE DELLA MUSICA
- L’AVVENIRE DELLA MUSICA
- Ringraziamenti