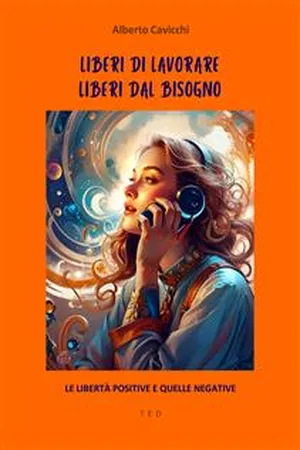Le due definizioni di sostenibilità
Dal punto di vista dell’analisi
economica e sociale è necessario distinguere due tipi di
sostenibilità dello stato sociale:
- l’economica;
- la politica.
Per comprendere al meglio queste
due definizioni e valutarne la rilevanza per il nostro Paese è
necessario porsi due domande che dovrebbero indirizzare i
comportamenti dei nostri amministratori pubblici e dei nostri
politici, i quali sono i veri artefici delle misure di politica
economica inerente alla spesa per il finanziamento dello Stato
sociale.
La sostenibilità economica
La sostenibilità economica è tale
quando assicura l’equilibrio nella gestione delle risorse, ovvero
quando esista un corretto bilanciamento tra costi e benefici, tra
entrate e uscite e tra tasse prelevate al contribuente e spese
effettuate per soddisfare i bisogni dei cittadini. Qualora ciò
avvenga è presumibile che la decisione di politica economica
assicuri la migliore allocazione delle risorse pubbliche, ovvero
permetta di perseguire il miglior risultato possibile, comprimendo
allo stesso tempo gli sprechi e le rendite monopolistiche. Qualora
però la decisione assunta non sia nemmeno sostenibile
economicamente dobbiamo concludere che lo stato sta distruggendo
ricchezza, in quanto l’utilizzo delle risorse disponibili è
errato.
La sostenibilità politica
La sostenibilità politica esiste se
c’è un consenso sociale basato su regole etiche che influenzino la
distribuzione di oneri e benefici. Perciò là dove s’intenda tenere
conto e, quindi, risolvere le difficoltà intrinseche nei meccanismi
delle scelte collettive non deve esistere collusione di gruppi
rappresentanti interessi particolaristici. Diversamente, se le
decisioni non sono ispirata a questi principi fondamentali del
“contratto sociale” la politica non sarà in grado di rispondere ai
bisogni delle parti più deboli della società (principio
solidaristico) né tantomeno alle aspirazioni delle parti più
generose e nobili della società (principio di equità).
È auspicabile che il sostegno al
reddito sia offerto alle famiglie che ospitano inabili al lavoro,
disoccupati temporanei o malati privi di assistenza sanitaria.
Qualora però lo stato non abbia capacità di supporto politico cosa
si può fare? Intanto è bene ricordare che la teoria economica
sancisce un principio fondamentale: la diretta corrispondenza tra
il consenso politico e l’equilibrata distribuzione di costi e
benefici tra cittadini. Facciamo un esempio: lo stato può decidere
di finanziare, con accise straordinarie sui carburanti, una
missione di pace dei nostri militari all’estero richiamandosi al
principio di utilizzazione razionale e parsimoniosa delle risorse
finanziarie.
Orbene, mentre i cattivi
amministratori pubblici non sono in grado di rispondere in modo
convincente né alla sostenibilità economica né a quella politica,
quelli capaci sono, invece, in grado di individuare tempestivamente
e con chiarezza le soluzioni sostenibili economicamente e
politicamente. In sintesi possiamo dire che, lo stato sociale è
sostenibile fino a quando i cittadini lo sopportano.
Il punto fondamentale è tuttavia il
saper riconoscere il punto critico del fallimento economico dello
stato, oltrepassato il quale lo stato sociale non è più in grado di
sostenersi economicamente, ovvero fino a quando il mercato si
oppone al finanziamento di una situazione di grave inefficienza
economica (crisi del debito sovrano). Per fare un esempio, potremmo
dire che l’insostenibilità economica dello stato sociale ha la
stessa dinamica prevista dal Codice Civile nei confronti di un
imprenditore, il quale viene considerato insolvente quando sia
acclarato che è in stato d’insolvenza, ovvero non più in grado di
far fronte con regolarità ai propri obblighi verso terzi. Per lo
stato questo punto critico viene raggiunto quando il bilancio
pubblico, con il quale è finanziato lo stato sociale, non è più
sostenibile.
La condizione di sostenibilità
tecnica del bilancio pubblico, necessaria ad evitare l’aumento del
rapporto debito/Pil, è garantita solo fino a quando il tasso
d’interesse reale sul debito non supera il tasso di crescita
dell’economia reale, aumentato del rapporto tra l’avanzo primario e
la consistenza del debito pubblico. Ebbene questa condizione è
stata (ed è) sistematicamente violata dall’Italia e ciò indica che
il tasso di crescita della nostra economia è stato (ed è anche
oggi) troppo basso per potersi permettere uno stato sociale
adeguato ai bisogni, oppure, in alternativa, che il deficit
corrente ha innalzato (e sta innalzano ulteriormente) i livelli dei
tassi d’interesse rendendoli superiori ai livelli dell’economia
reale. Dalle nostre previsioni emerge inoltre che questo trend
proseguirà anche nei prossimi anni, rendendo sempre più improbabile
la sostenibilità economica del bilancio dello stato.
Con una crescita economica
praticamente nulla se non addirittura negativa è certo che crescerà
ulteriormente il costo reale del debito, cioè quello dei tassi
d’interesse, i quali, a loro volta, spingeranno in alto il rapporto
debito/Pil. C’è un rimedio che possa rendere economicamente
sostenibile il bilancio pubblico? Nonostante la complessità una
soluzione esiste: intervenire - come hanno suggerito i governi dei
paesi sviluppati e gli organismi monetari internazionali - sul lato
della spesa (taglio delle uscite di parte corrente), anziché su
quello delle entrate (aumento della pressione fiscale).
D’altronde, la ricerca economica ha
già rilevato che, a parità di dimensione dell’intervento, in tutti
i paesi industrializzati la riduzione della spesa pubblica è più
efficace dell’aumento delle entrate. Del resto, inasprire il peso
fiscale al fine di mantenere identica l’attuale spesa sociale per
sanità e pensioni aumenterebbe l’inefficienza dello stato sociale,
favorendo le rendite di posizione per pochi privilegiati e
aumentando le spese a danno dell’intera collettività. Al fine di
evitare questo esito nefasto è necessario dare impulso alla
sostenibilità politica dello stato sociale, chiedendo alla politica
di decidere su quali spese intervenire, in che misura e adottando
quali principi etici.
Le anomalie dello stato sociale italiano
Che il sistema previdenziale
pubblico italiano sia soggetto a squilibri, per effetto
dell’invecchiamento della popolazione (fenomeno condiviso con altri
paesi europei sviluppati) è fatto noto e consolidato che dà origine
a effetti incontrollati i quali trasferiscono gli oneri sulle
spalle delle generazioni future.
È altrettanto vero che -
diversamente dagli altri paesi europei - il sistema italiano è
fortemente carente sotto il duplice profilo dell’equità orizzontale
(tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti) e di quella
verticale (tra i livelli retributivi bassi e alti e fra le carriere
lente e veloci). È noto pure che in Italia esiste un effetto
negativo sull’efficienza economica complessiva causato dalla
redistribuzione iniqua delle risorse tra lavoratori attivi
(occupati) e inattivi (disoccupati e pensionati).
Questi esiti negativi hanno due
cause:
- provocano un effetto imitazione
(per esempio, la corsa ai prepensionamenti, che nel medio temine
impoveriscono la qualità della forza lavoro e generano inflazione
da costi);
- concentra il potere d’acquisto
nelle mani di coloro che hanno uno stile di vita particolare
(domanda sempre uguale nel tempo di panieri di beni e servizi a
costi crescenti che genera inflazione da domanda).
Inoltre, gli effetti perversi del
sistema pensionistico italiano sono individuabili in:
- un elevato grado di copertura
della pensione rispetto alla retribuzione; motivo del soffocamento
della crescita del sistema previdenziale integrativo privato che si
riflette nell’inefficienza nei mercati finanziari e in più alti
tassi d’interesse;
- un utilizzo improprio dello
strumento previdenziale, utilizzato per finalità solidaristiche (il
reddito pensionistico serve a garantire il reddito familiare,
ovvero a funzionare da ammortizzatore sociale a difesa dei
disoccupati temporanei, dei minori e delle ragazze-madri).
In entrambi i casi si crea
inefficienza che, a sua volta, rende meno produttivo e competitivo
nel tempo il sistema economico italiano, rendendolo più fragile di
quello degli altri paesi europei. Per questo motivo è oggi
difficile definire scenari di lungo periodo, soprattutto per quanto
concerne l’evoluzione dell’economia e del sistema pensionistico
italiani.
Al fine di giustificare questa
nostra affermazione è bene concentrare l’attenzione su un esempio
teoricamente estremizzato. Supponiamo di trovarci in un’economia
nella quale non vi sia un sistema pensionistico. Presumiamo,
quindi, che la popolazione sia tutta attiva (interamente occupata),
che il tasso di crescita sia positivo e il sistema economico sia
pienamente diversificato fra agricoltura industria e terziario. Se
in questo contesto trovasse spazio un beneficio pensionistico,
godibile a ogni età, generalizzato e pari al livello di sussistenza
alimentare, potremmo avere uno spostamento di una parte della
popolazione attiva (occupati) verso quella passiva (disoccupati e
pensionati).
Come conseguenza avremmo che:
- il settore agro-alimentare
assorbirebbe forza lavoro a costi crescenti, data la possibilità
limitata di incrementare la produttività;
- il settore industriale
regredirebbe per carenza di domanda (consideriamo per comodità che
i pensionati acquistino solo beni alimentari).
A questo punto c’è da chiedersi
quale sarebbe la situazione di equilibrio del sistema? Sarebbe
quella nella quale una frazione residua di lavoratori produrrebbe
il fabbisogno alimentare per tutta la popolazione attiva (occupati)
e inattiva (disoccupati e pensionati). La frazione di lavoratori
dipenderebbe ovviamente dalla produttività combinata della terra e
di chi la lavora.
In ogni caso, il tasso di crescita
dell’economia tenderà a zero, poiché il livello della produzione
agro-alimentare rimarrà praticamente costante, in quanto i consumi
delle persone resteranno invariati. Mentre il settore industriale
scomparirà completamente. Quando poi anche tutta la terra
disponibile sarà stata utilizzata anche il tasso complessivo
dell’economia tenderà a zero, in quanto rimarrà solo il settore
agricolo residuale.
Infine, qualora i lavoratori del
settore alimentare fossero sindacalizzati sarebbe possibile
attendersi un’inflazione continua generata dalla crescita
salariale. La quale tenderebbe invano ad adeguare il potere
d’acquisto dei lavoratori attivi rispetto a quelli inattivi.
Infatti, in termini reali, il valore aggiunto, in quota costante,
prodotto dai lavoratori sarebbe destinato quasi tutto a loro
stessi, mentre una parte marginale andrebbe a sostenere gli
inattivi.
Per quanto ipotetico l’esempio
riportato in precedenza formula le tre principali anomalie prodotte
dall’attuale legislazione pensionistica italiana:
- consentendo il pensionamento
anticipato rispetto all’età anagraficamente genera - per effetto
dell’aumento dei costi di produzione - un’inflazione superiore a
quella media degli altri paesi europei sviluppati;
- ampliando la quota di inattivi -
per effetto della riduzione del reddito disponibile e della domanda
- deprime il tasso di crescita dell’economia rispetto alla media
degli altri paesi europei sviluppati;
- spostando la domanda complessiva
verso i beni e servizi primari, aumenta il potere monopolistico di
chi produce, contrae la diversificazione competitiva, chiude alle
esportazioni, diminuisce la spinta all’innovazione tecnologica e
riduce il tasso di crescita della produttività, rispetto alla media
dei paesi europei avanzati.
Come già accade da tempo in altri
paesi europei sviluppati, l’Italia deve ripristinare le condizioni
affinché lo stato sociale, oltreché strumento di equità
redistributiva e solidaristica, divenga anche motore della crescita
e dello sviluppo.
Lo stato sociale italiano
Gli scenari
La spesa per prestazioni sociali in
Italia comprendente la previdenza, l’assistenza e la sanità supera
il 20% del Pil e rappresenta più di un terzo dell’intera spesa
pubblica. Questi dati sono variati nel tempo e si prevedono in
ulteriore crescita nei prossimi anni. Le voci più importanti dello
Stato sociale italiano sono:
- l’Istruzione;
- la Sanità;
- la Previdenza;
- l’Assistenza.
Il volume della spesa per lo stato
sociale italiano è sostanzialmente in linea con quelli degli altri
paesi europei, sebbene la nostra spesa pensionistica sia
percentualmente più alta della media europea. Quel che cambia è la
sua composizione. In certe nazioni il reddito previdenziale
pubblico è minore di quello italiano, mentre sono maggiori le
agevolazioni e la qualità dei servizi.
L’anticipazione pensionistica per
gli insegnanti, il prepensionamento dei lavoratori dei settori
industriali in declino, la politica sociale attraverso il basso
canone degli affitti e il basso rendimento degli immobili abitativi
di proprietà degli Enti pubblici sono da considerare provvedimenti
previdenziali o assistenziali? Occorre, inoltre, tenere conto
dell’imposizione fiscale sul reddito e, quindi, dell’intera
struttura dell’intervento pubblico poiché, ad esempio, è assai
originale che in Italia, rispetto ad altri paesi sviluppati, gravi
sullo stato sociale il costo dell’organizzazione pubblica
dell’istruzione scolastica.
Passando all’esame del settore
previdenziale c’è da rilevare che la spesa pensionistica italiana è
ancora più alta di quella degli altri maggiori paesi europei. Così
come il tasso di dipendenza degli anziani sulla popolazione attiva
(coloro che hanno superato i 65 anni in relazione a coloro che
stanno nella fascia 15-65 anni)) è anch’esso superiore a quello
medio europeo. Inoltre va sottolineato che in Italia il rapporto
fra soggetti contributivi e soggetti beneficiari è il più basso tra
i maggiori paesi sviluppati. Ciò significa che i pensionati
italiani sugli attivi sono quasi il doppio di quanto si rileva nei
maggiori paesi europei.
Inoltre l’aliquota di equilibrio
(il tasso di contribuzione, inclusi i trasferimenti di bilancio,
rapportato alla massa retributiva che consente di mantenere in
costante equilibrio finanziario) è la più alta tra quelle dei paesi
analizzati dal Fondo Monetario Internazionale. Ciò significa che il
nostro cuneo previdenziale implicito sui redditi è di almeno un
quinto superiore a quello dei maggiori paesi della UE.
Le simulazioni effettuate dalla
nostra Ragioneria Generale e dal Fondo Monetario Internazionale
(utilizzando scenari demografici differenti: maggiore o minore
fertilità e mortalità e maggiore o minore flusso d’immigrazione)
giungono alla conclusione che entro il 2050 la popolazione italiana
si ridurrà dagli attuali 60 milioni di persone a meno di 50.
Qualora questo fosse l’andamento demografico il nostro sistema
previdenziale - a legislatura vigente - registrerebbe entro il 2045
una spesa pensionistica in rapporto al Pil di oltre il 20%. In
questo scenario, il tasso di dipendenza degli anziani dai
lavorativi attivi salirebbe, entro il 2050, al 60%, mentre il
rapporto contributori/beneficiari scenderebbe allo 0,7, ovvero 1,4
pensionati per ogni lavoratore attivo. Ciò significa che per quella
data gli anziani (superiori ai 65 anni) saranno più di 30 milioni.
Questa ipotesi porterebbe a un radicale cambiamento strutturale
della vita sociale, dell’organizzazione urbana, dei servizi sociali
e dei bisogni dei cittadini.
Queste simulazioni contengono anche
ipotesi di produttività esogena e crescente (la quale però non è
stata ancora realizzata) e non è detto che si stabilizzi al
2,4-2,8% tra il 2045 e il 2050. Del resto, chi può dire ora se nel
2045 il 40% della popolazione attiva manterrà un ritmo di piena
efficienza, con aumenti di produttività prossimi a quelli del boom
economico degli anni Sessanta o se, invece, si attesterà sui ritmi
di crescita della società dei servizi (post-industriale) degli anni
Novanta.
Qualora analizzassimo meglio le
proiezioni del Fondo Monetario Internazionale i risultati sarebbero
ancor più preoccupanti. Tra il 2045 e il 2050 la spesa
previdenziale italiana in rapporto al Pil potrebbe essere quasi
doppia di quella tedesca, il 15% più alta di quella francese e il
90% di quella inglese. Inoltre negli altri maggiori paesi europei
vi sarebbe una minore dipendenza degli anziani sui lavoratori
attivi e un maggior rapporto contributori/beneficiari, visto che in
questi paesi il trend demografico è più favorevole. Questi dati si
riflettono sull’aliquota d’equilibrio, cioè su quella di
contribuzione, la quale permetterebbe di raggiungere, in termini
attuariali, l’equilibrio finanziario del sistema italiano sarebbe
nel periodo 2045-2050 del 60%, mentre in Germania e Francia non
supererebbe il 40% e in Inghilterra si attesterebbe attorno al
5%.
Osservando questi dati emergono
chiaramente due fattori negativi:
- la portata dell’implicito effetto
redistributivo fra generazioni - ancora presente nell’attuale
legislazione italiana - rispetto agli altri paesi;
- lo stentato sviluppo in Italia
dei fondi pensione integrativi.
Due altri dati vanno, inoltre,
tenuti in considerazione:
- il rapporto pensione
media/reddito pro-capite sta crescendo;
- il meccanismo previdenziale
italiano, rispetto a quelli degli altri paesi europei, è più
sensibile ai mutamenti dello scenario economico e
istituzionale.
Riprendendo i dati del Fondo
Monetario Internazionale rileviamo che per stabilizzare, nel 2050,
il nostro sistema previdenziale (in presenza di una bassa crescita
del Pil) lo stato dovrebbe richiedere maggiori risorse
contributive, mentre Germania, Francia e Gran Bretagna ne
abbisognerebbero di meno. In ogni caso, diversamente dall’Italia,
nei maggiori paesi europei la diminuzione della crescita avrebbe
conseguenze negative generalizzate e graverebbe perciò tanto sui
lavoratori attivi che sui pensionati. C’è infine da rilevare che la
rigidità relativa alle variazioni strutturali del nostro sistema
pensionistico è rivelato dal fatto che quello italiano è meno
sensibile (rispetto a Germania, Francia e Gran Bretagna) alle
modifiche delle regole di indicizzazione dei prezzi al consumo e
più sensibile all’innalzamento dell’età pensionabile.