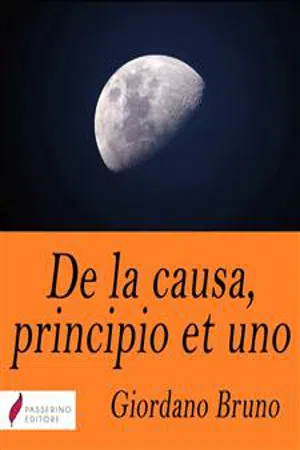Gervasio . È pur gionta l’ora, e costoro non son venuti. Poi che non ho altro pensiero che mi tire, voglio prender spasso di udir raggionar costoro, da’ quali oltre che posso imparar qualche tratto di scacco di filosofia, ho pur un bel passatempo circa que’ grilli che ballano in quel cervello eteroclito di Polihimnio pedante. Il quale, mentre dice che vuol giudicar chi dice bene, chi discorre meglio, chi fa delle incongruità ed errori in filosofia, quando poi è tempo de dir la sua parte, e non sapendo che porgere, viene a sfilzarti da dentro il manico della sua ventosa pedantaria una insalatina di proverbiuzzi, di frase per latino o greco, che non fanno mai a proposito di quel ch’altri dicono: onde, senza troppa difficultà, non è cieco che non possa vedere quanto lui sia pazzo per lettera, mentre degli altri son savii per volgare. Or eccolo in fede mia, come sen viene che par che nel movere di passi ancora sappia caminar per lettera. Ben venga il dominus magister .
Polihimnio. Quel magister non mi cale: poscia che in questa devia ed enorme etade, viene attribuito non piú ai miei pari che ad qualsivoglia barbitonsore, cerdone e castrator di porci, però ne vien consultato: nolite vocari Rabi.
Gervasio. Come dunque volete ch’io vi dica? Piacevi il reverendissimo?
Polihimnio. Illud est presbiterale et clericum.
Gervasio. Vi vien voglia de l’illustrissimo?
Polihimnio. Cedant arma togae: questo è da equestri eziandio, come da purpurati.
Gervasio. La maestà cesarea, anh?
Polihimnio. Quae Caesaris Caesari.
Gervasio. Prendetevi dunque il domine, deh! , toglietevi il gravitonante, il divum pater!... — Venemo a noi; perché siete tutti cossí tardi?
Polihimnio. Cossí credo che gli altri sono impliciti in qualche altro affare, come io, per non tralasciar questo giorno senza linea, sono versato circa la contemplazion del tipo del globo detto volgarmente il mappamondo.
Gervasio. Che avete a far col mappamondo?
Polihimnio. Contemplo le parti de la terra, climi, provinze e regioni; de quali tutte ho trascorse con l’ideal raggione, molte cogli passi ancora.
Gervasio. Vorei che discorressi alquanto dentro di te medesmo; perché questo mi par che piú te importi, e di questo credo che manco ti curi.
Polihimnio. Absit verbo invidia; perché con questo molto piú efficacemente vengo a conoscere me medesmo.
Gervasio. E come mel persuaderai?
Polihimnio. Per quel che dalla contemplazione del megacosmo facilmente, necessaria deductione facta a simili, si può pervenire alla cognizione del microcosmo, di cui le particole alle parti di quello corrispondeno.
Gervasio. Sí che trovaremo dentro voi la Luna, il Mercurio e altri astri? la Francia, la Spagna, l’Italia, l’Inghilterra, il Calicutto e altri paesi?
Polihimnio. Quidni? per quamdam analogiam.
Gervasio. Per quamdam analogiam io credo che siate un gran monarca; ma, se fuste una donna, vi dimandarei se vi è per alloggiare un putello, o di porvi in conserva una di quelle piante che disse Diogene.
Polihimnio. Ah, ah, quodanmodo facete. Ma questa petizione non quadra ad un savio ed erudito.
Gervasio. S’io fusse erudito, e mi istimasse savio, non verrei qua ad imparar insieme con voi.
Polihimnio. Voi sí, ma io non vegno per imparare, perché nunc meum est docere; mea quoque interest eos qui docere volunt iudicare; però vegno per altro fine che per quel che dovete voi venire, a cui conviene l’essere tirone, isagogico e discepolo.
Gervasio. Per qual fine?
Polihimnio. Per giudicare dico.
Gervasio. Invero, a’ pari vostri piú che ad altri sta bene di far giudicio de le scienze e dottrine; perché voi siete que’ soli a’ quali la liberalità de le stelle e la munificenza del fato ha conceduto il poter trarre il succhio da le paroli.
Polihimnio. E consequentemente dai sensi ancora i quali sono congionti alle paroli.
Gervasio. Come al corpo l’anima.
Polihimnio. Le qual paroli, essendo ben comprese, fanno ben considerar ancor il senso: però dalla cognizion de le lingue (nelle quali io, piú che altro che sia in questa città, sono exercitato e non mi stimo men dotto di qualunque sia che tegna ludo di Minerva aperto) procede la cognizione di scienza qualsivoglia.
Gervasio. Dunque, tutti que’ che intendeno la lingua italiana, comprenderanno la filosofia del Nolano?
Polihimnio. Sí, ma vi bisogna anco qualch’altra prattica e giudizio.
Gervasio. Alcun tempo io pensava che questa prattica fusse il principale; perché un che non sa greco, può intender tutto il senso d’Aristotele e conoscere molti errori in quello, come apertamente si vede che questa idolatria, che versava circa l’autorità di quel filosofo (quanto a le cose naturali principalmente), è a fatto abolita appresso tutti che comprendeno i sensi che apporta questa altra setta; ed uno che non sa né di greco, né di arabico, e forse né di latino, come il Paracelso, può aver meglio conosciuta la natura di medicamenti e medicina che Galeno, Avicenna e tutti che si fanno udir con la lingua romana. Le filosofie e leggi non vanno in perdizione per penuria d’interpreti di paroli, ma di que’ che profondano ne’ sentimenti.
Polihimnio. Cossí dunque vieni a computar un par mio nel numero della stolta mo[l]titudine?
Gervasio. Non vogliano gli Dei, perché so che con la cognizione e studio de le lingue (il che è una cosa rara e singulare) non sol voi, ma tutti vostri pari sete valorosissimi circa il far giudicio delle dottrine, dopo aver crivellati i sentimenti di color che ne si fanno in campo.
Polihimnio. Perché voi dite il verissimo, facilmente posso persuadermi che non lo dite senza raggione: per tanto, come non vi è difficile, non vi fia grave di apportarla.
Gervasio. Dirò (referendomi pur sempre alla censura de la prudenza e letteratura vostra)[:] è proverbio comune che quei che son fuor del gioco, ne intendeno piú che quei che vi son dentro; come que’ che sono nel spettacolo, possono meglio giudicar de li atti, che quelli personaggi che sono in scena; e della musica può far meglior saggio un che non è de la capella o del conserto; similmente appare nel gioco de le carte, scacchi, scrima ed altri simili. Cossí voi altri signor pedanti, per esser esclusi e fuor d’ogni atto di scienza e filosofia, e per non aver, e giamai aver avuto participazione con Aristotele, Platone et altri simili, possete meglio giudicarli e condannar con la vostra sufficienza grammatticale e presunzion del vostro naturale, che il Nolano che si ritrova nel medesmo teatro, nella medesma familiarità e domestichezza, tanto che facilmente le combatte dopo aver conosciuti i loro interiori e piú profondi sentimenti. Voi dico per esser extra ogni profession di galantuomini e pelegrini ingegni, meglio le possete giudicare.
Polihimnio. Io non saprei cossí di repente rispondere a questo impudentissimo. Vox faucibus haesit.
Gervasio. Però i pari vostri sono sí presuntuosi, come non son gli altri che vi hanno il piè dentro; e pertanto io vi assicuro, che degnamente vi usurpate l’ufficio di approvar questo, riprovar quello, glosar quell’altro, far qua una concordia e collazione, là una appendice.
Polihimnio. Questo ignorantissimo, da quel che io son perito nelle buone lettere umane, vuol inferir che sono ignorante in filosofia.
Gervasio. Dottissimo, messer Polihimnio; io vo’ dire che, se voi aveste tutte le lingue, che son (come dicono i nostri predicatori) settantadue —
Polihimnio. — Cum dimidia.
Gervasio. — per questo non solamente non siegue che siate atto a far giudizio di filosofi, ma oltre non potreste togliere di essere il piú gran goffo animale che viva in viso umano: e anco non è che impedisca che uno ch’abbia a pena una de le lingue, ancor bastarda, sia il piú sapiente e dotto di tutto il mondo. Or considerate quel profitto ch’han fatto doi cotali, de’ quali è un francese arcipedante, c’ha fatte le Scole sopra le arte liberali e l’Animadversioni contra Aristotele; e un altro sterco di pedanti, italiano, che ha imbrattati tanti quinterni con le sue Discussioni peripatetiche. Facilmente ognun vede ch’il primo molto eloquentemente mostra esser poco savio; il secondo, semplicemente parlando, mostra aver molto del bestiale e asino. Del primo possiamo pur dire che intese Aristotele; ma che l’intese male; e se l’avesse inteso bene, arebbe forse avuto ingegno di far onorata guerra contra lui, come ha fatto il giudiciosissimo Telesio consentino. Del secondo non possiamo dir che l’abbia inteso né male né bene; ma che l’abbia letto e riletto, cucito, scucito e conferito con mill’altri greci autori, amici e nemici di quello; e al fine fatta una grandissima fatica, non solo senza profitto alcuno, ma etiam con un grandissimo sprofitto, di sorte che chi vuol vedere in quanta pazzia e presuntuosa vanità può precipitar e profondare un abito pedantesco, veda quel sol libro, prima che se ne perda la somenza. Ma ecco presenti il Teofilo col Dicsono Arelio.
Polihimnio. Adeste felices, domini. La presenzia vostra è causa che la mia excandescenzia non venga ad exaggerar fulminee sentenze contra i vani propositi c’ha tenuti questo garrulo frugiperda.
Gervasio. Ed a me tolta materia di giocarmi circa la maestà di questo reverendissimo gufo.
Dicsono Arelio. Ogni cosa va bene se non v’adirate.
Gervasio. Io, quel che dico, lo dico con gioco, perché amo il signor maestro.
Polihimnio. Ego quoque quod irascor, non serio irascor, quia Gervasium non odi.
Dicsono Arelio. Bene: dunque, lasciatemi discorrer con Teofilo.
Teofilo. Democrito dunque e gli epicurei, i quali, quel che non è corpo, dicono esser nulla, per conseguenza vogliono la materia sola essere la sustanza de le cose; ed anco quella essere la natura divina, come disse un certo arabo, chiamato Avicebron, come mostra in un libro intitolato Fonte di vita. Questi medesmi, insieme con cirenaici, cinici e stoici, vogliono le forme non essere altro che certe accidentali disposizioni de la materia. E io molto tempo son stato assai aderente a questo parere, solo per questo che ha fondamenti piú corrispondenti alla natura che quei di Aristotele; ma, dopo aver piú maturamente considerato, avendo risguardo a piú cose, troviamo che è necessario conoscere nella natura doi geni di sustanza, l’uno che è forma e l’altro che è materia; perché è necessario che sia un atto sustanzialissimo, nel quale è la potenza attiva di tutto, ed ancora una potenza e un soggetto nel quale non sia minor potenza passiva di tutto: in quello è potestà di fare, in questo è potestà di esser fatto.
Dicsono Arelio. È cosa manifesta ad ognuno che ben misura, che non è possibile che quello sempre possa far il tutto senza che sempre sia chi può esser fatto il tutto. Come l’anima del mondo (dico ogni forma), la quale è individua, può essere figuratrice, senza il soggetto delle dimensioni o quantità, che è la materia? E la materia come può essere figurata? Forse da se stessa? Appare che potremo dire, che la materia vien figurata da se stessa, se noi vogliamo considerar l’universo corpo formato esser materia, chiamarlo materia; come un animale, con tutte le sue facultà, chiamaremo materia, distinguendolo, non da la forma, ma dal solo efficiente.
Teofilo. Nessuno vi può impedire che non vi serviate del nome di materia secondo il vostro modo, come a molte sette ha medesmamente raggione di molte significazioni. Ma questo modo di considerar che voi dite, so che no’ potrà star bene se non a un mecanico o medico che sta su la prattica, come a colui che divide l’universo corpo in mercurio, sale e solfro; il che dire non tanto viene a mostrar un divino ingegno di medico quanto potrebe mostrare un stoltissimo che volesse chiamarsi filosofo; il cui fine non è de venir solo a quella distinzion di principii, che fisicamente si fa per la separazione che procede dalla virtú del fuoco, ma anco a quella distinzion de principii, alla quale non arriva efficiente alcuno materiale, perché l’anima, inseparabile dal solfro, dal mercurio e dal sale, è principio formale; quale non è soggetto a qualità materiali, ma è al tutto signor della materia, non è tocco dall’opra di chimici la cui divisione si termina alle tre dette cose, e che conoscono un’altra specie d’anima che questa del mondo, e che noi doviamo diffinire.
Dicsono Arelio. Dite eccellentemente; e questa considerazione molto mi contenta, perché veggio alcuni tanto poco accorti che non distingueno le cause della natura assolutamente, secondo tutto l’ambito de lor essere, che son considerate da’ filosofi, e de quelle prese in un modo limitato e appropriato; perché il primo modo è soverchio e vano a’ medici, in quanto che son medici, il secondo è mozzo e diminuto a’ filosofi, in quanto che son filosofi.
Teofilo. Avete toccato quel punto nel quale è lodato Paracelso, ch’ha trattata la filosofia medicinale, e biasimato Galeno in quanto ha apportata la medicina filosofale, per far una mistura fastidiosa e una tela tanto imbrogliata, che al fine renda un poco exquisito medico e molto confuso filosofo. Ma questo sia detto con qualche rispetto; perché non ho avuto ocio per esaminare tutte le parti di quell’uomo.
Gervasio. Di grazia, Teofilo, prima fatemi questo piacere a me, che non sono tanto prattico in filosofia: dechiaratemi che cosa intendete per questo nome materia, e che cosa è quello che è materia nelle cose naturali.
Teofilo. Tutti quelli che vogliono distinguere la materia e considerarla da per sé, senza la forma, ricorreno alla similitudine de l’arte. Cossí fanno i pitagorici, cossí i platonici, cossí i peripatetici. Vedete una specie di arte, come del lignaiolo, la quale per tutte le sue forme e tutti suoi lavori ha per soggetto il legno; come il ferraio il ferro, il sarto il panno. Tutte queste arti in una propria materia fanno diversi ritratti, ordini e figure, de le quali nessuna è propria e naturale a quella. Cossí la natura, a cui è simile l’arte, bisogna che de le sue operazioni abbia una materia; perché non è possibile che sia agente alcuno che, se vuol far qualche cosa, non abbia di che farla; o se vuol oprare, non abia che oprare. È dunque una specie di soggetto, del qual, col quale e nel quale la natura effettua la sua operazione, il suo lavoro; e il quale è da lei formato di tante forme che ne presentano a gli occhi della considerazione tanta varietà di specie. E sí come il legno da sé non ha nessuna forma artificiale, ma tutte può avere per operazione del legnaiolo; cossí la materia, di cui parliamo, da per sé e in sua natura non ha forma alcuna naturale, ma tutte le può aver per operazione dell’agente attivo principio di natura. Questa materia naturale non è cossí sensibile come la materia artificiale, perché la materia della natura non ha forma alcuna assolutamente; ma la materia dell’arte è una cosa formata già della natura, poscia che l’arte non può oprare se non nella superficie delle cose formate da la natura come legno, ferro, pietra, lana e cose simili; ma la natura opra dal centro, per dir cossí, del suo soggetto o materia, che è al tutto informe. Però molti sono i soggetti de le arti, ed uno è il soggetto della natura; perché quelli, per essere diversamente formati dalla natura, sono differenti e varii; questo, per non essere alcunamente formato, è al tutto indifferente, atteso che ogni differenza e diversità procede da la forma.
Gervasio. Tanto che le cose formate della natura sono materia de l’arte, e una cosa informe sola è materia della natura?
Teofilo. Cossí è.
Gervasio. È possibile che sí come vedemo e conoscemo chiaramente gli soggetti de le arti, possiamo similmente conoscere il soggetto de la natura?
Teofilo. Assai bene, ma con diversi principii di cognizione; perché sí come non col medesmo senso conoscemo gli colori e gli suoni, cossí non con il medesmo occhio veggiamo il soggetto de le arti e il soggetto della natura.
Gervasio. Volete dire, che noi con gli occhi sensitivi veggiamo quello, e con l’occhio della raggione questo.
Teofilo. Bene.
Gervasio. Or piacciavi formar questa raggione.
Teofilo. Volentieri. Quella relazione e riguardo che ha la forma de l’arte alla sua materia, medesma (secondo la debita proporzione) ha la forma della natura alla sua materia. Sí come dunque ne l’arte, variandosi in infinito (se possibil fosse) le forme, è sempre una materia medesima che persevera sotto quelle; come, appresso, la forma de l’arbore è una forma di tronco, poi di trave, poi di tavola, poi di scanno, poi di scabello, poi di cascia, poi di pettine e cossí va discorrendo, tuttavolta l’esser legno sempre persevera; non altrimente nella natura, variandosi in infinito e succedendo l’una a l’altra le forme, è sempre una materia medesma.
Gervasio. Come si può saldar questa similitudine?
Teofilo. Non vedete voi che quello che era seme si fa erba, e da quello che era erba si fa spica, da che era spica si fa pane, da pane chilo, da chilo sangue, da questo seme, da questo embrione, da questo uomo, da questo cadavero, da questo terra, da questa pietra o altra cosa, e cossí oltre, per venire a tutte forme naturali?
Gervasio. Facilmente il veggio.
Teofilo. Bisogna dunque che sia una medesima cosa che da sé non è pietra, non terra, non cadavero, non uomo, non embrione, non sangue o altro; ma che, dopo che era sangue, si fa embrione, ricevendo l’essere embrione; dopo che era embrione, riceva l’essere uomo, facendosi omo; come quella formata dalla natura, che è soggetto de la arte, da quel che era arbore, è tavola, e riceve esser tavola; da quel che era tavola, riceve l’esser porta, ed è porta.
Gervasio. Or l’ho capito molto bene [,] ma questo soggetto della natura mi par che non possa esser corpo, né di certa qualità; perché questo, che va strafugendo or sotto una forma ed essere naturale, or sotto un’altra forma ed essere, non si dimostra corporalmente, come il legno o pietra, che sempre si fan veder quel che sono materialmente, o soggettivamente pongansi pure sotto qual forma si voglia.
Teofilo. Voi dite bene.
Gervasio. Or che farò quando mi avverrà di conferir questo pensiero con qualche pertinace, il quale non voglia credere che sia cossí una sola materia sotto tutte le formazioni della natura, come è una sotto tutte le formazioni di ciascuna arte? Perché questa che si vede con gli occhi, non si può negare; quella che si vede con la raggione sola, si può negar...