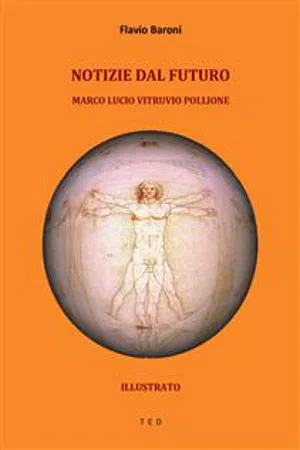
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Questa pubblicazione, a cura di Flavio Baroni, presenta al lettore le introduzioni che precedono ognuno dei Dieci Libri dell'Architettura di Vitruvio, con l'aggiunta di due brani presenti nel primo libro relativi l'uno alla concezione che Vitruvio ha dell'architettura e delle problematiche del costruire e l'altro alla formazione dell'architetto. L'intero testo è corredato dai disegni attinti dalle due edizioni: una del 1524 e l'altra del 1535 del trattato, tradotte e pubblicate da Francesco Lutio Durantino.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Notizie dal futuro. Marco Lucio Vitruvio Pollione by Flavio Baroni in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Architecture & Architecture General. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
ArchitectureSubtopic
Architecture GeneralCAPO I.
Cosa sia l’Architettura, e come debbano essere istruiti gli Architetti.
L’Architettura 1 è una scienza ch’è adornata da più dottrine, e da varie erudizioni, col sentimento delle quali giudica di tutte quelle opere che sono perfezionate dalle arti rimanenti 2 . Ella nasce dall’esperienza non meno che dal raziocinio. L’esperienza è una riflessione continua e consumata sull’uso, la quale si perfeziona coll’operare sulla materia di qualunque genere, e necessaria giusta l’idea del disegno. Il raziocinio poi è quello che può dimostrare le cose fabbricate, e manifestarle con prontezza, e con le ragioni della proporzione. Per lo che quegli Architetti che illetterati hanno tentato di operare sulla materia, non hanno potuto arrecare tanto di credito alle loro fatiche, sì che ne acquistassero fama; e quelli poi che nel raziocinio e nelle sole lettere si sono fidati, l’ombra, non già la cosa, sembra che abbiano seguitata. Ma quelli che fondatamente appresero l’una e l’altra, come uomini provveduti d’ogni sorta d’armi, sono giunti assai più presto a conseguire con riputazione il loro intento.
Conciossiaché in tutte le cose, e soprattutto nell’Architettura, vi sono due parti: la cosa significata cioè, e quella che è significante. La cosa significata è quella di cui si tratta: quella ch’è poi significante si è la dimostrazione svolta colle ragioni delle dottrine. Sicché sembra che esser debba nell’una e nell’altra parte esercitato chi fa professione di Architetto.
Quindi bisogna che egli sia uomo di talento, e riflessivo nella dottrina: perciò né talento senza disciplina, né disciplina senza talento non possono rendere perfetto un’artefice. Sia perciò egli letterato, esperto nel disegno, erudito nella geometria, e non ignorante d’ottica, istruito nell’aritmetica, gli siano note non poche istorie, abbia udito con diligenza i filosofi, sappia di musica, non ignori la medicina, abbia cognizione delle leggi dei giurisprudenti, intenda l’astronomia e i moti del cielo; e perché così abbisogni, eccone qui le cagioni.
Egli è necessario che l’Architetto sappia di lettere, perché leggendo e notando in iscritto si faccia la memoria più ferma. In appresso abbia disegno, perché egli sia capace a potere cogli esemplari dipinti mostrare ogni qualunque forma voglia fare d’alcun’opera. La geometria reca poi molti soccorsi all’Architettura; e in prima ella insegna l’uso della riga e delle seste, coi quali strumenti soprattutto si formano più facilmente le piante degli edifici, si conducono le linee rette, i livelli e gli angoli a squadra. Parimenti mediante l’ottica 3 si prendono negli edifici i lumi direttamente da determinati aspetti del cielo. Coll’aritmetica si calcolano le spese degli edifici, si dimostrano le ragioni delle misure, e col calcolo e col metodo aritmetico si sciolgono 4 i difficili problemi delle proporzioni. Bisogna che egli abbia notizia di molte istorie, poiché sovente gli Architetti disegnano nelle opere molti ornamenti, dei quali soggetti debbono eglino, a chi lor ne domanda, render ragione perché ve gli abbiano introdotti. Siccome se alcuno avesse, a luogo delle colonne, allogate statue di marmo, di donne vestite di stola, che Cariatidi vengono chiamate, e sopra esse abbia collocati i modiglioni e le cornici; così, a chi ne domandasse, renderà la seguente ragione. Caria città del Peloponneso fece lega coi Persiani per invadere la Grecia. Quindi i Greci, ottenuta la vittoria, e gloriosamente liberati da questa guerra, di comune consiglio la intimarono ai Cariati.
Presa dunque la città, uccisi i maschi, spianata la città medesima, ne condussero schiave le loro matrone; e non permisero ch’elleno deponessero le vesti e gli ornamenti da matrone, affinché non fossero per una volta sola condotte in trionfo, ma con eterno esempio di schiavitù, da grave scorno oppresse, sembrassero portare la pena per la loro città. Pertanto gli Architetti che fiorirono in quel tempo rappresentarono nei pubblici edifici i ritratti di quelle matrone collocate a reggere pesi 5, acciocché passasse anche ai posteri la memoria della nota pena del fallo dei Cariati. Così pure i Laconi sotto il comando di Pausania figliolo di Cleombroto 6, avendo nel fatto di arme di Platea con poca gente superato un numero infinito di Persiani, e con glorioso trionfo e delle spoglie e della preda, col prodotto dal bottino, fatto con laude e valore dei cittadini, eressero il Portico persiano come per trofeo e segno della vittoria, onde tramandarne la memoria ai posteri; ed ivi collocarono i simulacri degli schiavi coll’ornamento barbaro della loro veste, in atto di sostenere rintavolato, acciocché restasse a questa foggia punita la loro superbia col meritato oltraggio, e perché così anche gl’inimici abbattuti, pel timore della loro fortezza, si atterrissero, ed i cittadini rimirando questo esempio di valore, animati dalla gloria, fossero pronti a difendere la libertà. Per lo che da questo fatto ne avvenne che molti collocarono nelle fabbriche le statue persiane per sostenere gli architravi coi loro adornamenti 7, donde nacque che da tal soggetto aggiungessero alle decorazioni variati ornamenti di squisito gusto. Vi sono eziandio delle altre storie di simil sorta, delle quali l’Architetto debbi essere istruito.
La Filosofia poi fornisce l’Ar chitetto di animo grande, e fa ch’egli non sia arrogante, ma piuttosto manieroso, giusto e fedele, e, ciò che maggiormente importa, che egli non sia avaro; perciò non può degnamente farsi nessun’opera se non da chi sia sincero ed incorrotto. Non sia egli parziale, né abbia l’animo dedito a ricevere doni, ma con gravità sostenga il proprio decoro col riportarne buon nome; poiché questo lo prescrive la filosofia. Tratta inoltre questa della natura delle cose, la qual parte in greco si chiama Fisiologia, alla quale è di necessità applicarvi assai, perché ella contiene molte e diverse questioni naturali, come anche accade nel condurre le acque; perciò nei loro corsi e giri, e nelle salite dal piano orizzontale, si generano dei venti, or in un modo, ed ora in un altro, all’urto dei quali niuno saprà rimediare se non quegli che saprà dalla filosofia i principi delle cose naturali. Come parimenti chi leggerà i libri di Tesibio8, e di Archimede, e degli altri autori che hanno scritto dei precetti in simili materie, non potrà entrare nel loro vero senso, ove non sia stato di queste cose dai filosofi istruito. Deve poi sapere la musica9, per intendere le regole della scala armonica, e le ragioni matematiche, ed inoltre per saper dare la giusta carica alle baliste, catapulte e scorpioni10. Poiché hanno queste macchine da destra e da sinistra i capitelli, nei quali vi sono i buchi degli unisoni, attorno i quali cogli argani, mulinelli e vetti, si tirano le corde di budello, le quali non si fermano, o legano, se non quando rendono all’orecchio dell’artefice tuoni unisoni ed eguali11. Perciò i braccioli, che nel tirare e nel caricare si serrano, quando si rilasciano così stirati egualmente dall’una e dall’altra banda, debbono scoccare diritto il colpo; che se non saranno unisoni, faranno torcere dal diritto cammino i dardi. Similmente nei teatri i vasi12 di metallo, che si situano nelle piccole celle sotto i gradi con proporzioni matematiche, e le differenze dei suoni, che i Greci chiamano Echea13, si regolano con i concerti e consonanze musicali, distribuiti intorno nella quarta e quinta, e nell’ottava, in maniera che la voce del suono che parte dalla scena giungendo a percuotere i vasi così disposti, accrescendosi col rimbombo, perviene più chiara e più dolce all’orecchio degli spettatori. Anche nessuno potrà mai formare senza le ragioni musiche le macchine idrauliche, né altre somigliati a queste14.
La Medicina poi è necessaria a conoscersi per sapere quali siano i declinamenti del Cielo, che i Greci chiamano Climi, quali arie dei luoghi siano sane, e quali malsane: e così per l’uso delle acque; poiché senza queste riflessioni non si può fare alcuna abitazione salubre.
Bisogna pur ch’ei non ignori le leggi indispensabili per regolare gli ordinari muri 15 degli edifici, per riguardo al giro delle grondaie, alle fogne, ed ai lumi. Gli scoli parimenti delle acque, ed altre cose simili, esser debbono noti agli Architetti, acciocché ne siano cautelati prima di piantare gli edifici, sì che non rimangano, dopo effettuale le opere, le liti ai padri di famiglia; ed acciocché, nello stabilire i patti con prudenza, resti assicurato tanto chi dà, quanto chi prende in affitto: perciò se i patti saranno con sapere espressi, rimarranno senza frode gli uni e gli altri 16.
Mediante poi l’Astrologia si conosce l’Oriente, l’Occidente, il Mezzodì; il Settentrione, e la disposizione del Cielo, l’Equinozio, il Solstizio, il corso delle Stelle; e chi non saprà queste cose, non potrà neppur sapere come si formino gli orologi.
Poiché dunque questa così degna disciplina viene adornata e ripiena di molte e varie erudizioni, io non penso che taluni possano a ragione chiamarsi così di subito Architetti, se non coloro che fin dall’età puerile salendo per questi gradi di dottrine, e nutriti della cognizione di molte scienze ed arti, giungeranno al più alto colmo dell’Architettura. Recherà forse meraviglia agl’ignoranti che naturalmente apprendere si possa e ritenere a memoria un così gran novero di dottrine; ma si crederà esser facile a farsi, ove riflettano che tutte le scienze hanno fra loro una corrispondenza e comunicazione: perciò la scienza enciclica, ossia universale, è, a guisa di un corpo intero, composta da tutti questi membri. Quindi coloro che dalla tenera età apprendono i vari rudimenti di tutte le scienze, imparano i segni di queste, e con essi il reciproco rapporto di tutte le discipline; e così poi facilmente sono di tutto eruditi.
Pizio 17, che fu uno degli antichi Architetti, ed il quale pel primo 18 così nobilmente architettò il tempio di Minerva nella città di Palazia, disse perciò nei suoi scritti, che l’Architetto dee poter operare in ogni arte e scienza, più di quello che fecero coloro i quali colle loro industrie e fatiche hanno condotta alcuna cosa in particolare a somma perfezione. Ma questo però in effetto non riesce. Non può in fatti l’Architetto, e non debba essere grammatico come sarà stato Aristarco, ma non sia senza lettere; non musico quanto Aristosseno 19, ma non ignorante di musica; non pittore come Apelle, ma non imperito del disegno; non già scultore come Mirone, o Policleto, ma non ignaro affatto della scultura; né finalmente medico come Ippocrate, ma non digiuno interamente di medicina; non eccellente singolarmente in ogni scienza, ma non insciente in nessuna. Perciò in tanta varietà di cose non è possibile che alcuno possa giungere alle più particolari finezze, perché appena è in poter nostro arrivare ad intendere e sviluppare le loro teorie. E non è già che i soli Architetti non possano giungere all’ultima perfezione in tutte le cose; ma anco quei medesimi che in una sola arte s’incamminano non tutti ne riportano il primo posto, ed il più sublime grado di lode. Se dunque in ciascuna scienza non tutti i rispettivi professori, ma soltanto uno scarso numero di essi nel corso di un secolo sono giunti all’eccellenza, come mai può un Architetto, il quale debba essere esperto in molle arti (cosa per sé straordinaria e grande), fare che non solo non ne ignori alcuna, ma che anzi superi tutti quegli artefici i quali hanno sopra un’arte sola esercitato laboriosamente il loro grandissimo ingegno?
Sembra dunque che Pizio in ciò si sia ingannato, e che egli non abbia avvertito che ciascun’arte di due cose si compone: delle opere della mano cioè, e del raziocinio. Di queste la prima è propria di coloro che si esercitano in ciascun’arte, ed essa riguarda l’effetto dell’opera; l’altra è comune con t...
Table of contents
- Copertina
- NOTIZIE DAL FUTURO. MARCO LUCIO VITRUVIO POLLIONE
- Indice
- Intro
- DUE PAROLE
- LIBRO I
- Note
- LIBRO II
- Note
- LIBRO III
- Note
- LIBRO IV
- LIBRO V
- Note
- LIBRO VI
- Note
- LIBRO VII
- Note
- LIBRO VIII
- Note
- LIBRO IX
- Note
- LIBRO X
- Note
- CAPO I.
- Note
- CAPO II.
- Note
- Ringraziamenti