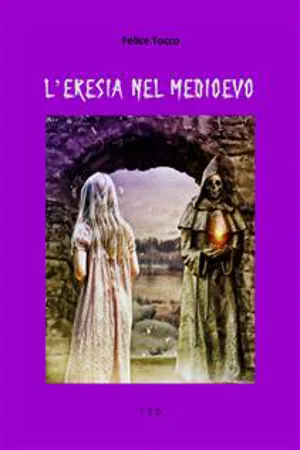
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
L'eresia nel Medioevo
About this book
Storia dell'eresia nel Medioevo, ovvero dall'eresia allo scisma e dallo scisma all'eresia: dai Catari ai Valdesi e dai Patarini agli Arnaldisti. Con Gioacchino da Fiore, Amorico di Bena, Giovanni da Parma, Ubertino da Casale, Michele da Cesena, Guglielmo Occam… Un libro provvisto di una smisurata documentazione. In questa edizione il testo è stato interamente controllato e normalizzato, comprese le ben 877 note (in gran parte in lingua latina e facoltativamente consultabili).
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access L'eresia nel Medioevo by Felice Tocco in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Theology & Religion & Religion. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Topic
Theology & ReligionSubtopic
ReligionAMORICO DI BENA E IL MOVIMENTO FRANCESCANO
I.
La fama di Gioacchino par che non tardasse a diffondersi fuori d’Italia, e già dicemmo che il re d’Inghilterra e l’abate di Perseigne nel loro viaggio in Italia vollero conoscere di persona quest’uomo misterioso, che tanto faceva parlar di sé. Né parrà strano che l’eco delle sue idee si ripercuotesse in Francia, ove i discepoli di Amorico di Bena le accolsero per innestarle alle loro dottrine filosofiche. Il Rousselot crede che l’innesto si debba ad Amorico stesso. [1] Né certo la cronologia porrebbe inciampo a questa opinione, perché sebbene le opere dell’abate Gioacchino siano state pubblicate intorno al 1200, e non molto più tardi quelle di Amorico, che vennero condannate dall’Università parigina nel 1204, [2] pure dopo questo tempo Amorico andò a Roma per appellarsi dalla sentenza dell’Università, e nulla vieta che a Roma sapesse qualche cosa delle dottrine di Gioacchino, come nove anni prima era occorso all’abate di Perseigne. Né sarebbe temerità il supporre che a tergere la sua dottrina da ogni macchia, ne mostrasse l’accordo con quella di un santo uomo, fondatore di un ordine religioso, e tenuto dalla S. Sede in grande venerazione. Questa prova in verità non avrebbe fruttato, perché il Papa ribadì la condanna dell’Università, ed Amorico, tornato a Parigi, fu costretto nel 1207 a ricredersi pubblicamente, e ne morì, come si diceva, dal dolore; [3] ma ciò non toglie che la prova, pur non giovando alla causa del filosofo, avrebbe contribuito non poco al successo della dottrina.
Non ostante questi nuovi argomenti da me addotti, io non saprei accettare l’opinione del Rousselot, perché le più antiche fonti attribuiscono la teoria dei tre stati non ad Amorico stesso, né a Davide di Dinan, bensì ai loro discepoli. [4] Quando dunque sia nato siffatto innesto del razionalismo filosofico col misticismo religioso, mal si saprebbe dire; ma quando sia nato, o a chiunque appartenga, è certo meritevole di studio.
La filosofia di Amorico di Bena rinnova il realismo di Scoto Erigena con colorito più spiccatamente panteistico. Amorico, al pari di Scoto, muove dalla dottrina delle idee mediane tra il mondo e Dio, rispetto a quelle creatrici, rispetto a questo create. E come le idee eterne e la mente divina, che le pensa, sono in fondo la stessa cosa, così parimenti si confonderanno in uno le idee creatrici e gli effetti che da loro promanano. E così tutte le cose si unificheranno in Dio, e tutte avranno la stessa natura, come della stessa natura sono Abramo ed Isacco. Onde si può ben dire che tutte le cose tornano ad una, e tutte sono Dio, poiché Dio è l’essenza di tutte le creature. Ed a quel modo che la luce non si vede in sé stessa, ma nell’aere, così Dio né dagli uomini né dagli angeli può essere veduto in sé stesso, bensì nelle sue creature. [5]
La stessa dottrina venne insegnata dal discepolo di Amorico, Davide di Dinan. Se non che pare che il discepolo si giovasse a preferenza di concetti aristotelici, laddove il maestro più volentieri adoperava i platonici. S. Tommaso ci dice che Davide soleva dividere le cose (il mondo) in tre parti, corpi, anime e sostanze eterne separate. L’entità indivisibile, onde sono formati i corpi la diceva ile o materia prima; l’entità indivisibile, o sostrato delle anime la chiamava nous o mente; l’entità indivisibile delle sostanze eterne, Dio. E come tutte e tre queste entità sono prime ed indivisibili, vale a dire hanno gli stessi attributi, è pur gioco forza che in fondo siano la stessa entità. Dal che consegue che tutte le cose nell’essenza loro si riducono ad uno. [6]
Da questa dottrina metafisica potevano ricavarsi conseguenze arditissime. Due sole ci vengono ricordate da Martino Polono. La prima, riguarda la distinzione dei sessi, la quale al pari di tutte le differenze, che separano cose da cose, sarebbe affatto provvisoria. Un tempo siffatta tenzone dei due sessi non esisteva, cominciò soltanto dal peccato di Adamo, e dopo la resurrezione si tornerà all’unità primitiva. [7] Con queste sentenze, il cui senso appena si coglie, e che certo ricordano i miti dell’androgino del Convito, forse si connette l’entusiasmo per l’amore, per quella forza arcana e misteriosa, che riduce gli esseri diversi all’unità della loro natura. Certo questa seconda conseguenza traevano gli Almariciani dal loro panteismo, che allorquando la forza d’amore investe gli uomini, vince le loro volontà, e rende le loro azioni inimputabili. [8]
A queste teorie filosofiche Amorico aveva già saputo dare un colore ed espressione religiosa. Egli soleva dire, secondo la testimonianza di Guglielmo Armorico riprodotta da Vincenzo di Beauvais, che il primo dogma da essere insegnato e creduto è questo: ogni cristiano essere membro di Cristo, e non potere salvarsi alcuno, che non creda in questo dogma più fermamente della incarnazione o passione di Gesù. [9] Così pure ammetteva bene che il corpo di Cristo fosse nel sacro pane, perché parimenti è in ogni pane, ed in ogni cosa. [10] In altre parole egli sapeva col magistero dell’allegoria torcere i dommi tradizionali a quei significati, che la sua filosofia richiedeva. Questa libertà d’interpretazione, questa tendenza alla spiegazione allegorica, è appunto il tratto che raccosta l’abate calabrese al filosofo di Chartres. E certo se non Amorico, almeno i suoi discepoli non dubitano di accogliere la teoria dei tre stati. Ed anche essi pensano che al tempo della legge mosaica, quando così aperto era il contrasto tra Dio e l’uomo, non si conosceva la verità, ovvero il monismo nella loro filosofia insegnato. Nel secondo periodo, in cui Gesù è considerato come l’Uomo-Dio, la verità comincia a rivelarsi, ma in forma di simboli, e l’unificazione di Dio coll’uomo è rappresentata come se avesse avuto luogo una volta sola, e per virtù soprannaturale. Nel terzo periodo poi la verità è svelata pienamente, in Gesù si vede raffigurata tutta l’umanità, e ciò che si dice dell’uomo deve dirsi della natura intera, che è tutt’uno con Dio. [11] Nel primo periodo domina il Padre, senza l’intervento del Figliolo o dello Spirito. [12] Nel secondo domina il Figliolo, che assunse carne in Maria non certo nel senso che l’intende la tradizione, bensì a quel modo che si può dire anche del Padre essersi incarnato in Abramo, il primo dei patriarchi, o il rappresentante di Geova. Nel terzo infine domina lo Spirito Santo il quale s’incarna, anche lui non più in un uomo solo, ma in tutti i membri della nuova religione. [13] E come alla venuta del figliolo cessò il regno del Padre, e fu abolita la circoncisione, e ci affrancammo dalla schiavitù della legge mosaica; così alla venuta dello Spirito cesserà il regno del Figliolo, ed i dommi ed i precetti della nuova legge cadranno al pari dell’antica. [14] Non che cesseranno i sacramenti, ma s’intenderanno nel loro vero spirito. Abbiamo già citata la trasformazione razionalistica dell’Eucaristia. Parimenti è trasformato il dogma della risurrezione dei morti, la quale intesa alla lettera non si può ammettere, ma bensì nel senso allegorico di un ridestarsi dello spirito della verità dal lungo sonno che l’opprimeva. [15] Parimenti l’Inferno non è altro se non il peccato mortale stesso, che è come un dente guasto nella bocca, e il Paradiso lo porta con sé chiunque arrivi alla cognizione filosofica di Dio. [16] Seguendo questo spirito razionalistico non fa certo meraviglia che abbiano condannato anch’essi quegli usi e quelle cerimonie del culto esteriore, che vedemmo proscritti dai Catari e dai Valdesi. Così pare che abbiano condannato il battesimo dei bambini, [17] il culto delle immagini, l’adorazione dei santi, la venerazione delle reliquie, [18] e la confessione e la comunione l’intendevano come una interna rinnovazione della coscienza religiosa, prodotta dalla grazia dello Spirito Santo, senza il soccorso di opere o cerimonie esteriori. [19]
Ben si vede come gli Almariciani andassero molto più in là dell’abate calabrese, o di qualunque setta religiosa. Ciò non pertanto al pari di Gioacchino la pretendevano a profeti, e sapevano predire anche loro che tra cinque anni sarebbero toccate al mondo quattro piaghe. La prima è la fame, di cui sarebbe morto il popolo, la seconda è la guerra che avrebbe fatta strage dei principi, la terza un terremoto che avrebbe fatto inghiottire i Burgensi dalla terra squarciatasi sotto i loro piedi, la quarta, il fuoco che avrebbe divorato i prelati, che sono le membra dell’Anticristo, e Roma, la nova Babilonia, che ne è il lor capo. Allora saranno unificati tutti i regni in un solo, ed il capo di questa nova società, informata dall’amore dello spirito, sarà Filippo Augusto, il re di Francia. [20]
Ma non ostante queste rassomiglianze la dottrina degli Almariciani e quella dell’abate Gioacchino sono agli antipodi, e l’innesto del razionalismo filosofico col misticismo, del quale facemmo parola, doveva riuscire piuttosto ad una meccanica mescolanza che ad un concrescimento organico. Poiché tra il monismo neoplatonico e la dottrina di Gioacchino, che rasentava il triteismo, non poteva aver luogo nessuna conciliazione. E se i due novatori si servivano dell’allegoria per accomodare alle loro idee i sacri testi, certo le idee loro erano affatto disformi; perché nel mentre Amorico metteva la scienza al di sopra della fede, e confidava che la religione in avvenire fosse assorbita nella filosofia, Gioacchino al contrario faceva pochissimo conto della scienza, e credeva che, non solo nel presente, ma più ancora nell’avvenire, la religione avrebbe scacciata dal sacro tempio la filosofia. Pari all’opposizione tra le dottrine è la disformità dell’indirizzo pratico. Perché la mèta dell’umanità secondo Amorico è vivere la vita della natura, di cui l’uomo non è che una piccola parte; la mèta secondo Gioacchino è tutt’altra, staccarsi più di quel che non si faccia ora, dalla natura e raccogliersi nelle austere solitudini dello spirito. L’ideale di Amorico è la riaffermazione del mondo, l’ideale di Gioacchino invece ne è la piena ed imminente distruzione. Non è la prima volta né sarà l’ultima che una dottrina filosofica tolga in prestito una forma religiosa, che non le appartiene. Talvolta è questo l’unico mezzo per assicurare l’avvenire della dottrina.
II.
I veri interpreti del pensiero di Gioacchino non furono i fratelli del libero spirito, bensì i frati minori, che nel silenzio delle loro celle ne studiarono e commentarono i libri e formarono una scuola, detta gioachimita o gioachita, e crearono una completa letteratura profetica, e pseudonoma. Sarebbe interessante lo studio di questa letteratura, in parte già pubblicata nel secolo decimosesto, ed in parte sepolta nella polvere delle nostre biblioteche. Ma per il nostro compito la notizia, che ne demmo nel parlare delle opere di Gioacchino è più che bastevole. Ci restringeremo a studiare le idee direttive dei Gioachimiti, ed il modo come germogliarono tra le lotte del sodalizio francescano. Giace tuttora inedito nelle nostre biblioteche un antico racconto dei dissidi francescani, che va sotto il nome di Cronaca delle Tribolazioni. [21] Si conserva una redazione in latino, ed un’altra in italiano, ma entrambe evidentemente sono composte di frammenti di cronache più antiche, legate insieme col manifesto disegno di mostrare non pure la successione cronologica, ma l’intima connessione delle lotte, che ebbe a durare una parte dei francescani. [22] In questo centone, come nei Fioretti di S. Francesco, composti nello stesso modo e con lo stesso intendimento se non col medesimo disegno, gli errori storici e cronologici spesseggiano. Né certo l’anonima Cronaca delle Tribolazioni può stare a petto di quella fonte preziosa, che è il Salimbene, gioachimita anche lui, ma temperato, e narratore ingenuo dei fatti accaduti sotto i suoi occhi. Ma non ostante questi gravi difetti né la Cronaca né i Fioretti perdono la loro importanza, e debbono essere posti da banda, come crede l’Affò. [23] Tutte e due valgono, e la Cronaca a parer mio più dei Fioretti, essendo il primo saggio di una ricostruzione della storia dell’ordine da S. Francesco ad Ubertino da Casale. Certo questa ricostruzione, fatta con intendimento polemico in servigio d’un partito, non ha né può avere grande esattezza e schiettezza storica, ma come manifestazione delle idee e dei sentimenti di quel partito, è certo un documento prezioso. E tale la reputava il Wadding, che se ne giovò più di quel che dovesse. Il cronista conta sei tribolazioni, alle quali bisogna aggiungere per settima quella che egli stesso soffre e di cui crede più prudente tacere. Secondo questa partizione della storia francescana si possono bene agguagliare le tribolazioni francescane alle sette piaghe d’Egitto, alle calamità predette nell’ Apocalisse. E da siffatto riscontro il pio cronista può ben trarre la speranza che la settima tribolazione sia l’ultima, né si faccia aspettare il giorno del trionfo; ma perché il numero torni deve mettere la prima tribolazione negli ultimi anni di S. Francesco, il che difficilmente si può ammettere da chi studi le più antiche fonti, come ci faremo a dimostrare.
Il Santo d’Assisi nel fondare un nuovo ordine religioso, ebbe in mente idee più larghe e più feconde dell’Abate di Fiore. Egli ben vide che il miglior mezzo a combattere gli eretici era quello d’imitarli nei costumi, e sulle loro orme far getto della propria fortuna, vestire ruvidi panni, e andar raminghi di città in città, predicando dappertutto la buona novella. Anche Francesco al pari di Valdez apparteneva ad un’agiata famiglia, e menava parimenti una vita frivola e spensierata; ma anche lui, tocco dalle parole del Vangelo, si tolse in un punto agli agi ed ai piaceri, e abbandonati amici e parenti, si cacciò animoso nell’ingrata via dell’apostolato. [24] E dappertutto predicava la sola via della salute essere la povertà, perché chi non sa spogliarsi delle ricchezze, né vende il suo per distribuirlo ai poveri, non è penetrato da quell’amore del prossimo, che Cristo mette a capo della sua legge. [25] La povertà volontaria era per Francesco come per il Valdez la fonte delle virtù, un ideale di sacrificio e di generosità, che scaldava il cuore e commoveva la fantasia. [26] Né gli pa...
Table of contents
- Copertina
- L’ERESIA NEL MEDIOEVO
- Indice
- Intro
- AVVERTENZA
- INTRODUZIONE
- DALL’ERESIA ALLO SCISMA
- I CATARI
- I VALDESI
- PATARINI E ARNALDISTI
- DALLO SCISMA ALL’ERESIA
- L’ABATE GIOACCHINO
- AMORICO DI BENA E IL MOVIMENTO FRANCESCANO
- CONCLUSIONE
- Ringraziamenti