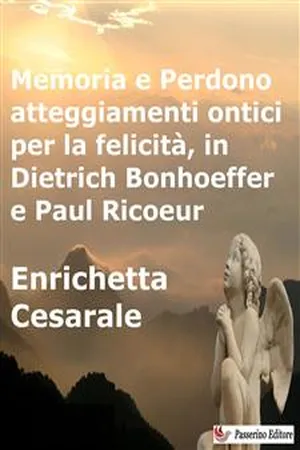
Memoria e Perdono, atteggiamenti ontici per la felicità, in Dietrich Bonhoeffer e Paul Ricoeur
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
Memoria e Perdono, atteggiamenti ontici per la felicità, in Dietrich Bonhoeffer e Paul Ricoeur
About this book
Il testo desidera ripercorrere l'affascinante pensiero e sentiero di vita di due grandi uomini e maestri, Dietrich Bonhoeffer e Paul Ricoeur, e ne rilegge il movimento a spirale, paradossalmente lineare, che partendo da una intuizione iniziale progredisce avanzando verso un fine, che è, per entrambi, il fine della vita. Partendo dallo stesso interrogativo, "Chi sono io?", inizia il loro lungo viaggio, nella crescita della consapevolezza e della comprensione del Dasein, dove ogni esperienza di rottura è motivo di ri-sistemazione dell'ordine dei pensieri.
Sia Bonhoeffer che Ricoeur hanno conosciuto personalmente la perdita di cose inestimabili, hanno sperimentato le interruzioni del senso nel tempo, la continuità spezzata col passato e col futuro, ma hanno compreso che niente va perduto e hanno, così, teorizzato la forza della memoria. L'autrice Enrichetta Cesarale, nata a Gaeta (LT), ha compiuto il cursus studiorum filosofico-teologico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove ha conseguito la Licenza in Teologia biblica e il Dottorato sotto la guida di Padre Ugo Vanni s.j. È laureata in Filosofia presso l'Università degli studi di Roma3 con tesi dal titolo: «Il giorno: nunc filosofico e scritturistico. La notte: attesa e coraggio del giorno». Ha pubblicato presso l'Editrice Pontificia Università Gregoriana «Figli della luce e figli del giorno» (1Ts 5, 5). Indagine biblico-teologica del «giorno» in Paolo.
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
1. La «teologia in via di perfezionamento»: teologia, forma di vita reale
1.1 Sanctorum Communio, prima tappa del pensiero itinerante
Table of contents
- Copertina
- Memoria e Perdono, atteggiamenti ontici per la felicità, in Dietrich Bonhoeffer e Paul Ricoeur
- Indice
- Dietrich Bonhoeffer, colpevole per amore del prossimo
- INTRODUZIONE «Chi sono io?»
- 1. La «teologia in via di perfezionamento»: teologia, forma di vita reale
- 1.1 Sanctorum Communio, prima tappa del pensiero itinerante
- 1.2 La Sequela: seconda tappa di un pensiero terreno
- 1.2.1 L’Etica: opera incompiuta di un percorso interrotto
- 1.3 Resistenza e resa: perfezione del percorso umano e teologico
- 2. Il percorso itinerante del pensiero nella vita: un tempo vissuto da uomo
- 2.1 La disciplina dell’arcano, traccia visibile
- 2.2 Il bene, traccia che è la vita
- 2.3 La responsabilità, traccia che è azione
- 2.4 Agire in conformità alla realtà, luogo della traccia
- 2.5 Sostituzione vicaria, divenire traccia
- 2.6 La coscienza
- 3. La responsabilità e la realtà del tempo
- 3.1 Il concetto del «kairós» nel periodo del Kirchenkampf
- 3.2 Responsabilità e storicità
- 3.3 La dialettica ultimo-penultimo
- Conclusione
- Paul Ricoeur: nella ricostruzione del sé, la memoria e il perdono difficile
- Introduzione
- 1. Chi sono io? Sé come un altro
- 2. Chi è responsabile? Una «Piccola Etica»
- 2.1 Il bene
- 3. La colpa e il male. Fenomenologia ed Ermeneutica del male
- 4. L’indagine del sé nella storia
- 4.1 Memoria, storia, oblio
- 4.2 La morte e la memoria
- 4.3 Dono, perdono, riconoscimento
- 4.4 Il perdono difficile
- 4.5 Storia e Tempo
- 4.5.1 Sé è il tempo
- 4.5.2 «Tempo dell’opera, tempo della vita»
- Conclusione
- Considerazioni
- EPILOGO
- Ringraziamenti