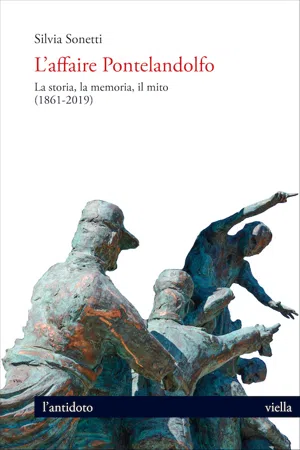![]()
1. La storia
1. «Avrebbe salvato un paese!! sic!»
Con data di ieri mi si fa rapporto dal capitano di questa guardia nazionale […]. Mi si assicura che in detto luogo vi è un punto di provenienza d’onde quei malfattori possano vedere da ogni parte che la forza possa quivi recarsi e nel contempo, da quel punto stesso, possono deviare per molte strade campestri ed immettersi nelle vicine campagne di comuni diversi adiacenti, cioè Guardia San Framondi, San Lorenzo Maggiore, Casalduni, e Pontelandolfo.16
Il 12 aprile 1861, Vincenzo Coppola era stato nominato delegato di pubblica sicurezza dei mandamenti di Pontelandolfo, Colle Sannita e Baselice. All’inizio dell’estate aveva scoperto le trame di una rete cospirativa nel circondario e sostenne, con malcelata insoddisfazione, che gli arresti e le perquisizioni che aveva programmato erano stati eseguiti «con poca prudenza».17 Era convinto che non si trattasse del solito ritorno del banditismo nelle aree interne o di una recrudescenza criminale, ma di un tentativo di rivolta generale.
Le province napoletane erano ora parte del nuovo Stato italiano. Da qualche settimana si erano moltiplicati i segnali di un’intensa mobilitazione dei difensori del vecchio regime borbonico. Notabili e partigiani della dinastia avevano reclutato banditi, ex militari e contadini, mettendo in campo bande e formazioni irregolari. La rivolta del 1861 sarebbe diventata la prima tappa importante della guerra nel Mezzogiorno, un conflitto cruento e brutale che avrebbe segnato il Sud del Paese per quasi un decennio. Nell’estate i contorni di questa crisi non erano chiari. Per i funzionari italiani non era semplice definire i limiti del proprio ruolo delineando il confine della legalità in un contesto ancora incerto, per la profondità e la radicalità della rivoluzione dell’anno precedente e della successiva unificazione istituzionale.
Coppola era uno dei numerosi funzionari e militari napoletani che si erano rapidamente inseriti nei gangli dello Stato italiano. Pur separati da appartenenze o adesioni politiche, condividevano tutti un’avversione radicale verso il regime borbonico e la stessa convinzione che il proprio ruolo fosse incompatibile con il ritorno della vecchia dinastia. Il crollo del Regno radicalizzò le fratture, gli odi e i rancori che da decenni avevano accompagnato la storia delle province napoletane, ma liberò anche energie e individui abituati ad agire nelle trame della cospirazione e dell’esilio.
Se, apparentemente, sembrava un poliziotto alle prime armi, in realtà Coppola aveva esperienze consolidate nel lungo conflitto civile meridionale come molti dei suoi colleghi: uomini dotati di strumenti interpretativi funzionali a comprendere una storia decennale fatta di violenze private e pubbliche, mobilitazioni ideologiche, rancori sociali, rivalità locali sempre in un qualche modo connessi con le grandi partite politiche. Coppola, per esempio, era stato tra coloro che si erano battuti per la Costituzione e per il Parlamento nel 1848; con lo scioglimento della camera e l’inizio della reazione borbonica, fu vittima della repressione politica. Dopo il processo – nel suo gruppo c’era anche il famoso avvocato salernitano Francesco La Francesca che sarà poi procuratore generale della Corte di Appello di Napoli e deputato del Regno d’Italia –, la famiglia fu rovinata e lui fu costretto a interrompere gli studi di ingegneria. Solo con l’unificazione ebbe un ruolo nella nuova polizia con la nomina a delegato di pubblica sicurezza, una figura istituita solo due anni prima dal governo piemontese e poi estesa alle province italiane. Era un profilo incardinato nel Ministero dell’Interno, di fatto dipendente gerarchicamente prima dai governatori, poi dai prefetti. Almeno in teoria, serviva anche a limitare ingerenze (e prepotenze) di amministratori e sindaci ai quali era stata a lungo delegata la tutela dell’ordine pubblico, spesso personalmente implicati o esposti a vendette private.18 Anche per questo il delegato di mandamento doveva essere estraneo ai territori, senza nessun legame di parentela, proprietà o affiliazione politica.
Dopo i fatti di Pontelandolfo del 14 agosto, cui non aveva assistito perché si era rifugiato a Cerreto prima dell’arrivo dei briganti, Coppola fu sospeso. Alla fine dell’estate, fu sentito dai magistrati istruttori del processo anche per difendersi dalle accuse di codardia che aleggiarono intorno a tutti coloro che si erano allontanati dal paese. Il giudice Mazzara testimoniò a suo favore dicendo che aveva «rialzato lo spirito pubblico e […] cercato di affezionare gli uomini al governo [dando la] caccia ai briganti affrontando qualunque pericolo».19 Il giudice Luigi di Giorgio apprezzò il suo zelo20 come anche il prefetto di Benevento che gli esternò in una lettera la sua «soddisfazione».21 Coppola meritò gli elogi e gli attestati di lode anche dei sindaci di Pontelandolfo22 e di Casalduni. Quest’ultimo, Ferdinando Cacucci, lo ricordò come un uomo «imparziale, onesto, energico».23
Grazie alle numerose deposizioni in suo favore Coppola fu subito reintegrato e promosso alla I classe.24 Nei due anni successivi continuò a operare tra il Beneventano e il Matese (nel mandamento di Colle25 e a San Marco dei Cavoti26), mettendo a segno numerosi arresti e as...