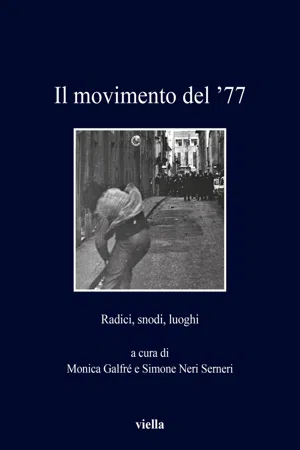![]()
Storie, culture, prospettive
![]()
Monica Galfré
«Senza passato né futuro». Il difficile rapporto del ’77 con la storia
Gli anniversari sono appuntamenti obbligatori, che certo non aiutano la riconciliazione con le memorie più controverse, come è sicuramente quella del movimento del ’77. Tuttavia essi lasciano trapelare, al di là della logica celebrativa della ricorrenza, una serie di elementi utili a fare luce su quello che in questo caso ho chiamato il difficile rapporto del ’77 con la storia. Il quarantennale, ormai concluso, è stato senz’altro più silenzioso del trentennale quando, con la complicità di quotidiani ed editori nazionali, l’ultimo movimento del Novecento italiano si era avviato a divenire un luogo della memoria collettiva, anche se con evidenti e significative torsioni interpretative. L’interrogativo di fondo attorno a cui ruotava allora la riflessione non è oggi superato e conviene riprendere da lì il discorso. Ci si chiedeva, e ci si continua chiedere, quasi l’una cosa escludesse l’altra, se il ’77 fosse opera dell’«ultima generazione d’Ottobre» o della prima dell’era postmoderna, con tutto ciò che questo comporta, se vi avessero cioè prevalso la violenza o la creatività, la politica o il privato, le ideologie o la loro definitiva eclissi, il rifiuto o la nascita di un nuovo modo di intendere il lavoro, l’operaismo o il postindustrialismo.
Dalle numerose pubblicazioni uscite intorno al 2007 il ’77 emergeva, assai discutibilmente, come punto di saldatura tra l’eredità degli anni Settanta e l’età postmoderna, come se anticipasse in qualche modo la fine del secolo breve. Pur oscillando ancora tra nostalgia e demonizzazione, nel complesso il trentennale aveva segnato il recupero in chiave positiva del ’77. Era infatti evidente il ruolo giocato ancora dalla memoria, o meglio dalle memorie, tra le quali più di tutte pesava un’ansia di riscatto generazionale. Il ’77 era così divenuto il crogiuolo in cui l’impegno collettivo degli anni Settanta si combinava con le ragioni del privato del decennio successivo, e in cui l’idea stessa di rivoluzione finiva per essere corretta dalla sostanziale accettazione della società e delle sue regole. La letteratura, più libera e spregiudicata, si dimostrava paradossalmente ben più lucida, o solo estremamente fortunata nel poter esibire un romanzo come Piove all’insù di Luca Rastello, capace di toccare il cuore vivo del ’77, primo tra tutti quello della violenza politica, tra colpe individuali e responsabilità collettive.
Dalla memoria alla storia
Il “relativo” silenzio di questo ultimo decennale – ma a livello locale le iniziative non sono state poche – non è necessariamente negativo ed è forse il segno del passaggio di testimone da una memoria ormai ingrigita, stanca e ripiegata su di sé, a una storia non priva di vitalità, grazie anche ai progressi compiuti dagli studi sugli anni Settanta, sulla violenza politica e sulla lotta armata (nonostante le polemiche riaccesesi per il quarantennale dell’omicidio Moro, che ha visto gli ex protagonisti e i loro detrattori dare il peggio di sé). La recente sintesi di Alessio Gagliardi dà conto di come e quanto la letteratura scientifica sul ’77 si sia arricchita, a cominciare dalle monografie, da quella di Marco Grispigni di qualche anno fa a quella più recente di Luca Falciola.
Una curiosità più matura e “laica”, nella quale si riflette il passaggio a una nuova generazione di studiosi, caratterizza ora l’approccio al ’77. Persino i quotidiani, affidandosi alla voce degli storici, sembrano essersi disintossicati dai vizi della memoria. È apparso ridimensionato lo stesso ricorso alla fotografia, riflesso del pregiudizio di «indicibilità» che ha a lungo gravato sul movimento del ’77, che privilegiò una rappresentazione diretta di se stesso rifiutando ogni tipo di narrazione altra. Le foto di Tano D’Amico, che comunque lasciano trapelare una realtà ben altrimenti frastagliata rispetto a quella celebrativa, continuano a essere usate, ma non in modo esclusivo. Non è forse senza significato che, a riprova dell’ambivalenza (se non proprio dell’ambiguità) documentaria delle immagini, sia uscito un libro che ricostruisce proprio i retroscena della foto simbolo del ’77, su cui tornerò più avanti, quella del ragazzo, solo in mezzo alla strada, volto coperto dal passamontagna, che spara impugnando la P38 con entrambe le mani.
Tuttavia il ’77 appare ancora un passaggio opaco, un oggetto misterioso e sfuggente, diverso da luogo a luogo nei tempi e anche nei modi; un passaggio che non ha ancora trovato una collocazione equilibrata nella storia degli anni Settanta e più in generale nella storia della Repubblica, al di là dell’ansia definitoria che lo ha accompagnato sin dal suo sorgere. Senza tenere conto della pluralità di scenari, protagonisti e temi che lo caratterizza, lo si continua a mettere in relazione al secolo breve inteso in senso riduttivo come secolo della violenza e delle ideologie, o all’età postmoderna, concepita in senso non meno riduttivo come la sua negazione, in positivo o in negativo che sia. In ogni caso ne è risultato largamente confermato, come si è detto, il valore periodizzante del movimento del ’77, la convinzione cioè che esso rappresenti uno snodo in cui vecchio e nuovo, pur diversamente dosati a seconda dei punti di vista, si sovrappongono.
Vorrei discutere criticamente proprio questa convinzione, ponendo un quesito forse un po’ provocatorio in questa sede, cioè se e quanto legittimo sia sul piano storico e storiografico tematizzare il movimento del ’77. Nel senso che – comunque lo si faccia – questa operazione implica l’isolamento del ’77 da quanto lo precede e da quanto lo segue. Il fatto è che, come ha ricordato Diego Giachetti, «il ’77, per essere raccontato ha bisogno di una narrazione storica, vuole un “prima” e un “dopo”, ha bisogno di un richiamo ai precedenti e agli esiti, non sta da solo». Non si finisce in fondo per appiattirsi sulla sua autorappresentazione? «Non abbiamo né passato né futuro – era scritto lungo una parete dell’Università romana – La Storia ci uccide». Non inserire il ’77 tra i movimenti, come fa Marica Tolomelli in un recente volume, è in sé discutibile, ma può avere un suo fondamento proprio in questo senso.
Dopo il libro di Guido Crainz, Il paese mancato, che per primo ormai quasi quindici anni fa ha riservato al ’77 uno spazio autonomo all’interno del cosiddetto “lungo ’68”, le più recenti sintesi di storia repubblicana gli dedicano un’attenzione assai più distratta. Privilegiando i suoi aspetti simbolici e rappresentativi, gli studi attribuiscono ora al ’77 un ruolo simile, fatte le opportune differenze, a quello del caso Moro che, trasformato in un capitolo a sé della storia della lotta armata, ha assunto il significato periodizzante di fine della prima Repubblica. La cacciata di Lama, simbolo del ’77, è considerata l’atto fisico, non solo simbolico, che sancì la rottura irreversibile del Pci con il mondo giovanile che stava alla sua sinistra; e che, più in generale, annunciò la fine della Repubblica dei partiti, per le analogie con quanto accadde con l’esecuzione di Aldo Moro all’interno della Dc. Si trattò quindi di due parricidi che – estendendo la lettura che Miguel Gotor ha fatto del sequestro Moro attraverso il percorso delle lettere e del memoriale della prigionia – hanno acceso una forte ipoteca sul futuro del paese, ostacolando il percorso che avrebbe condotto al compromesso storico.
Il dramma di Moro diventa il dramma della Repubblica stessa, che con lo statista sembra perdere l’unica alternativa credibile al governo esclusivo della Democrazia cristiana, in grado di riscattare la Repubblica dai vizi eversivi che ne minavano le fondamenta. Insieme alla Dc di Moro ne fu vittima il Pci di Berlinguer, messo in grave difficoltà nella sua aspirazione al governo dall’esplosione del ’77, oltre che dal terrorismo ingravescente del periodo immediatamente successi...