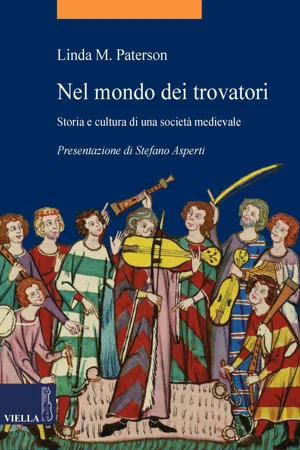![]()
1. Introduzione. Occitania: identità e coscienza di sé
«Occitania» è una parola poco familiare alla maggior parte di coloro che vivono fuori della Francia e anche a molti francesi. Eppure, quasi certamente, tutti hanno sentito parlare dei trovatori, quei poeti-musici medievali che “inventarono” l’amor cortese e influenzarono profondamente l’arte poetica e il sentimento amoroso in Europa dal XII secolo ai giorni nostri. Essi vengono di solito associati con la Provenza o con il Sud della Francia, ma la Provenza rappresenta, oggi come allora, solo una piccola parte della loro terra d’origine, che si estendeva dai Pirenei e dalle Alpi fino all’Alvernia e al Limosino. L’espressione stessa “Sud della Francia” implica in realtà l’esistenza di uno Stato-nazione che è ben lungi dal rispecchiare la realtà dell’epoca. L’annessione di larga parte dell’Occitania alla Francia, avvenuta con l’invasione francese durante la crociata contro gli albigesi all’inizio del XIII secolo, fu un risultato del tutto imprevedibile in quanto, sotto molti aspetti, l’Occitania aveva legami più stretti e più naturali con i suoi vicini mediterranei e in particolare con la Catalogna.
Per chi definisce una regione sulla base di demarcazioni politiche l’Occitania non è mai esistita, dato il carattere politicamente indipendente, conflittuale e instabile dei territori che la costituivano. Fino all’epoca della crociata contro gli albigesi agli inizi del Duecento, i principali aspiranti al potere furono i duchi di Aquitania, i conti di Tolosa e i re d’Aragona-Catalogna. Quando Guglielmo IX arrivò al potere nel 1086, i duchi di Aquitania, pur essendo nominalmente vassalli dei re capetingi di Francia, controllavano di fatto una fetta più vasta della Francia attuale, amministrando il Poitou e l’Aquitania fino ai Pirenei.
Tutto questo territorio passò ai Plantageneti nel 1152, dopo il matrimonio di Eleonora d’Aquitania con il futuro Enrico II d’Inghilterra, asceso al trono nel 1154. La Linguadoca, da Tolosa al Rodano, era sotto il dominio dei conti di Tolosa. L’Aragona e la Catalogna, unite nel 1137 sotto Raimondo Berengario IV, possedevano il Rossiglione e le enclaves dell’alta Linguadoca; per tutto il secolo XII i suoi conti-re lottarono con i conti di Tolosa per il controllo della Provenza, spinti dall’ambizione di creare uno Stato mediterraneo che si estendesse dalla Garonna e dall’Ebro fino alle Alpi. L’Occitania comprendeva anche molte altre regioni indipendenti o semiautonome, quali le baronie pirenaiche di Béarn, Bigorre, Comminges e Foix, o l’Alvernia, in teoria dipendente in linea diretta dal ducato di Aquitania piuttosto che dalla corona francese, che riuscì a strappare ai Plantageneti il controllo nominale della regione solo nel tardo XII secolo. Molte città si sottrassero all’autorità dei principali signori territoriali: Albi, Carcassonne, Béziers, Agde e Nîmes erano controllate dalla potente famiglia dei Trencavel, Narbona e Montpellier godevano di una loro amministrazione indipendente, Marsiglia mantenne la sua autonomia dalla Provenza fino al 1252, mentre Tolosa, la sola città di una certa rilevanza a parte Saint-Gilles, teoricamente sotto il controllo dei conti di Tolosa, verso la fine del XII secolo stava per diventare una repubblica indipendente.
L’identità dell’Occitania non sta tanto nelle sue demarcazioni politiche quanto nella sua lingua e nella sua cultura.. L’occitano è una lingua romanza o neolatina, come il francese, il catalano, il francoprovenzale, il castigliano, il portoghese, l’italiano, il sardo, il romeno, il ladino e il dalmatico. La sua estensione geografica non ha subito mutamenti significativi a partire dal Medioevo, sebbene il numero delle persone madrelingua sia drasticamente diminuito. Nelle regioni pirenaiche la lingua occitana si avvicina al basco nelle zone sudoccidentali, al castigliano in quelle meridionali e al catalano in quelle sudorientali. A nord la frontiera linguistica inizia alla confluenza della Garonna con la Dordogna e segue il corso della Gironda verso settentrione, fino a includere il Limosino e parte della Marca e dell’Alvernia, tagliando il Rodano sopra Valence e passando a sud di Grenoble fino a raggiungere la frontiera italiana. A partire da qui, con l’eccezione di alcune enclaves a dialetto francoprovenzale nella Valle d’Aosta e a Susa, essa coincide con la frontiera politica fino al Mediterraneo. A nord-est la frontiera occitanica esclude parte del Delfinato il quale, insieme alla Savoia, alla Svizzera occidentale e alla Franca Contea, costituisce l’area linguistica francoprovenzale. Un’area di interferenza fra l’occitano e il francese, nota come la «mezzaluna», comprende parti dell’Angoumois, del Poitou, del Limosino, del Berry, della Marca, dell’Alvernia e del Borbonese. La sfera linguistica dell’occitano occupa perciò, con poche aggiunte ai margini, approssimativamente un terzo della Francia attuale.
Nel Medioevo la lingua d’oc era definita in contrapposizione ad altre lingue. A partire dal XII secolo i trovatori usavano talvolta l’espressione lengua romana per distinguerla dal latino; nel XIII e XIV secolo alcuni documenti amministrativi la chiamavano roman, in contrasto con la langue du roi, e i testi letterari la opponevano al frances. Il grammatico catalano Raimon Vidal de Besalú la chiamò lemosi in opposizione alla parladura francesca; il termine proensal o proensales sembra invece essere stato preferito dagli italiani, per i quali la Gallia meridionale era ancora la Provincia romana i cui abitanti, i provinciales, venivano distinti dalle gentes francigenae della Francia del Nord. A quanto pare, è stato Dante il primo a usare l’espressione lingua d’oc, opponendola alle lingue d’oïl e del sì («sì» in occitano, francese e italiano). Nel XIV secolo il termine “occitano” veniva usato dall’amministrazione ufficiale in espressioni quali lingua occitana, respublica occitana, patria linguae occitanae e Occitania. Anche se oggi, nella Francia del Sud, Occitan non è privo di implicazioni politiche, la gran parte dei medievisti continua a preferirlo perché evita l’ambiguità di termini che si riferiscono a una qualsiasi piccola parte dell’insieme più vasto.
Culturalmente l’identità medievale dell’Occitania è rappresentata dai trovatori, i quali, con la loro produzione letteraria, valicarono i confini linguistici or ora descritti. Essi infatti non solo si misero in viaggio alla ricerca di protezioni, specialmente verso il Nord della Spagna e l’Italia, ma la loro lingua fu adottata da Alfonso II d’Aragona come lingua letteraria ufficiale di corte nell’ambito della sua ambiziosa strategia di espansione politica in Provenza.
Si sono scritti molti libri sui trovatori: questo però, anche se motivato dal desiderio di comprendere in tutti i suoi aspetti la società in cui vivevano, intende essere diverso dagli altri. Si parlerà di trovatori solo quando risulterà funzionale il citarli, poiché, diversamente, si dovrebbe dedicare loro l’intero volume. Ma che percezione essi avevano della propria identità geografica, politica ed etnica?
Il loro mondo geografico è delimitato dall’Islanda a nord, dal Nilo a sud e dall’Ungheria e dalla Terrasanta delle crociate a est, diviso tra cristiani e pagani, avendo solo una vaga idea delle proprie frontiere geografiche. Diversamente dagli scrittori in lingua romanza della Francia del Nord, i trovatori sono poco interessati al mitico Oriente ma hanno un’idea piuttosto chiara dell’identità regionale del mondo cristiano. Per esempio, la Canso d’Antiocha, testo occitanico del XII secolo, menziona crociati venuti da circa trenta regioni: normanni, pittavini, borgognoni, provenzali, limosini, baschi, germani, gallesi, irlandesi, danesi e così via. Ma al di là delle terre abitate dai loro principali sostenitori – Occitania, Spagna, Francia e Italia – le “regioni” sono essenzialmente paesi come l’Inghilterra, l’Irlanda, la Scozia, il Galles, la Germania o “l’Impero”, il Portogallo. La Francia è sempre percepita come un paese straniero; Italia significa l’antica Lombardia o le sue singole città indipendenti: Milano, Pavia, Cremona, Asti, Genova, Verona, Ravenna e Faenza. Le regioni più note al di fuori dell’Occitania sono quelle della Penisola iberica: Portogallo, Galizia, ma soprattutto Castiglia, Navarra, Aragona e Catalogna.
Dal punto di vista linguistico, i trovatori percepiscono come straniero il bretone, l’inglese, il germanico, il frisone, il fiammingo, l’angioino, il bavarese, il greco, lo scozzese e il gallese. A parte l’idioma dell’Angiò, le parlate della Francia settentrionale, della Spagna e dell’Italia non suscitano alcun commento esplicito sulla loro difficoltà. Alcuni autori catalani e occitanici capivano certamente il francese, e il poeta del Girart de Roussillon tentò di fonderlo con l’occitano. I frequenti scambi fra trovatori in Occitania, Italia e Spagna crearono un certo internazionalismo oltre che interesse per le lingue straniere e l’abilità nel parlarle, evidenti, per esempio, nei componimenti plurilingue; la cosa però non era condivisa dai francesi, di vedute meno larghe. All’interno dell’Occitania, le differenze linguistiche locali dovevano essere considerevoli: nel XIV secolo, per esempio, gli abitanti del villaggio pirenaico di Montaillou erano consci di esprimersi in un dialetto locale parlato al massimo da un migliaio di persone.Le differenze dialettali all’interno dell’Occitania sembrano tuttavia aver avuto una parte minima o nulla nella cultura trobadorica, dato che fin dall’inizio i trovatori si servirono di un linguaggio letterario, o koiné.
Dal punto di vista etnico i trovatori si definiscono in contrapposizione ai saraceni e agli ebrei. Nonostante esistano testimonianze non letterarie di una certa tolleranza razziale nel Sud, i poeti occitanici mostrano pochi segni di questa tanto decantata convivencia. Di tanto in tanto la loro letteratura descrive saraceni amichevoli provenienti dalla Spagna o dall’Oriente, ma si tratta di eccezioni; di solito i musulmani appaiono nel loro stereotipo negativo. La Canso d’Antiocha, in sintonia con altre opere sulle crociate, ne dipinge alcuni di pelle nera, con le gole, gli occhi e le palme rosso sangue, divoratori di carne cruda e latranti come cani. Gli ebrei sono marchiati come gli uccisori di Cristo, malvagi, avari, la feccia della società.
Anche se i poeti occitanici condividono i pregiudizi etnici e religiosi del mondo cristiano, raramente evocano persistenti stereotipi etnici all’interno della parte cristiana del loro mondo. Essi associano certe regioni o città ad alcuni tipi di attività o di prodotti; Montpellier ad esempio è legata all’oro, Narbona ai tessuti, Châtillon ai tagliapietre e così via. Certe regioni erano note per una loro particolare specializzazione militare come la Guascogna, la Navarra e i Pirenei per i lanciatori di dardi. Altre erano rinomate per talune peculiarità artistiche o giullaresche: Guerau de Cabrera rimprovera al giullare Cabra di non saper concludere un brano musicale con una modulazione bretone, o danzare e fare giochi di prestigio come un giullare guascone. Ma certe definizioni etniche quali «pittavini panciuti» o «socievolezza catalana» nascerebbero dalla contingenza di un conflitto politico o dal clientelismo. Prima della crociata contro gli albigesi, i clichés più frequenti sono quelli riferiti ai bretoni, per la loro celebre e illusoria «speranza bretone» e il dolore per la morte di Artù. Essi vengono anche accomunati ai normanni come giullari molesti.
Fu la crociata contro gli albigesi che generò consapevolezza politica e insofferenza per l’occupazione straniera, dando vita allo stereotipo del francese avvinazzato, ostile, rancoroso, avido, sadico e tirannico. Fonti non occitaniche rafforzano l’immagine del francese ubriacone con gli occhi iniettati di sangue. A partire dalla fine del XII secolo, alcuni trovatori associano i francesi alla prodezza nelle armi contrapposta alla gioia di vivere degli occitani. Questo corrisponde a una vera e propria separazione nella percezione dei valori; in quest’epoca, infatti ideali e rituali cavallereschi erano ben radicati in Francia, mentre avevano avuto scarsa incidenza al Sud.
Alcune tenzoni occitaniche mettono a confronto gente di diverse regioni. All’epoca della crociata contro gli albigesi, i trovatori Monge e Albertet composero un partimen su chi fosse superiore tra i francesi e gli occitani.Monge esalta il più alto tenore di vita dei francesi, la loro liberalità, la migliore qualità del cibo, degli abiti e delle armature e inoltre la loro abilità come soldati. Denigra invece gli occitani definendoli poveracci, briganti avidi e buffoni cortigiani. Albertet, per contro, loda l’ospitalità aperta e generosa, la gaiezza e la socievolezza della gente del Sud, e la propensione a contendersi l’eccellenza della reputazione con le parole e le azioni; sostiene che gli occitani furono i primi a inventare l’arte del ricevere, mentre un ospite in Francia o nel Poitou avrebbe potuto tranquillamente morire di fame. Dei francesi critica la scontrosità e la mancanza del senso di ospitalità. Una tenso tra Raimon de las Salas e un Bertran, in data successiva all’agosto 1216, pone la seguente questione: chi, tra i lombardi e i provenzali, è migliore nel guerreggiare, offrire feste, elargire doni?Raimon loda i giullari e le dame provenzali, screditando come grosse e scontrose le donne lombarde. Bertran ribatte sostenendo che i lombardi non amano l’ostentazione e i piaceri offerti dai giullari e dalla compagnia femminile che inducono all’adulterio e provocano le nascite di bastardi riconosciuti da mariti ignari. Questa discussione riprende il tema di una tenso bilingue tra Raimbaut de Vaqueiras e una donna genovese, composta verso il 1190. Alle profferte amorose di un provenzale che parla nella propria lingua, la genovese replica non solo in volgare italiano, ma in un tono che respinge l’urbanità del suo interlocutore. Rifiutando le sue proposte e...