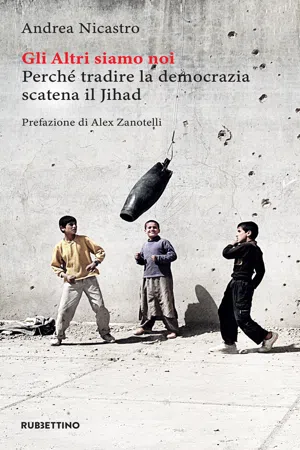![]()
Atto 1
1999. La palestra cecena
O di come l’islamismo si innestò sul nazionalismo
Il kafir, qui, ha paura di morire.
Tutti i kafir hanno paura di morire.
Allah o Akbar, vinceremo la guerra1
Con la caduta del Muro di Berlino (1989) e la fine della guerra fredda, l’Urss implode. C’è una serie infinita di film d’azione, 007 compreso, che elaborano la paura di quegli anni per il traffico di testate atomiche. Per la prima volta da decenni il Cremlino è inerte: da una parte il mondo trema all’idea che il nuovo zar Boris Eltsin perda il controllo dei missili da Armageddon, dall’altra i sudditi che per secoli hanno aspettato quel momento alzano la testa.
Nel luglio del 1991, si staccarono per primi i satelliti del Patto di Varsavia (l’equivalente comunista della Nato: dalla Polonia all’Ungheria, dalla Romania alla Bulgaria). Poi, tra agosto e dicembre, ottennero l’indipendenza anche alcune Repubbliche sovietiche.
Persino la Georgia, terra natale di Stalin, ci riuscì. Perché la Cecenia non doveva provarci? Il problema è che la Georgia sta al di là del displuvio caucasico, la Cecenia no.
Per quanto anacronistiche possano sembrare, le dottrine di difesa militare considerano ancora le montagne, gli oceani, i poli e i deserti come alleati indispensabili contro l’avanzata del nemico.
La Cecenia si estende dalle vette sul versante moscovita delle montagne del Caucaso sino alle prime pianure. Da lì, fino a Mosca, non ci sono ostacoli naturali, solo autostrade dove potrebbero correre divisioni corazzate nemiche. Pure se dissanguata, Mosca era decisa a impedire l’amputazione. L’unica soluzione per i ribelli ceceni erano le armi. E, nel 1994, cominciò la guerra.
I secessionisti erano ex ufficiali dell’Urss, ex coscritti dell’Armata rossa, spesso reduci dal decennio sovietico in Afghanistan. Si erano mai sentiti comunisti? Di certo finito l’impero rosso, impararono a sentirsi ceceni: il germe del nazionalismo era entrato nelle loro menti. Chiesi molte volte che cosa significasse essere ceceni, che cosa li rendesse diversi dai russi visto che mangiavano, bevevano, studiavano, vestivano come russi da almeno tre generazioni. Rispondevano ricordando le deportazioni staliniane, i combattimenti antichi contro gli zar, parlavano dell’importanza del “ceceno”, una lingua che avevano usato (talvolta) solo in casa. Gli ingredienti identitari erano molto “familiari”, aneddotici. Qualcuno citava, infine, anche la religione musulmana.
I ceceni vincono la prima guerra d’indipendenza (1994-1996): la Cecenia è libera dal giogo russo, ma la capitale Grozny è distrutta, il Paese è alla fame, le famiglie in lutto. Il Cremlino abbandona la battaglia perché la Russia non sopporta un’altra guerra di guerriglia dopo quella persa in Afghanistan pochi anni prima, nel 1989. Assieme ai nazionalisti ceceni, Mosca si è ritrovata a combattere le stesse brigate islamiste che l’avevano tenuta in scacco in Afghanistan. Per aiutare i fratelli ceceni, che dopo settant’anni di ateismo di Stato riscoprono la fede dei bisnonni, si è infatti riattivata la rete della guerra santa internazionale. Arrivano a Grozny combattenti del jihad afghano, ma anche volontari da Egitto, Giordania, Pakistan, Golfo. E con loro armi e finanziamenti di quei difensori della “vera fede” che pochi anni prima si erano mobilitati per salvare l’Afghanistan dal comunismo e ora si impegnavano per Grozny.
Nel 1994 i russi sanno solo combattere alla vecchia maniera e lo fanno anche piuttosto male per mancanza di attrezzature, soldi, motivazione. La televisione satellitare Russia Today (Rt) sarà costituita solo dieci anni dopo e la capacità russa di influenzare i social media era, all’epoca, ancora tutta da immaginare Per Mosca la prima guerra cecena si traduce in un disastro come numero di perdite e come immagine internazionale. Così nel ’96 Boris Eltsin preferisce trattare con gli indipendentisti, ottenere una pace qualunque e concentrarsi su quel che gli sta più a cuore: la dismissione del sistema industriale sovietico. A fianco di Eltsin, però, sta crescendo Vladimir Putin, giovane ex agente del Kgb, che ha ben chiara la necessità di ricostruire la “verticale del potere” e un’“area imperiale russa”.
Nel 1999 l’influenza di Putin arriva a maturazione e per la breve indipendenza cecena è un bagno di sangue. La Russia torna padrona.
Oggi, vent’anni dopo, Grozny è tirata a lucido dai milioni elargiti dal Cremlino al presidente collaborazionista che ha costretto i ribelli ad arrendersi. Con l’aiuto delle sue truppe, Mosca ha imprigionato, torturato e ucciso i parenti dei guerriglieri indipendentisti sino alla settima generazione. Uno stile di counter-insurgency spietato, ma tanto efficace da convincere i combattenti alla resa. Chi scendeva dalle montagne e abbandonava le armi aveva salva la vita. Chi rifiutava aveva la famiglia sterminata. Solo i jihadisti stranieri hanno continuato a combattere. La rivincita russa nel Caucaso è un caso bellico poco studiato: dove la religione aveva battuto lo Stato, la famiglia ha sconfitto la religione. Tra i luccicanti grattacieli della città ricostruita, si respira, ancora oggi, un’atmosfera di schiavitù, paura e rancore.
In bus col fondamentalista
Arrivai in Cecenia per la prima volta nel 1999, all’inizio della riscossa putiniana. Ero stato invitato con altri colleghi stranieri dal governo locale che voleva mostrare al mondo l’aggressione che stava subendo dai russi. La capitale cecena aveva appena cambiato nome per diventare Dzhokhar Gala, in onore del generale Dzhokhar Dudayev, ucciso subito dopo aver dichiarato l’indipendenza nel 1992. Quel nome era l’unica cosa nuova dell’intero Stato. Nulla era stato ricostruito dopo i bombardamenti russi del ’94-96. Si viveva in palazzi sventrati. Bastava un telo di plastica, un muro di mattoni recuperati e si tornava ad abitare l’appartamento devastato, mettendo le tendine sul cellofan che sostituiva i vetri e stendendo i panni da un lato all’altro della voragine lasciata da una cannonata.
Il presidente Aslan Maskhadov doveva proteggere i giornalisti in visita, ma non aveva neppure una divisa per la sua Guardia d’élite. «A farli soldati bastano mitra e lanciarazzi che tengono a tracolla, le giberne piene di bombe a mano e l’orgoglio di aver già una volta piegato l’Armata rossa»2.
Gli incubi del presidente Maskhadov erano due: i nemici e gli alleati. I nemici erano i russi e ne conosceva la crudeltà e l’arsenale bellico. Gli alleati erano i jihadisti e per i nazionalisti come Maskhadov erano quasi peggio dei primi.
Tra i combattenti dell’Islam c’era un giordano che si faceva chiamare emiro Khattab. Aveva formato un’enclave tra le valli cecene dove imponeva la Sharia, la legge islamica, secondo l’interpretazione radicale dei suoi finanziatori del Golfo. Un altro era ceceno solo a metà, aveva le stesse ambizioni di controllo sociale di Khattab, ma progetti militari più vasti. Si chiamava Šamil Basaev.
Basaev aveva lasciato il comunismo per il nazionalismo e il nazionalismo per l’islamismo. Qualcuno dice che l’avesse fatto per soldi, perché così riceveva petrodollari dalla jihad bank sempre pronta a investire su qualsiasi combattente.
Al mio ingresso in Cecenia la loro fama sta lievitando. Man mano che la barba di Basaev si conforma ai precetti dei Wahabiti, i fondamentalisti del Golfo, aumentano i fondi a disposizione e le azioni diventano più audaci. Il progetto di Basaev è di esportare il jihad anche nelle altre aree musulmane dell’ex Urss, galvanizzare i credenti, far loro capire che Mosca, ormai senza il collante dell’ideologia comunista, non è imbattibile e basta il coraggio di un martire per mettere in ginocchio la macchina bellica russa.
Basaev diventerà famoso per stragi tanto drammatiche quanto spettacolari e mediatiche, mai tentate prima degli attentati dell’11 settembre a New York.
Basaev cattura 1600 ostaggi nell’ospedale di Budënnovsk (Russia) e nonostante 129 morti ne esce illeso. Sequestra una scuola a Beslan (Ossezia del Nord): lo scontro tra i suoi guerriglieri e gli agenti Omon russi finisce per uccidere 350 tra bambini e insegnanti. Sequestra persino, nel cuore di Mosca, il teatro Dubrovka. Il Cremlino chiama a trattare anche la giornalista dissidente Anna Politkovskaja, ma alla fine intervengono le forze speciali e i morti sono 168.
Nell’ottobre 1999, però, Basaev è ai suoi esordi. Ha appena compiuto scorrerie oltre il confine ceceno, nel Daghestan russo, per tentare di aizzare la popolazione musulmana. Ha sbagliato interlocutore oppure segue la logica del tanto peggio tanto meglio perché il Cremlino reagisce invadendo di nuovo la Cecenia. I nazionalisti come Maskhadov sono in difficoltà. Il presidente si trova in casa un alleato che ha provocato l’invasione, che non obbedisce ai suoi ordini e potrebbe anche cercare di ucciderlo. Allo stesso tempo, però, quell’alleato gli è indispensabile per resistere al ritorno russo. Maskhadov sa di essere debole: è scomparsa ogni autorità centrale, il Paese è ormai un «mosaico di feudi familiari»3.
La Guardia di Maskhadov è più nervosa quando attraversa il territorio controllato dai jihadisti che quando passa in un’area in mano ai russi di cui almeno conosce la scarsa voglia di combattere e la facilità con cui li si può corrompere.
Durante un trasferimento, sull’autobus dei reporter scortato dagli uomini del presidente, salgono due giovanissimi guerriglieri di Basaev per fare da garanti dell’incolumità di tutti. Hanno la barba rada, con i peli lunghi di chi non se l’è mai tagliata.
Uno, di nome Haris, alto e secco, appoggia il kalashnikov al sedile, con la bocca attaccata alla mia nuca. Il bus sobbalza, traballa, si muove e il kalashnikov rimbalza su e giù. E se parte un colpo?
Mi giro e gli chiedo di spostare la canna. Haris prima non capisce, poi guarda perplesso, infine lo sguardo si fa irridente. Ha capito.
...