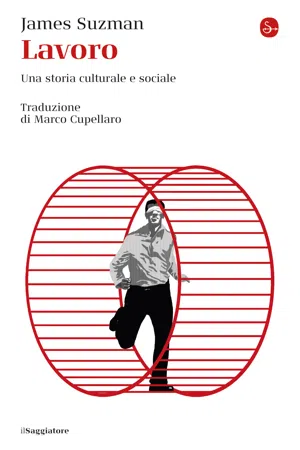![]()
PARTE QUARTA
Creature della città
![]()
11. Luci della città
Nell’agosto 2007 Thadeus Gurirab infilò in un borsone consunto qualche vestito e una copia laminata del suo diploma scolastico e lasciò la piccola fattoria di famiglia, nella Namibia orientale, per trasferirsi nella capitale, Windhoek. I genitori di Thadeus avevano sempre saputo che la loro minuscola fattoria non sarebbe mai stata in grado di sostentare più di una famiglia, e avevano fatto di tutto perché Thadeus, secondo di quattro figli, andasse a scuola per avere la possibilità di trovare «lavoro in città».
Al suo arrivo a Windhoek Thadeus andò nella casa in cui abitavano lo zio paterno e la moglie, la madre di quest’ultima e i loro tre figli. Vivevano tutti in una baracca di lamiera ondulata, su un «terreno» pieno di sassi a Havana, un vasto insediamento abusivo in collina, alla periferia della città.
Dopo più di un decennio, Thadeus vive ancora lì. I suoi zii sono andati via nel 2012, lasciandogli la terra. Ora ha un «doppio lavoro», fa l’addetto alla sicurezza, e anche il custode di una delle tante chiese evangeliche in cui gli immigrati urbani si riuniscono ogni domenica a pregare per la buona sorte. E arrotonda le entrate affittando un’altra baracca di lamiera ondulata, che ha costruito sullo stesso terreno: uno spazio, sufficiente appena per un materasso singolo, in cui vivono due giovani arrivati di recente dall’Est, che fanno anch’essi le guardie giurate: uno dorme lì di giorno e fa il turno di notte, e l’altro lavora di giorno e dorme la notte.
Thadeus è soddisfatto di questa soluzione: in questo modo, a casa sua c’è sempre qualcuno che tiene d’occhio le cose. Dal 2012 Havana è quasi raddoppiata e non è più sicura come una volta. Thadeus spiega che le affollatissime colline su cui si affaccia la baracca quando arrivò lui erano ancora disabitate. E poiché per i nuovi arrivati trovare lavoro è molto difficile, non hanno altra scelta che chiedere l’elemosina o rubare.
Con una popolazione di appena mezzo milione di persone, periferia compresa, Windhoek è molto più piccola di tante altre metropoli: eppure anche lì le cose sono andate – su scala minore – come negli altri paesi in via di sviluppo.
Nel 1991 quasi tre quarti dei namibiani vivevano in campagna. In poco più di un quarto di secolo il numero totale di abitanti della Namibia è quasi raddoppiato. Ma mentre la popolazione rurale è cresciuta di un quinto, la popolazione urbana è quadruplicata, soprattutto per l’arrivo di quelli come Thadeus, che si trasferiscono in città perché le campagne sono troppo affollate. Il risultato è che oggi il numero dei namibiani che abitano in città è pari a quella che nel 1991 era la popolazione totale del paese. E poiché il governo non ha risorse finanziarie per avviare un programma di alloggi sociali, e il tasso di disoccupazione giovanile si aggira intorno al 46 per cento, la maggior parte di questi nuovi arrivati deve accontentarsi di vivere in borgate abusive come Havana.
Nel 2007 Thadeus è stato uno dei 75 milioni di nuovi abitanti delle città stimati per quell’anno nel mondo, la maggior parte dei quali, proprio come lui, hanno lasciato una casa in campagna per tentare la sorte in città più o meno grandi. Ognuno di loro ha dato un piccolo contributo al superamento di un’importante soglia storica della nostra specie: all’inizio del 2008, per la prima volta da quando esiste l’uomo, nelle città vivevano più persone che nelle campagne.
La rapidità con cui è avvenuta questa transizione da specie scarsamente interessata a modificare il proprio ambiente a specie che vive in vaste e complesse colonie fabbricate, è unica nella storia evolutiva. L’urbanizzazione delle termiti, delle formiche e delle api è durata milioni di anni, mentre tra gli umani tutto è accaduto – dal punto di vista evolutivo – in un batter d’occhio.
Percentuale della popolazione mondiale
che vive in aree urbane, 1500-2016.3
Ma anche se gli umani solo di recente sono diventati quelle che nella lingua degli ju|’hoan venivano definite «creature cittadine», le città sono state fin dall’antichità – da quando in Medio Oriente, Cina, India, Mesoamerica e Sud America iniziarono a coagularsi i primi piccoli centri urbani – dei crogioli di creatività, d’innovazione, di potere e di diversità. E hanno influito sulle vicende umane in misura più che proporzionale alla propria popolazione. Fino alla Rivoluzione industriale le città non erano quasi mai state più di un quinto della popolazione totale di una regione, eppure avevano già da oltre 5000 anni un ruolo decisivo nel determinare la traiettoria della storia umana.
La maggior parte dei capitoli più recenti della storia della trasformazione in specie urbana dell’Homo sapiens sono stati redatti nella calligrafia estemporanea delle caotiche e affollate bidonville che, come Havana, si sviluppano ai margini delle città grandi e piccole nei paesi in via di sviluppo. In queste baraccopoli vivono oggi fino a 1,6 miliardi di persone. Le più grandi – come Kibera in Kenya, Ciudad Nezahualcóyotl fuori Città del Messico, Orangi Town in Pakistan e Dharavi a Mumbai – contano milioni di abitanti e sono una sorta di città nella città. Esse sviluppano una ragnatela di chilometri e chilometri di strade al di fuori di qualsiasi pianificazione, e crescono così velocemente che le amministrazioni municipali, nel migliore dei casi, possono tentare di inseguirle prendendo freneticamente appunti per calcolare se sia possibile, e quanto costerebbe, adeguare a posteriori alla situazione effettiva servizi di base come l’acqua, le fognature e l’elettricità.
Altri capitoli recenti nella storia della nostra fuga nelle città sono scritti in modo molto più ordinato. La cosa che colpisce di più è lo stile sovradimensionato degli urbanisti e architetti cinesi di oggi. Quarant’anni fa, quattro cinesi su cinque vivevano in campagna; oggi tre su cinque vivono e lavorano in edifici di vetro, cemento e acciaio, sorti perlopiù attorno a strade asfaltate, larghe e diritte, servite da un’infrastruttura idrica, energetica, di nettezza urbana e trasporti ben integrata. Lo spostamento di 250 milioni di cinesi dalle regioni rurali alle città, tra il 1979 e il 2010, per cercare lavoro in un settore manifatturiero cresciuto con straordinaria rapidità, è stato il più grande evento migratorio della storia dell’umanità, e ha provocato non soltanto la comparsa quasi improvvisa, dal nulla, di «città fantasma» per il momento sottoutilizzate, ma ha anche visto città consolidate espandersi nelle campagne, inghiottendo un gran numero di tranquilli borghi rurali, villaggi, fattorie e cittadine.
Per Vere Gordon Childe la «rivoluzione urbana» coincise con la seconda e cruciale fase della rivoluzione agricola. La prima fase fu imperniata sul processo, penosamente lento, di una domesticazione di animali, cereali e altre colture vegetali avvenuta nell’arco di moltissime generazioni, all’insegna del progressivo sviluppo e affinamento di tecnologie semplici come l’irrigazione artificiale, l’aratro, gli animali da tiro, la produzione di mattoni e la metallurgia, che «accrebbero tangibilmente il benessere biologico della nostra specie, facilitandone la moltiplicazione».
Al contrario, la fase urbana, sosteneva Childe, iniziò solo nel momento in cui la produttività agricola superò una soglia critica e gli agricoltori riuscirono a produrre eccedenze abbastanza ampie da poter mantenere burocrati, artisti, politici e altre figure che essi molto generosamente non consideravano semplicemente «parassiti». Questa fase fu contrassegnata dalla comparsa di città rifornite da mercanti, governate da monarchi e amministrate da preti, soldati e burocrati.
Childe aveva quasi certamente ragione, almeno in una prospettiva di storia del lavoro. Le città antiche nacquero solo quando gli agricoltori locali furono in grado di produrre dei surplus di energia sufficienti a offrire un sostentamento affidabile a vaste popolazioni che non dovevano lavorare nei campi. E dove l’energia era abbondante, essa fu usata – nello stesso modo dei tessitori mascherati africani – per costruire dapprima grandi architetture monolitiche, come Göbekli Tepe o Stonehenge, e in seguito vere e proprie città e metropoli.
Le prime grandi città, in Asia, in Medio Oriente e nelle Americhe, furono tanto accidenti della geografia quanto testimonianze di ingegnosità delle popolazioni locali. Sia in Papua Nuova Guinea sia in Cina, per esempio, le sperimentazioni in campo agricolo iniziarono tra 10 000 e 11 000 anni fa. Ma mentre 4000 anni fa gli agricoltori cinesi, avendo avuto la fortuna di domesticare riso e miglio ad alta resa, generavano ormai stabilmente eccedenze sufficienti a istituire e mantenere la prima serie di dinastie imperiali urbane, gli agricoltori della Papua Nuova Guinea, sulla base dei rendimenti energetici ben più modesti della coltivazione di taro e igname e dell’allevamento di maiali, non riuscirono mai ad andare oltre lo sviluppo di villaggi un po’ più grandi degli altri. Solo in epoca coloniale, con l’importazione in Nuova Guinea di cereali ad alto rendimento come il riso, divenne possibile avere qualcosa di simile a una città vera e propria. Anche i mesoamericani furono ostacolati dall’assenza di piante alimentari ad alto rendimento, e soltanto quando, meno di 1000 anni fa, dopo migliaia di generazioni di selezione artificiale, il mais iniziò a somigliare alla coltura ad alto rendimento che oggi conosciamo, generarono eccedenze abbastanza grandi da mantenere delle città.
Accanto al fattore fortuna legato alle cultivar autoctone, le altre due variabili importanti dell’equazione geografica furono il clima e la topografia. Non è un caso se le prime città del Medio Oriente, del Sudest asiatico e del subcontinente indiano si sviluppassero tutte in climi particolarmente propizi alla produzione cerealicola, oppure nelle piane alluvionali di grandiosi sistemi fluviali soggetti a inondazioni stagionali. Prima ancora che qualcuno comprendesse l’importanza del concime o definisse le regole per una rotazione delle colture adeguatamente organizzata, le popolazioni di queste aree contavano sulle inondazioni inviate dalle loro divinità fluviali per reintegrare lo strato superficiale dei terreni con i ricchi detriti alluvionali e materiali organici trasportati verso valle dai corsi d’acqua.
Più o meno allo stesso modo in cui alcuni scienziati ipotizzano che l’entropia abbia reso quasi inevitabile la comparsa della vita sulla Terra, la storia suggerisce che anche la creazione di città più o meno grandi fosse inevitabile ovunque gli uomini diventassero produttori di cibo sufficientemente efficienti.
Come gli organismi viventi, anche le città nascono, si alimentano e crescono catturando energia e mettendola a compiere lavoro. E quando, per un motivo o per l’altro, non sono più in grado di assicurarsi l’energia di cui hanno bisogno, anch’esse, come organismi privati dell’aria, del cibo o dell’acqua, si arrendono all’entropia, si decompongono e muoiono. All’inizio della storia urbana della nostra specie ciò accadde più spesso di quanto si immagini. Alcune città vennero strangolate dall’assedio dei rivali. Altre morirono a causa di siccità, pestilenze e altre calamità inviate da Dio. Questa dovette essere, nell’antichità, la sorte di tanti insediamenti, città e cittadine che si presentano agli archeologi come se fossero stati abbandonati dall’oggi al domani senza alcuna ragione evidente.
Fino alla Rivoluzione industriale, anche in civiltà agricole particolarmente sofisticate e produttive, come quella dell’antica Roma, quattro persone su cinque vivevano nelle campagne e lavoravano la terra. Ma quell’abitante su cinque che viveva in città era il pioniere di un modo di lavorare completamente nuovo.
Le città, in quanto prime grandi concentrazioni di persone che non dovevano spendere tempo o fatica per produrre cibo, erano sospinte da una miscela di circostanze, curiosità e noia a trovare nuovi modi creativi per spendere le proprie energie. E come uccelli tessitori ben nutriti che l’entropia stimola a compiere lavoro, quanto più grande era l’energia che le città estraevano dai territori agrari circostanti, tanto più esse crescevano e tanto più indaffarati erano coloro che vi vivevano. Gran parte di quell’energia veniva spesa nell’approvvigionamento dell’occorrente per la costruzione, la manutenzione e il rinnovo delle infrastrutture di base. Fu così che nacquero molti nuovi mestieri specializzati legati ad attività di falegnameria, edilizia muraria e architettura, ingegneria, idrologia e costruzione di fognature. Molta energia veniva spesa anche per costruire templi e mantenere gli ordini sacri, per blandire e placare con sacrifici e tributi divinità esigenti e per raccogliere la sfida totalmente nuova del mantenimento dell’ordine all’interno di grandi concentrazioni di persone – mentre i loro antenati avevano vissuto per 300 000 anni in minuscole bande mobili. C’era bisogno di burocrati, giudici, soldati, figure specializzate nel mantenere l’ordine e dare coesione a comunità urbane con valori, credenze e obiettivi comuni.
Le leggende che narrano le origini delle città antiche, come la storia di Romolo e Remo, gemelli abbandonati e allattati da lupi prima che Romolo uccidesse il fratello e fondasse Roma, riempiono un vuoto nella nostra storia collettiva. Nella maggior parte dei casi possiamo solo speculare su come e perché un piccolo villaggio si sia trasformato prima in una cittadina e poi in una metropoli, sfruttando le possibilità create dai surplus di energia generati dall’agricoltura. Non c’è dubbio che le strade che condussero alla fondazione di antiche metropoli come Atene, Roma, Chengzhou (oggi Luoyang), Menfi in Egitto, Grande Zimbabwe e Mapungubwe nell’Africa meridionale o la Tenochtitlán che oggi giace in rovina nel sottosuolo di Città del Messico, siano state non meno numerose delle vie che entravano e uscivano da ciascuna di quelle metropoli. Alcune città nacquero quasi certamente come centri cerimoniali o punti d’incontro geograficamente ben posizionati, nei quali le persone si ritrovavano periodicamente per socializzare, venerare dèi e scambiarsi doni, idee, timori, sogni e coniugi. Altre quasi certamente, in periodi di conflitto, si agglomerarono in luoghi più difendibili, nei quali i forti potevano aiutare e proteggere i deboli e le persone subivano il fascino di leader carismatici dalle grandi ambizioni e dall’ego smisurato.
La vita e la morte delle città dipendevano da regole di comportamento comuni e dalla capacità dei cittadini di condividere esperienze, credenze e valori per estenderli poi alle stesse campagne che davano loro nutrimento.
A mano a mano che le popolazioni di coltivatori crescevano, grazie alle eccedenze energetiche, il territorio e l’accesso a risorse c...