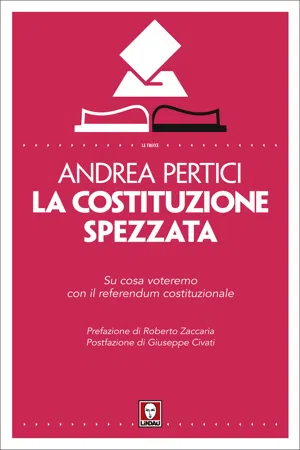![]()
1
Il percorso della revisione costituzionale
Tra il pesante passato e l’incerto presente
La comprensione del contenuto della legge di revisione della seconda parte della Costituzione, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», non pare poter prescindere da una breve ricostruzione della sua gestazione e del suo successivo cammino parlamentare, anche considerato che i lavori preparatori sono limitatissimi.
È infatti noto – ed è stato ampiamente ricordato – che la questione di una revisione della Costituzione è stata posta in Italia da ormai molti anni (sostanzialmente dalla fine degli anni ’70), divenendo oggetto di varie proposte elaborate da comitati parlamentari, commissioni bicamerali ad hoc, commissioni permanenti, comitati governativi, Governi (eventualmente con la consulenza di commissioni di esperti), che hanno generalmente prodotto scarsi risultati concreti (salvo l’effetto di far ritenere «superata» la Costituzione vigente e quindi di indebolirla).
Il testo di fronte al quale ci troviamo risente certamente di questo lungo percorso, sia nel metodo che nel merito. Dal primo punto di vista, ritroviamo, infatti, per la terza volta consecutiva (dopo quelle del 2001 e del 2005), un’ampia revisione costituzionale proposta dal Governo, la cui maggioranza procede all’approvazione anche senza il coinvolgimento dell’opposizione (i cui voti sono ritenuti benvenuti se convergono, ma la cui assenza non è vissuta con disagio). Dal secondo punto di vista, al centro sono ancora poste le esigenze di rafforzamento dell’Esecutivo e di aumento della sua stabilità (oltre che – aspetto che si è aggiunto dagli anni ’90 – un ripensamento del rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali).
Tuttavia, la legge costituzionale licenziata lo scorso aprile è anche figlia delle particolari condizioni politiche della XVII Legislatura e più in particolare, poi, del Governo che l’ha presentata. Per questo, mantenendo sullo sfondo i riferimenti a quanto accaduto nelle legislature precedenti1, riteniamo utile concentrarci, in particolare, su come la questione della riforma della Costituzione si sia posta e sia stata affrontata nei diversi passaggi di questa legislatura.
Prima tappa: i «saggi» del Presidente
Certamente il travagliato inizio della XVII Legislatura, con le note difficoltà di formazione di una maggioranza parlamentare disposta a sostenere un Governo2, aveva rilanciato la questione delle riforme costituzionali, che – come abbiamo ricordato poco fa – è in discussione da decenni ed era solo parzialmente sopita nelle ultime due legislature, dopo la bocciatura da parte degli elettori della revisione dell’intera seconda parte proposta dalla maggioranza di centrodestra nel 2006.
In effetti, il presidente Napolitano, dopo le elezioni del 24 febbraio 2013, riscontrò un sostanziale stallo nella formazione di un nuovo Governo, in quanto, soltanto grazie a un enorme premio di maggioranza, il centrosinistra era maggioranza alla Camera, ma non al Senato (a causa del differente sistema di attribuzione del premio di maggioranza), dove non solo nessuna lista o coalizione aveva la maggioranza, ma questa non poteva essere raggiunta neppure sommando le due coalizioni maggiormente disposte a governare insieme (quella di centrosinistra guidata da Bersani e quella centrista guidata da Monti).
La situazione si presentava ulteriormente complicata dal fatto che il Presidente della Repubblica, essendo a fine mandato, non poteva neppure procedere allo scioglimento anticipato delle Camere3, come normalmente fa quando non riesce a trovare una maggioranza parlamentare disponibile a sostenere un Governo. In questa situazione di impasse, il 30 marzo 2013, il Presidente decise quindi di affidare a dieci «saggi» (personalità provenienti dalla politica e dalle istituzioni), suddivisi in due gruppi di lavoro, il compito di elaborare, in contatto con i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, «proposte programmatiche in materia istituzionale e in materia economico-sociale ed europea»4. Naturalmente, in questa sede, interessa soprattutto il primo profilo, rispetto al quale il competente gruppo di lavoro presentò, dopo pochi giorni (il 12 aprile 2013), una relazione in cui dichiarava di avere selezionato «le questioni ritenute di maggior rilievo per il superamento della crisi del sistema istituzionale sulla base di valutazioni politiche, del giudizio dei costituzionalisti, dei lavori delle Commissioni parlamentari che si sono succedute nel tempo». La relazione era quindi suddivisa in sei capitoli: 1) «Diritti dei cittadini e partecipazione democratica»; 2) «Del metodo per le riforme costituzionali»; 3) «Parlamento e Governo»; 4) «Rapporto Stato-Regioni»; 5) «Amministrazione della giustizia»; 6) «Regole per l’attività politica e per il suo finanziamento», almeno i primi quattro dei quali hanno certamente specifico rilievo nella revisione costituzionale successivamente approvata. In effetti, su alcuni punti, pur con qualche differenza, il riscontro sembra piuttosto chiaro: ad esempio, risulta abbastanza simile la composizione del Senato, con l’eccezione dei senatori di nomina presidenziale, seppure significative differenze siano da registrare rispetto alle funzioni. Molti altri aspetti, invece, sono stati trascurati (ad esempio, la sfiducia costruttiva) o palesemente disattesi (dalla riduzione del numero dei deputati all’obbligo di discussione delle leggi d’iniziativa popolare alla attribuzione a un giudice indipendente e imparziale del giudizio sui titoli di ammissione dei parlamentari e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità). Infine, alcune modifiche previste dalla revisione non erano state oggetto di segnalazione da parte dei «saggi»: ad esempio, l’eliminazione della potestà legislativa concorrente, di cui si chiedeva comunque una riduzione o il giudizio preventivo della Corte costituzionale sulle leggi elettorali.
Merita sottolineare come, dal punto di vista del metodo, la Commissione avesse sottolineato che «la revisione costituzionale necessita di coesione e disponibilità all’ascolto delle ragioni di tutti», questo essendo il punto di metodo su cui i quattro componenti erano del tutto d’accordo5, ma che, alla fine, non ha trovato riscontro nell’approvazione della revisione costituzionale su cui saremo chiamati a votare, rispetto alla quale, oggi, quasi tutti i «saggi» nominati dal presidente Napolitano si trovano su una posizione contraria6.
Seconda tappa: il Governo Letta – di larghe intese – e i suoi «saggi»
Quest’ultima indicazione sembra di particolare importanza soprattutto a fronte dell’assunzione dell’iniziativa legislativa anche sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale da parte dei Governi, con conseguente connotazione della proposta come di parte (quella che, appunto, sostiene quell’Esecutivo) e la conseguente difficoltà di arrivare poi a un testo largamente condiviso.
In effetti, alla Costituente, la proposta non fu d’iniziativa del Governo, ma fu elaborata dalla Commissione dei Settantacinque, in cui sedevano rappresentanti di tutte le forze politiche, come ben evidenziato all’inizio della discussione generale, il 4 marzo 1947, da Calamandrei, il quale, in relazione al lavoro che aspettava i costituenti, disse:
Non si tratterà di criticare un progetto presentato dal Governo e di votargli contro per arrivare a farlo respingere; ma saremo, invece, qui a fare una specie di esame di coscienza, poiché, in sostanza questo progetto di costituzione, sul quale siamo chiamati a discutere, esce da noi, è creato da noi, non dal Governo. Le critiche che noi rivolgeremo a esso saranno critiche rivolte a noi stessi; dovranno dunque essere, critiche costruttive. È una specie di esame di maturità, che la democrazia deve dare attraverso questa Costituzione.
D’altronde, De Gasperi (Presidente del Consiglio dei Ministri per tutto il periodo costituente, attraverso i suoi primi quattro Governi) fu sempre molto attento a non interferire con l’attività dell’Assemblea costituente, tanto che – come ricordato da Leopoldo Elia7 –, durante i lavori, il banco del Governo era riservato al Comitato direttivo della Commissione dei Settantacinque e nell’unica occasione in cui lo stesso De Gasperi intervenne sull’art. 5 (poi, 7), relativo ai Patti lateranensi, lo fece dal suo seggio di deputato, come leader della Dc, mostrando grande scrupolo nel non mescolare l’attività di governo con quella costituente. Ciò si rivelò particolarmente utile, nel 1947, con la fine dei Governi di unità nazionale e la conventio ad excludendum nei confronti del Pci e del Psi, quando si potette così mantenere, nell’Assemblea, il (precedente) clima collaborativo, che portò poi ad approvare il testo con 453 voti favorevoli e soli 62 contrari (su 515 presenti dei 556 eletti).
Analogo riguardo da parte dei Governi non risulta esserci stato negli ultimi anni, quando, pur non nell’ambito di una Assemblea costituente, ma di un procedimento parlamentare di revisione costituzionale, si è inteso mettere mano alla modifica di larga parte della Costituzione, in più occasioni, su iniziativa dell’Esecutivo, con conseguente inevitabile connotazione del testo come «di parte» e la conduzione della discussione sulla Costituzione in una logica di confronto tra il Governo e la sua maggioranza, da una parte, e l’opposizione, dall’altra.
Ora, il Presidente del Consiglio Letta, nel discorso con cui si presentò alle Camere per ottenere la fiducia al suo Governo, che, dopo settimane di stallo, riuscì a formarsi immediatamente dopo la rielezione del presidente Napolitano8, sottolineò l’importanza delle riforme istituzionali, evidenziando però l’esigenza che queste non fossero proposte dall’Esecutivo. Infatti, egli disse che
al fine di sottrarre la discussione sulla riforma della Carta fondamentale alle fisiologiche contrapposizioni del dibattito contingente, sarebbe bene che il Parlamento adottasse le sue decisioni sulla base delle proposte formulate da una Convenzione, aperta alla partecipazione anche di autorevoli esperti non parlamentari e che parta dai risultati della attività parlamentare della scorsa legislatura e dalle conclusioni del Comitato di saggi istituito dal Presidente della Repubblica.
Questa non meglio identificata «Convenzione» (di cui lo stesso Presidente del Consiglio, peraltro, avrebbe voluto verificare il lavoro dopo diciotto mesi), in realtà, non vide mai la luce. Viceversa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fu istituita una Commissione di consulenti dell’Esecutivo, composta da trentacinque esperti, in maggioranza docenti universitari di diritto pubblico e costituzionale, ai quali si aggiungeva, pochi giorni dopo, un comitato di redazione composto da altri sette esperti nelle medesime materie, presieduta dal ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello. Tale Commissione giunse a elaborare una relazione finale9, ricca di spunti per procedere alla revisione del bicameralismo paritario, del procedimento legislativo, del titolo V (Regioni e autonomie locali), della forma di governo, del sistema elettorale e degli istituti di partecipazione popolare, offrendo più soluzioni alternative. Proprio da questo punto di vista, infatti, è necessario sottolineare come spesso la ricchezza dei contenuti di questa relazione sia tale che è stato agevole ricondurre alcune delle scelte compiute dalla legge di revisione a quanto indicato in essa, senza considerare che magari si trattava di singole posizioni e che all’interno dello stesso lavoro erano presenti, sulla stessa questione, anche ipotesi differenti. Basti pensare che, ad esempio, l’unanime indicazione per il superamento del bicameralismo paritario veniva poi declinata, da una minoranza dei componenti, con il passaggio al monocameralismo, mentre dalla maggioranza con l’introduzione di un bicameralismo differenziato, nell’ambito del quale erano prospettate un ampio numero di opzioni: dal mantenimento dell’elezione a suffragio universale alla attribuzione della stessa ai Consigli regionali, al proprio interno o tra altri soggetti, con o senza la partecipazione di rappresentanti dei comuni, con o senza la presenza di membri di diritto.
Ora, mentre questa Commissione era al lavoro, il Governo aveva presentato un disegno di legge di deroga al normale procedimento di approvazione delle leggi di revisione della Costituzione, previsto dall’art. 138. In base a questo, si sarebbe dovuto costituire un Comitato, composto da membri delle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato e presieduto dai presidenti di queste, che avrebbe dovuto esaminare i progetti di legge di revisione costituzionale sulla forma di Stato, la forma di governo e il bicameralismo, «nonché i coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali». Sulla base di questo lavoro, da concludere entro quattro mesi, più progetti di revisione costituzionale (ciascuno «omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico») dovevano essere presentati in assemblea per la discussione e l’approvazione. La proposta prevedeva, quindi, tempi ristretti per la discussione e la deliberazione (tre mesi dalla trasmissione) e quindi, una volta conclusa la prima deliberazione su un testo conforme, da parte di entrambe le Camere, una seconda da realizzare ad almeno tre mesi dalla prima (come normalmente previsto dall’art. 138 della Costituzione). Successivamente, il testo sarebbe potuto essere sottoposto all’approvazione popolare attraverso un referendum su richiesta di un quinto dei componenti di una Camera o di cinquecentomila elettori o di cinque Consigli regionali, come già previsto dall’art. 138, ma senza che ciò potesse essere escluso dall’approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
Ora, questa proposta di deroga alla normale procedura di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, di cui all’art. 138 della Costituzione, già prevista in precedenti occasioni, seppure con modalità differenti10, pur introducendo una tempistica maggiormente scandita del procedimento, intanto produceva l’effetto di allungare i tempi, portando ad attendere l’approvazione di questa nuova procedura prima di mettere mano al merito delle modifiche costituzionali.
Terza tappa: il governo Letta – di ristrette intese – e la necessità di un nuovo schema
Intanto, il 1° agosto 2013, la Corte di Cassazione confermò in via definitiva la condanna del Presidente del Popolo della Libertà, Silvio Berlusconi, a quattro anni di reclusione per frode fiscale, con conseguente decadenza dal mandato parlamentare (che il Senato votò il successivo 27 novembre). Questo determinò un progressivo indebolimento del sostegno al Governo Letta, al quale, all’inizio di dicembre 2013, fu definitivamente ritirato l’appoggio da quella parte del Popolo della Libertà che riteneva inaccettabile continuare a governare insieme ai partiti i cui parlamentari avevano votato a favore della decadenza di Berlusconi. Tuttavia, l’Esecutivo mantenne la maggioranza parlamentare grazie al fatto che una minoranza del partito – che potremmo definire «ministeriale» (di questa facevano parte tutti e quattro i ministri e alcuni sottosegretari) – decise, invece, di continuare ad appoggiare il Governo Letta, fondando un nuovo partito, chiamato Nuovo Centrodestra (mentre l’altra parte ricostituiva Forza Italia). Con l’uscita dalla maggioranza Forza Italia abbandonò anche il percorso delle riforme costituzionali. Di conseguenza, il disegno di legge del Governo con cui si stabiliva per queste una diversa procedura (dai tempi maggiormente scanditi), essendo appoggiato da una maggioranza ormai ben più ristretta, non avrebbe certamente ottenuto i due terzi in seconda deliberazione, con conseguente sottoponibilità al referendum costituzionale, che complessivamente determina un allungamento dei tempi di circa sei mesi. Per evitare questo, anche a fronte di un quadro politico che stava cambiando e sembrava perdere quella prospettiva di durata che al momento del suo insediamento il Governo Letta aveva tratteggiato, lo stesso Esecutivo decise di ridimensionare le proprie ambizioni anche rispetto alla revisione costituzionale. In particolare, venne abbandonata la proposta di legge costituzionale che prevedeva il procedimento in deroga a quello previsto dalla stessa Costituzione (art. 138) per la sua modifica e si decise di concentrare la revisione costituzionale su alcuni più limitati aspetti. A questo proposito, certamente colpisce che non si sia sentita la necessità, da parte di un Governo che aveva scelto una particolare strada per modificare la Costituzione, di fornire almeno una spiegazione circa il mutamento di indirizzo. Tanto più che, una volta abbandonato, quel percorso, che certamente aveva consentito all’Esecutivo e alla legislatura di guadagnare tempo, si rilevava, invece, una sicura perdita di tempo, anche contribuendo ad alimentare la sensazione che il Governo Letta stesse girando un po’ a vuoto su vari fronti, tanto da essere presto sostituito – come vedremo meglio – da altro Esecutivo guidato dal nuovo Segretario del Pd, Matteo Renzi.
Quarta tappa: il «Patto del Nazareno» tra il (nuovo) Segretario del Pd e il Presidente di Forza Italia
Dal punto di vista delle riforme istituzionali (della Costituzione e della legge elettorale), infatti, risultano fondamentali alcuni accadimenti verificatisi tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014.
Il primo in ordine cronologico si verifica il 4 dicembre 2013, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge elettorale (il cosiddetto «Porcellum»), la cui sentenza (n. 1 del 2014) sarà depositata alcune settimane dopo. Ciò, da un punto di vista politico, delegittima profondamente le Camere, evidenziando anche come queste non siano riuscite neppure a trovare una soluzione per introdurre un nuovo sistema elettorale, nonostante questo fosse atteso da tempo.
Pochi giorni dopo, l’8 dicembre, è eletto il nuovo Segretario del Pd (secondo la complessa procedura delineata dallo Statuto attraverso una fase di votazione da parte degli iscritti, nei circoli, e poi attraverso una vera e propria consultazione elettorale tra tutti i «simpatizzanti», errone...