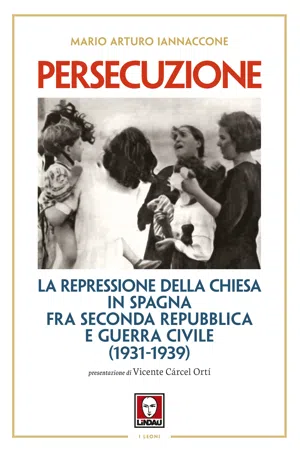![]()
Capitolo 1
L’esilio di Alfonso XIII e il Governo costituente
L’esilio di Alfonso XIII
Quando accettò la dittatura di Primo de Rivera nel 1923, re Alfonso XIII era un uomo ancora molto giovane avendo compiuto qualche mese prima 37 anni. Poteva prendere su di sé il peso del potere? Guidare il ritorno pieno alla Monarchia costituzionale? Forse. A lui comunque viene ascritta una responsabilità storica pesante, prima con l’accettazione della dittatura di Primo de Rivera che, benché non sanguinaria, fu sopportata a fatica da una parte degli spagnoli, e poi perché cedette ogni potere a un gruppo di politici e intellettuali che compirono una sorta di colpo di Stato tra il 1930 e il 1931. Accettando la dittatura di Primo de Rivera, durata poco meno di sei anni (13 settembre 1923-28 gennaio 1930), Alfonso indebolì una Monarchia già compromessa, nella sua credibilità, dalle decennali lotte dinastiche, violando inoltre la Costituzione del 1876 sulla quale aveva giurato. Così facendo non fu più considerato un monarca costituzionale vero e proprio ma un capo di Stato sostenuto dall’esercito. Una parte della società spagnola accettò la dittatura quale risposta a uno stato di agitazione sociale e politica sempre più grave. In effetti, il dittatore portò la paz social riducendo il fenomeno del pistolerismo. Si pensi che tra il 1919 e il 1920 si erano avuti oltre 1200 scontri a fuoco. In generale, una parte della società spagnola considerò gli anni ’20 felici e pacifici anche se ciò significò rinunciare ad alcune libertà4.
Il 30 gennaio 1930, Primo de Rivera si dimise, perché non aveva più l’appoggio dell’esercito. A quel punto, il re avrebbe dovuto abdicare lasciando il posto a uno dei suoi figli ma il primogenito Alfonso (1907-1938) soffriva di una grave forma di emofilia che lo avrebbe portato alla morte qualche anno più tardi, mentre il secondogenito Jaime (1908-1975), sordomuto, non poteva accedere al trono. Gli altri figli erano troppo giovani a quella data. Non potendo governare da solo senza una reggenza a causa della sua reputazione seriamente danneggiata, nominò come presidente del Governo il generale Dámaso Berenguer (1873-1953). Il problema maggiore, in quel momento, era che una parte dell’opinione pubblica, soprattutto gli intellettuali liberali, lo considerava complice di Primo de Rivera, un rappresentante delle tradizioni militariste della Spagna. Lo scrittore e cattedratico Miguel de Unamuno ebbe a dire, già all’inizio della dittatura: «In Spagna d’ora in avanti non ci sarà più posto per l’equivoco del liberalismo dinastico, in Spagna è morta l’anima della Monarchia costituzionale, da adesso Spagna sarà sinonimo di repubblicano»5. Questa era però un’opinione parziale, che non rappresentava la maggioranza del sentire popolare. Intellettuali come Unamuno decisero che quello era il momento di agire, se volevano ottenere forma repubblicana dello Stato, facendo leva sull’indecisione dell’opinione pubblica. Il re però non era l’unico responsabile dell’avvallo di una dittatura che aveva elementi di incostituzionalità ma che (forse) fu opportuna in anni in cui il Paese non riusciva a far convivere Monarchia, Esercito, borghesia, forze di opposizione e anarchici. La colpa tuttavia ricadde tutta su di lui. Così le pulsioni repubblicane di una parte degli intellettuali si fecero più forti; questi erano anche generalmente anticlericali e non perdonavano alla Chiesa di non aver protestato quando il re aveva affidato a Primo de Rivera una dittatura simile all’autocratismo del Porfiriato messicano. Del resto, subito dopo la Rivoluzione d’ottobre sovietica si era temuto realmente l’esportazione in Spagna della rivoluzione marxista-leninista6. In molti (e fra questi i vescovi) avevano assistito con preoccupazione all’estendersi dell’influenza socialista e anarchica nel Sud e temevano l’avvento di un Governo guidato dal socialista Manuel García Prieto (1859-1918) che già aveva annunciato, nel caso di un suo insediamento, l’avvio di una decisa legislazione anticlericale. Anche l’assassinio del cardinale Soldevilla y Romero, per mano di un anarchico, il 4 giugno 1923, aveva sollevato ulteriori timori. Di fronte al pericolo rivoluzionario, come molte altre componenti della società, la Chiesa aveva salutato la dittatura semidemocratica di Primo de Rivera come un periodo di transizione autocratico che doveva portare a un nuovo assetto. Egli avrebbe dovuto restare in carica per qualche mese, il tempo di ristabilire la paz social, e invece il suo potere fu prolungato per quasi sette anni. La Chiesa, comunque, non convisse del tutto pacificamente con Rivera e dovette difendere dal dittatore il clero catalano e quello basco accusati di separatismo per il semplice fatto di predicare, confessare e scrivere nelle lingue locali; ci furono espulsioni e attriti di una certa gravità anche se nel complesso il rapporto non arrivò a una conflittualità conclamata7.
Nel 1930, Dámaso Berenguer, incaricato dal re, tentò di riportare il Paese alla «normalidad constitucional» ripristinando la Monarchia costituzionale che Primo de Rivera, con il suo Direttorio militare e civile, aveva modificato, ma l’impresa non riuscì. La «dictablanda» (in paragone alla «dictadura» di Primo de Rivera) di Berenguer naufragò anche per la crescente ostilità dei partiti repubblicani e dei monarchici carlisti della Comunión Tradicionalista che Primo de Rivera aveva marginalizzato. Il carlismo era il movimento dei sostenitori di don Carlos di Spagna che, rifiutando l’abrogazione della legge salica operata dal fratello Ferdinando VII, si era proclamato nel 1833 re di Spagna contro la regina Isabella II e la reggente María Cristina, fautrice di una monarchia costituzionale8. I carlisti riconobbero come loro capo il fratello del pretendente Carlo VII, Alfonso Carlo di Borbone-Parma, contando su una forza militare composta da decine di migliaia di uomini di stanza nella Spagna settentrionale. Quando Berenguer promise di convocare le elezioni generali, sindacati come il CNT, che Primo de Rivera aveva messo fuori legge, tornarono alla luce mobilitandosi e provocando anche disordini. Il 17 agosto 1930, a San Sebastián, i capi dei partiti di opposizione riunirono una sorta di Governo costituente informale nel Pacto de San Sebastián che era, di fatto, un vero comitato rivoluzionario, guidato dal giurista Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949); suo scopo era rovesciare la Monarchia con un colpo di Stato il 15 dicembre 1930. Il tentativo avvenne il 12, quando il capitano golpista Fermín Galán, il capitano Ángel García Hernández e uno scarso seguito tentarono la presa del potere. Del colpo di Stato erano alleati il Comitato Rivoluzionario Repubblicano, i sindacati – che dovevano indire uno sciopero generale – e vari militari come il generale Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) ma il golpe fallì miseramente perché l’esercito non si sollevò. Queipo de Llano e Ramón Franco, che avevano occupato l’aeroporto madrileno di Cuatro Ventos, fuggirono in Francia. Altri personaggi implicati, come Casares Quiroga, Miguel Maura e Alcalá-Zamora furono arrestati; i socialisti Largo Caballero e Fernando de los Ríos si costituirono; Indalecito Prieto, altro socialista, e Marcelino Domingo, radicalsocialista, fuggirono in Francia mentre il radicale Alejandro Lerroux e il centrista Manuel Azaña restarono nascosti per qualche tempo9. Gli unici a finire male furono i militari Galán e García Hernández che subirono un processo e furono infine fucilati. La durezza mostrata nei confronti dei protagonisti di un golpe che non aveva avuto possibilità di riuscita (i due militari si erano arresi subito), colpirono una parte dell’opinione pubblica, soprattutto in paragone all’indulgenza mostrata verso i colpevoli di iniziative simili nei decenni precedenti. Tuttavia, l’indulgenza veniva da parte di chi simpatizzava con i golpisti, altri avevano visto nell’iniziativa la minaccia dell’instaurazione di un Governo di tendenze radicali. I due ufficiali divennero «eroi repubblicani» celebrati in opere come Fermín Galán di Rafael Alberti (opera in tre atti del 1931).
Se Alfonso XIII stava dimostrando scarsa lungimiranza politica (durissimo con i due ufficiali, fucilati, e comprensivo con i politici che avevano progettato il golpe) c’è da dire che anche i futuri capi repubblicani davano, in questa manifestazione d’irresolutezza e divisione, l’anticipazione di ciò che sarebbe stata la Segunda República. Berenguer convocò elezioni generali per marzo ma dal momento che fu minacciata un’astensione generale e veniva richiesto un passo indietro da parte sua, egli si dimise con tutto il suo Governo il 14 febbraio 1931. Alfonso XIII, preso alla sprovvista, cercò un sostituto ricevendo rifiuti anche da parte di vari esponenti a lui vicini come il conte Antonio Maura, il Conte di Romanones, il marchese Alhucemas, José Sánchez Guerra e Melquíades Álvarez, tutti uomini che avevano fatto parte degli ultimi governi monarchici e che passarono frettolosamente al campo repubblicano. Infine Berenguer fu sostituito dall’ammiraglio Juan Bautista Aznar, il quale, riunito un Governo di «concentración monárquica», fissò le elezioni municipali, non politiche, per il 12 aprile 1931. A quelle dovevano seguire, in data da destinare, l’elezione delle Cortes, cioè del parlamento. È importante sottolineare che le elezioni di aprile non avevano carattere di referendum fra due tipi di Governo, Repubblica e Monarchia.
Il giorno delle elezioni, il 12 aprile, i repubblicani vinsero in 41 capoluoghi di provincia contro 8 andati ai monarchici (Ávila, Burgos, Cadice, Gerona, Lugo, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria e Vitoria). I repubblicani ottennero i risultati migliori a Madrid e Barcellona dove avevano condotto campagne elettorali capillari. Se si escludono i capoluoghi e si fa un calcolo meramente numerico furono i monarchici a vincere con una schiacciante maggioranza: i consiglieri monarchici eletti furono 22.000 contro gli 800 repubblicani, tutti, in pratica, eletti nelle città. A Madrid (950.000 abitanti circa), ad esempio, i candidati repubblicani furono 30 contro i 20 monarchici (la vittoria era netta ma non eccezionale) mentre a Barcellona (1.000.000 di abitanti) la vittoria era più pronunciata: 38 contro 2110. Seguivano Valencia (320.000) e Saragozza (229.000), tutte le altre città erano inferiori ai 200.000 abitanti (tutti i censi sono riferiti al 1931). In seguito a questi risultati un gruppo di uomini politici e intellettuali diedero seguito al golpe – tale era nella forma – proclamando la Repubblica. A Barcellona il capo dell’Esquerra catalana, Francesc Macià, aveva proclamato la Repubblica catalana e sarebbe tornato sui suoi passi soltanto grazie a una trattativa con tre ministri del Governo che si stava insediando e che garantirono una certa autonomia della Generalitat de Catalunya. Nella competizione elettorale risultarono elette anche alcune donne (sebbene le donne non potessero votare), fra queste le repubblicane Clara Campoamor e Victoria Kent e la socialista Margarita Nelken. I repubblicani e le forze laiciste erano contrari al diritto di voto alle donne mentre i cattolici erano favorevoli al punto che un’organizzazione cattolica, l’Unión de Damas Españolas, avrebbe raccolto un milione di firme per consentirlo. Quel diritto sarebbe stato concesso nel corso del 1931 con una maggioranza repubblicana assai ristretta11. A Madrid, Alcalá-Zamora parlamentò con militari e polizia concordando l’esilio del re. Nelle città iniziarono a mobilitarsi le folle dei partiti vincitori e dei sindacati per dare la spallata definitiva alla Monarchia, mentre altre parti politiche restavano paralizzate dal succedersi velocissimo degli eventi. Il re stesso aveva giudicato pericolosa la situazione, temeva tumulti e per questo accettò un esilio volontario. Il 14 aprile, alla Puerta del Sol, davanti al palazzo del Ministero degli Interni, conversero i nuovi uomini di potere davanti alle loro folle. Alcalá-Zamora proclamò la Repubblica e presentò i ministri principali del suo Governo: Maura, Lerroux, Azaña, Caballero, Prieto e Domingo. Nelle stesse ore, il re partiva in esilio per Marsiglia. Pare che in nessun luogo del Paese ci siano state manifestazioni in favore del re e l’avvento della Repubblica si realizzò «per via sostanzialmente democratica, attraverso un suffragio elettorale con esito e significato assai chiari e una pacifica mobilitazione […] senza che l’opposizione monarchica, che pure aveva mostrato una forza elettorale non priva di consistenza, cercasse di rompere il gioco, di ricorrere alla violenza […]»12. È Gabriele Ranzato a sottolineare che la via fu sostanzialmente democratica, il che significa che non lo fu formalmente (nelle democrazie la forma è fondamentale). L’opposizione inoltre, che non era priva di consistenza (giacché ai numeri aveva vinto), non ricorse alla violenza. A parte il giudizio severo che può essere dato sul re, di fatto, l’intera vicenda nasceva su basi di consenso ambigue, come un colpo di mano. Le vecchie élite monarchiche furono paralizzate dagli eventi e non chiamarono alla raccolta le loro forze nella convinzione che quella repubblica, «virtualmente» proclamata da Miguel de Unamuno e da Alcalá-Zamora a Madrid, fosse un incidente di percorso. Tuttavia, un fatto pesava come un macigno: il re aveva abbandonato il campo.
In gran parte della storiografia successiva, scritta soprattutto da storici e storiografi inglesi e francesi simpatizzanti per i repubblicani, anche a costo di imprecisioni e forzature, l’estremo divario fra i 22.000 rappresentanti eletti per i monarchici e gli 800 eletti per i repubblicani viene sottostimata o considerata frutto dell’influenza dei caciques. Questi c’erano, anche se Primo de Rivera aveva cercato di combatterli. È ben possibile, forse sicuro, che una parte dei voti siano stati forzati dai caciques a favore dei monarchici ma la differenza di 21.200 consiglieri è troppo grande. Che il successo dei monarchici e delle forze di destra e cattoliche nelle campagne mettessero «in evidenza i vecchi mezzi truffaldini usati per ottenerlo» è indimostrabile13. Consideriamo inoltre che un sindacato rurale di sinistra, l’UGT, contava ben 400.000 iscritti e avrebbe potuto esercitare la sua forza, una forza contraria a quella monarchica, sia pure ancora minoritaria, nelle campagne. Nelle campagne dell’Andalusia e dell’Estremadura non erano certamente i sindacati cattolici o i caciques di tendenza monarchica a do...