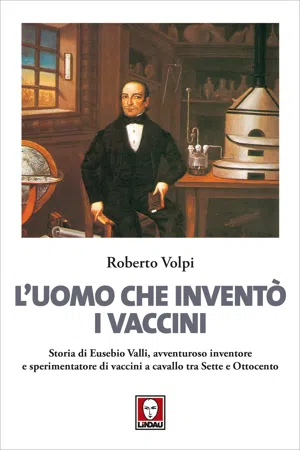![]()
1
Una biografia con il titolo di una pratica notarile
Allo sbocco della Valle dell’Era, nella provincia di Pisa, Ponsacco (allora nominato Ponte di sacco forse per essere l’unico ponte di congiunzione e di passaggio di uomini e merci – imballate e portate in sacchi – tra l’umbratile Volterra da una parte, incastonata nel susseguirsi verde e silenzioso delle scabre colline della Toscana di mezzo, e la Piana di Pisa dall’altra, o forse soltanto e più prosaicamente ancora in quanto di proprietà di un certo Sacco: Ponte di Sacco, appunto, ma stavolta con la s maiuscola anziché minuscola) aveva mura e torri di fortificazione: sette torri, per l’esattezza, di una soltanto delle quali è rimasto un tozzo moncone sbrecciato, rosseggiante al tramonto. Forse per la posizione vagamente strategica (ma in quei tempi bastava davvero poco per considerare di importanza strategica un luogo, un appostamento, un crocevia, una collina, un fiume o corso d’acqua qualsivoglia, e insomma un qualcosa di geograficamente evidenziato rispetto al paesaggio circostante), forse proprio per le fortificazioni – pur se allora le fortificazioni dovevano essere perfino più comuni delle non fortificazioni – Ponsacco fu, per tutto il corso del XV secolo, palleggiato tra Pisa e la più lontana Firenze a furia di scaramucce e più consistenti battaglie su nessuna delle quali ha lasciato impresso il suo nome. Segno evidente, quest’ultimo, che le due città toscane avevano sempre qualcosa di più importante da contendersi e che Ponsacco ci andava di mezzo più per la sua posizione geografica che non per le sue posizioni politiche.
Per tagliare la testa al toro i fiorentini, dopo l’ultima loro riconquista, demolirono le mura perimetrali nel 1509. E da quella data sembra che la vita, nel piccolo borgo di Ponte di sacco o Sacco, abbia preso a scorrere con un po’ più di tranquillità.
Pressappoco in quei tempi turbinosi un Antonio Valle o Valla o Della Valle (o ancora della Valle con la d minuscola), figlio di un fuoriuscito da Roma per motivi politici, vi approdò non si sa come né se volutamente o accidentalmente e qui rimase dando origine alla famiglia dei Valli di Ponsacco. Famiglia non comune, se è vero, come in effetti lo è, pur se da tanto non c’è più alcun Valli a Ponsacco proveniente da quel ceppo, che «in tutti i rami nei quali andò divisa, si sono conservate sempre e si conservano inalterate tutte le antiche e nobili tradizioni, cioè la virtù, l’onoratezza e il decoro».
A scrivere queste parole è l’avvocato Giuseppe Valli nel suo libro dal titolo tanto pignolo da sembrare proprio l’intestazione di una pratica, faldone o incartamento di uno studio legale Cenni biografici sul Dottore (si noti l’uso della maiuscola per dottore) Eusebio Valli da Ponsacco (Pisa) – ma quando mai s’è visto nel titolo d’una biografia l’indicazione, per giunta tra parentesi, neppure si trattasse di una lettera o appunto di una pratica notarile, della provincia del comune che dette i natali al, chiamiamolo così, biografato? –, edito nel 1881 a Pontedera, cittadina a cinque chilometri da Ponsacco, dal dopoguerra nota per gli stabilimenti Piaggio e il prodotto più famoso che da quegli stabilimenti sia mai uscito: l’intramontabile Vespa. Libro a suo modo fortunato, a dispetto del titolo, se nel 1886 viene ristampato a cinque anni di distanza dalla prima edizione. Questa ristampa che, come recita il lunghissimo e – al solito – archivistico sottotitolo di copertina, risulta «riveduta e corretta coll’aggiunta di un ricchissimo Epistolario [altra maiuscola in eccesso; il Valli avvocato seminava maiuscole ovunque, quasi a onorare l’altro Valli, Eusebio] e di scritti sulla priorità della scoperta dell’inoculazione del virus rabido come rimedio contro la rabbia canina», è quella della quale ci avvarremo di preferenza come guida, se non limpidissima – in quanto scopertamente partigiana – certo ben documentata, nel nostro viaggio alla scoperta di un personaggio fuor di dubbio singolare, bizzarro e irrequieto come pochi.
A proposito di questa ristampa annotiamo subito una stranezza, della quale fornirò una spiegazione in seguito, che gode di un posto centrale nel nostro racconto: i cinque anni che la separano dalla prima edizione del libro dell’avvocato Giuseppe Valli. Cinque anni sono davvero tanti per la prima ristampa di un libro, ancora oggi. Figurarsi per un libro su un personaggio pressoché sconosciuto e morto ormai da settanta anni, a maggior ragione in riferimento al tempo della biografia – l’800, non propriamente un secolo di grande diffusione del libro e della lettura, pur se nella sua fase declinante verso il ’900 – e al luogo in cui fu scritta e alla popolazione alla quale principalmente, anche se non esclusivamente, si rivolgeva: quella della piccola comunità di solo alcune migliaia di anime di Ponsacco e dintorni.
Ma veniamo al nostro protagonista, a Eusebio, per premettere che costui appartiene alla storia minore, molto minore, anzi – quanto rimettendoci, di una tale collocazione, ciascuno potrà meglio giudicare alla fine di questa biografia. A quella storia, in parole povere, che difficilmente riesce a conquistarsi una pagina e perfino qualche scarna citazione sui libri; a quella storia fin troppo tranquillamente sacrificata a quell’altra, con l’iniziale maiuscola e il contenuto per così dire certificato dal lavoro di ricerca, di scavo e di interpretazione di tanti studiosi: grandi, meno grandi e pure mediocri. Rispetto a quest’ultima, quella minore soffre di uno straordinario quanto ovvio handicap: la dimenticanza, l’oblio cui va soggetta con la stessa facilità con la quale l’altra, la maggiore, va soggetta a periodiche rivisitazioni e re-interpretazioni. Così, nessuna meraviglia se, nonostante Eusebio Valli abbia imprestato il suo nome a un po’ di vie, un paio di scuole elementari e qualche piazza tra Ponsacco, dove erano nati i genitori, e Casciana Alta, a una quindicina di chilometri da Ponsacco, più interna e più a sud della provincia di Pisa, dove invece nacque, di lui non è rimasta traccia se non nei libri pressoché sconosciuti che scrisse e che sopravvivono come reliquie dimenticate, mai compulsati da alcuno, in qualche santuario della storia della medicina, in certe carte di qualche archivio polveroso che nessuno consulta più da chissà quanto tempo (forse da quando se ne servì il suo fino a questo momento unico vero biografo, l’avvocato Giuseppe Valli) e nella memoria di qualche concittadino maniacalmente dedito alla rivalutazione di vere e più spesso presunte glorie locali e di qualche sporadico cultore di storia della medicina dall’enciclopedica conoscenza.
![]()
2
Il mistero delle date
Eusebio Valli nacque il 16 dicembre del 1755 a Casciana Alta, minuscola località della odierna provincia di Pisa adagiata sulla sommità di una dolce ondulazione che a malapena – a dispetto di quell’aggettivo, quell’«alta», davvero eccessivo – si può chiamare colle, e morì nientemeno che a L’Avana, capitale dell’isola di Cuba, dov’era andato con l’idea di studiare e combattere la febbre gialla, nel settembre del 1816.
Le date hanno una grande importanza per capire questo personaggio o, meglio ancora, per capire l’idea che di lui si fecero i suoi concittadini e un po’ d’altre persone che concittadini non erano ma che pure in un certo momento della loro vita udirono il suo nome e l’eco delle sue imprese (se vogliamo chiamarle così: e chi scrive vuole chiamarle così, convinto che le imprese non sono soltanto quelle che lasciano tracce che resistono al tempo), dopo ch’egli, per la verità, era morto e seppellito da un pezzo. L’importanza delle date della nascita e della morte del Valli non sta tanto in ciò che delimitano, ovvero la non troppo lunga né breve per i tempi di allora vita di Eusebio, il suo tragitto terreno, il tempo del suo percorso inserito nel percorso del mondo al suo tempo. Paradossalmente, questa importanza sta tutta in una terza data, estranea a entrambe le precedenti giacché si collega al Valli quando lui non è più al mondo da svariati decenni. Le date della nascita e della morte di Eusebio Valli, insomma, hanno un valore in qualche modo storico (sempre nel senso di storia minore che s’è detto) non in sé stesse ma perché ci attestano in modo incontestabile che la data veramente importante per il Valli arrivò soltanto una cinquantina d’anni dopo la sua morte. E riguardava tutt’altro personaggio, neppure italiano, per giunta, lui sì appartenente, eccome, alla storia maggiore: Louis Pasteur. Il francese Louis Pasteur, il grande microbiologo – però chimico di studi ufficiali. Ma procediamo con ordine.
A Casciana Alta, nel bel mezzo di una via intitolata al Nostro – la più importante del piccolo borgo di alcune centinaia di anime, quella che lo attraversa tutto nel senso della longitudine –, sulla facciata di una modesta casa, c’è una lapide che sta a cavallo tra il primo e il secondo dei tre piani della casa sulla quale si può leggere, tra uno «spirito indomito» e un «animo nobile e generoso», che il Valli fu, addirittura, il «primo a praticare l’inoculazione antirabbica». Per dire: il vaccino contro la rabbia.
Si tratta di una lapide ben strana giacché, contenuto a parte, è senza data. Ora, non c’è lapide commemorativa al mondo, credo, che non riporti, ben evidenziata, spessissimo in numeri romani, che danno tanto l’idea della storia, la data di apposizione: almeno l’anno, spesso anche il mese e perfino il giorno. Quella no, niente. La lapide che Casciana Alta ha dedicato alla memoria del suo solo figlio che mai sia assurto a una qualche gloria mondana o, non fosse altro, a una qualche notorietà, sia pure fuggevole e circoscritta anch’essa nello spazio e a maggior ragione nel tempo, non riporta alcuna data.
Perché? Semplice, ma nondimeno assai poco spiegabile, dimenticanza? Gesto da imputarsi alla modestia, alla ritrosia di uomini – contadini quasi al gran completo, tra pochi proprietari terrieri, alcuni, coltivatori diretti, altri, e, ben più numerosi, mezzadri e coloni – che intendevano, in questo modo, rifiutandosi perfino di apporre una data a segnare il loro gesto, conferire al loro concittadino una universalità di fama sganciata dai giorni e dal calendario, e dunque capace di proiettarsi a piacimento, per così dire senza vincoli, su Eusebio Valli, il dottor Eusebio Valli, il «primo a praticare l’inoculazione antirabbica»?
Impossibile pensare alla dimenticanza, siamo seri; ma anche la seconda ipotesi appare troppo sottile ed elucubrata, troppo – viene da pensare – psicanalitica. E non già perché quegli uomini che apposero la lapide non sapessero, all’occorrenza, essere sottili o psicologicamente complessi e magari pure un poco contorti, ma perché perseguivano un obiettivo ben più pragmatico e corposo, rimpiattando la data, più terra terra mi vien da dire: quello di confondere, di intorbidare un po’ le acque a favore del loro illustre o quasi concittadino e insomma di imbrogliare le carte, per chiamare le cose col loro nome. Al momento (tenuto nascosto) dell’apposizione della lapide sulla casa natia del Nostro, a quei non così sempliciotti concittadini sembrò di capire che per il loro quasi, se non del tutto, dimenticato Valli si riaprivano delle possibilità di diventare famoso, forse addirittura universalmente famoso, forse stabilmente, perennemente famoso. La lapide, quella lapide orbata della data, intendeva a suo modo e nel suo piccolo, e pur nella lontananza abissale dai centri del potere, dare un contributo per cercare di trasformare quelle nuove e inaspettate possibilità in realtà.
Ma continuiamo ad addentrarci nel mistero della data mancante. Anche a Ponsacco, attualmente fiorente cittadina di oltre quindicimila abitanti al centro della Valdera, che come si è detto al Valli diede i natali e che dei Valli è stata la culla, c’è una lapide per Eusebio, sulla facciata della casa che fu dei suoi genitori, e nella quale anche lui trascorse alcuni – pochi e certamente non lunghi – periodi della sua vita. Su quella lapide la data invece c’è e consiste nel solo anno: il 1881.
Abbiamo già incontrato quest’anno, il 1881. La prima edizione del libro dell’avvocato Giuseppe Valli sulla vita di Eusebio è proprio della fine del 1881. A Ponsacco, dunque, tanto la lapide commemorativa che la biografia di Eusebio Valli – forse la prima lapide e senz’altro la prima vera biografia dopo la sua morte – vedono la luce soltanto sul finire del 1881. Ci si potrebbe scommettere mille – non cento, mille – contro uno che anche la lapide di Casciana Alta è di quell’anno fatidico – e vedremo perché. Ma – intanto – fatidico in che senso? È impossibile non chiedersi che cosa mai possa entrarci il 1881 con le date specifiche del Valli: con il 1755 anno della sua nascita e con il 1816, anno della sua morte. C’è dunque un mistero in queste due lapidi apposte rispettivamente e del tutto incongruamente, almeno all’apparenza, a una distanza rispettivamente di 126 anni dalla nascita e di 65 anni dalla morte. Un piccolo mistero, considerando quanto è in certo senso a portata di mano la sua soluzione.
Le lapidi commemorative – è osservazione comune – o vengono apposte pressoché subito o dopo un certo numero, pieno, di anni: dieci, cinquanta, cento, mille anni dalla nascita o dalla morte, ma mai dopo 126 o 65 anni. Mai. Che senso avrebbe una lapide a questa distanza dalle due date della nascita e della morte? E lo stesso avvocato Giuseppe Valli non poteva trovare un altro momento per commemorare il Valli suo predecessore? Non poteva scriverlo prima un libro su di lui, la sua biografia? Aveva perfino un’età avanzata, per i suoi tempi, quando si accinse all’impresa. Non poteva scriverne quand’era un giovane avvocato? Gli sarebbe tornato utile anche alla professione, visto e considerato che si trattava di perorare una causa né facile né comune: quella di un mancato riconoscimento scientifico. No, che non poteva. Cioè, in teoria poteva benissimo, ma in pratica non poteva, non gliene sarebbe passata per la testa neppure l’idea non fosse stato per quel che successe o, meglio, che principiò a succedere proprio agli inizi di quel 1881. In pratica anch’egli per un verso seguì e per l’altro contribuì a formare la piccola – ma non così piccola – corrente di notorietà che d’un tratto investì il nome e la figura di Eusebio Valli, strappando entrambi alla dimenticanza cui sembravano per sempre consegnati, dopo che erano trascorsi, appunto, la bellezza di 126 e 65 anni rispettivamente dalla sua nascita e dalla sua morte: numeri incongrui per lapidi e biografie.
Il fatto accertato e accertabile da chiunque voglia farlo è che solo nel 1881 prende il via non già la riscoperta ma la vera e propria scoperta di Eusebio Valli, di cui si erano tutti tranquillamente dimenticati gli uomini e le donne del tempo della sua vita e dei decenni successivi alla sua morte, concittadini compresi, e si assiste quasi a una gara a scolpire lapidi in suo onore, a intestargli vie, piazze, scuole. Certo, la gara all’intestazione si svolse pur sempre in un ambito geograficamente alquanto circoscritto, un pezzetto della provincia di Pisa compreso tra tre degli attuali comuni di quella provincia: Ponsacco, Lari e Casciana Terme. Ponsacco come luogo di nascita dei genitori di Eusebio, Casciana Terme – ai tempi di Eusebio Bagni di Casciana – in quanto comune di cui era frazione Casciana Alta, e Lari perché nel secondo dopoguerra Casciana Alta sarebbe stata inclusa nel suo territorio. Ma l’altra gara, quella a una pur sempre tardiva valorizzazione delle scoperte del Valli, coinvolse medici e studiosi, oltre che giornalisti e gazzettieri che volentieri ne scrissero, di buona parte della Toscana e anche di fuori della Toscana.
Ma ancora non abbiamo risposto alla domanda su come c’entri il 1881 coi valliani anni 1816 e 1755. C’entra, ecco il punto, la spiegazione di tutto il busillis, perché d’Oltralpe, dalla Francia, presero ad arrivare, proprio in quel 1881 altrimenti inspiegabile, certe notizie sugli studi e gli esperimenti che il grande scienziato Louis Pasteur aveva cominciato a fare sulla rabbia, cercando di scoprire un vaccino o una cura; notizie che ebbero come d’incanto il potere di richiamare alla memoria prima di qualcuno e poi di parecchi – storici e studiosi della medicina, ma anche persone come l’avvocato Giuseppe Valli, discendente dallo stesso ceppo di Eusebio, che sentirono d’un tratto l’orgoglio di una affinità di qualche tipo con questo personaggio – altri esperimenti sulla rabbia, altri tentativi, altri vaccini (se davvero si possono chiamare così, ma io credo che non ci sia altro modo di chiamarli, proprio perché corrispondevano alla filosofia e alla concezione medico-immunologica dei vaccini, per quanto grossolani fossero) ben meno famosi del vaccino cui perverrà il grande francese: quelli, appunto, di un fino ad allora dimenticato o ben che andasse sottovalutato medico toscano che rispondeva al nome di Eusebio Valli.
La lapide di Casciana Alta – non è pensar male, ma esercizio di realismo – è volutamente, deliberatamente, programmaticamente senza data perché, in fondo, i maggiorenti di quel luogo di qualche centinaio di anime che si decisero alla bisogna dovettero provare almeno un poco di vergogna a dedicarla al loro più illustre concittadino di sempre, con tanto e tanto colpevole ritardo, e solo perché fattori esterni in certo senso la imponevano. Un senso di vergogna che veniva a sommarsi a una furbizia da contadini, da villici che la sapevano lunga: infatti, nascondendo la data, quell’improprio 1881, nascondevano al tempo stesso l’impresa alla quale si accingeva Louis Pasteur e fingevano una memoria mai smarrita del Valli e della sua precorritrice scoperta sulla rabbia. Così da poter scrivere sulla lapide, senza farsi troppi scrupoli, che fu quest’ultimo il primo a inoculare un vaccino antirabbico (quando ancora, aggiungiamo noi, Pasteur neppure era nato) in esseri umani in carne e ossa e con risultati, sempre a sentir loro, non disprezzabili: se non altro quegli esseri umani sopravvissero tanto alla rabbia (se davvero, bisogna doverosamente precisare, l’avevano contratta) quanto al ben poco sperimentato vaccino valliano di cui diremo.
Inutile aggiungere che la possibilità che Pasteur mettesse coi suoi studi sulla rabbia una pietra tombale, stavolta davvero tale, sugli incerti e men che mediocremente documentati risultati ottenuti da Eusebio Valli (oltretutto, per quanto riguardava il vaccino contro la rabbia, su non più di un paio di persone) era, in fondo, conseguenza anche del loro stesso atteggiamento, dell’aver cioè anche loro atteso, per ricordarsi del Valli, che dalla Francia arrivasse notizia, in quel 1881 fatidico proprio per questo, di ciò a cui il grande Pasteur aveva cominciato ad applicarsi con una dose perfino maggiore della consueta caparbietà.
Insomma, ecco la conclusione di tutto il discorso: fu paradossalmente il grande scienziato francese a dare a Eusebio Valli quel poco, quel briciolo di faticosa gloria postuma che gli toccò in sorte – del resto quasi subito rientrata, come può rientrare nell’ordinarietà una passione senza sostanza, con la stessa repentinità con la quale si era inaspettatamente accesa. L’unica gloria di cui il medico toscano avrebbe mai goduto. Senza la complessa, spietata lotta contro la rabbia che ingaggiò Pasteur, e che gli prese quattro lunghi anni della sua vita di ricercatore e scienziato, nessuno avrebbe forse ricordato Eusebio Valli e il suo vaccino contro la rabbia di decenni e decenni – quasi un secolo – prima. Nessuno gli avrebbe intestato piazze e scuole e neppure lapidi che lo ricordano come il «primo», «vero» scopritore del vaccino antirabbico (quasi che invece Pasteur avesse usurpato il titolo). Perché una cosa almeno va detta e ribadita in difesa dei concittadini del Valli e di tutti quegli altri che si precipitarono a incensarlo per motivi di campanile e nazionalistici: che il vaccino di Eusebio non era un’invenzione di uomini che volevano farsi perdonare una troppo frettolosa dimenticanza, lapidi mai apposte sui muri delle case, scuole o vie o piazze mai intestategli. Il Valli aveva inventato e sperimentato veramente – ma poco, troppo poco, quasi niente! – quel vaccino. Quello, come, del resto, altri vaccini, il più importante dei quali addirittura contro la peste.
![]()
3
Nella storia minore (e forse neppure in quella)
È una storia curiosa, e per alcuni aspetti drammatica, questa del Valli inventore di vaccini, sperimentatore accanito sul campo, mai nelle stanze silenziose e indaffarate e presumibilmente umide, dagli altissimi soffitti, dagli scaffali da speziali, dagli ingombranti alambicchi dei laboratori di allora, sempre nei luoghi percorsi dalle malattie, dalle pestilenze, dal dolore e dalla morte, là dove la vita batteva e smetteva di battere con la stessa solerte, efficiente indifferenza. Una storia che merita di essere raccontata, pur se non si deve pretendere di giungerne alla fine avendo acquisito una chiarezza di giudizio sul valore scientifico del Valli. Colpa forse del sottoscritto che ne scrive, ma anche del fatto che chi fu davvero Eusebio Valli, almeno da questo stretto punto di vista, è ancora oggi difficile da stabilire con sufficientemente fondata certezza. E chissà, anzi, che egli non sia stato precocemente dimenticato proprio per quell’ombra di indeterminatezza – molta, troppa – che pesa sulla sua opera, per il carattere di incompiutezza –, troppa incompiutezza – che sempre aleggiò sulla sua vita nonostante tutto lo zingaresco girovagare di cui fu intessuta, o forse proprio per questo girovagare del Valli all’avventura nelle contrade del mondo che allora meno di oggi doveva apparire funzionale alla dignità e all’autorevolezza della scienza.
Di preferenza si dimenticano, com’è ovvio, ancorché ciò possa sembrare ingiusto, quanti sfuggono alle clas...