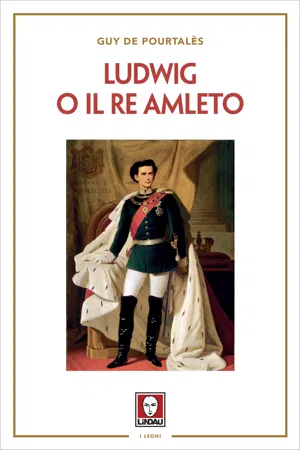![]()
1
L’operetta di Monaco di Baviera
Circa trent’anni dopo il soggiorno di Goethe in Italia, soggiorno che inoculò una goccia suprema di classicismo nelle vene del grande corpo romantico tedesco, un giovane principe di Baviera vi giunse a sua volta e scoprì Roma. Non solo Roma, ma Atene in Roma, l’Olimpo eterno, gli dèi, Omero, la bellezza, il suo destino.
Divenuto re poco dopo con il nome di Ludwig I, il sovrano voleva rendere la sua cara capitale una nuova Atene. E nel colpirne il terreno onorato e triste con un bastone d’oro, ne fece scaturire dei Propilei, un Partenone, una pinacoteca, una gliptoteca di mattoni, rivestita di cemento con venature a pennello per imitare il marmo. Poi si sposò, fu un marito fedele, un padre severo, un monarca che si prendeva cura delle finanze pubbliche. La sua unica amante restava la Grecia. La vedeva dappertutto. Ne permeava i suoi artisti, che pagava con corone di rose e di alloro, anche se acquistava le sue statue all’estero. Il suo regno fioriva in pace e in un innocente ellenismo. A un pittore, che del Reno tedesco aveva fatto un dipinto allegorico, diceva: «Reno deriva dalla parola rinos. Il Reno è un fiume greco». Nel 1832 ebbe una grande gioia: Otto, il figlio ancora minorenne, fu designato dal Congresso di Londra per essere incoronato re degli Elleni. Purtroppo questa gioia ebbe breve durata. I greci illuminarono il Partenone per celebrare l’arrivo del giovane bavarese; tuttavia, lo cacciarono presto, cosa che, peraltro, non tolse nulla all’entusiasmo classico di re Ludwig. Monaco continuò a essere popolata di templi e colonne.
Questa esistenza avrebbe forse potuto essere portata a termine nella tranquillità e nell’edificazione di opere murarie, se un incidente, frutto di estrema impertinenza, non avesse disturbato per sempre il suo corso apollineo. Una sera del settembre 1846, mentre stava lavorando nel suo studio, Sua Maestà fu improvvisamente disturbato da un rumore insolito, da grida e grande confusione. Un servitore sconvolto venne infine a dirgli che la ballerina spagnola che doveva debuttare quella sera a teatro, essendosi vista ritirare il permesso di apparire sul palcoscenico reale, pretendeva con impudenza di arrivare fino al re, e, se non fosse stata afferrata saldamente, di certo ci sarebbe riuscita! Già il monarca stava rimuginando sulle punizioni che una simile audacia avrebbe meritato, quando, seguita da un ciambellano terrorizzato, apparve la ballerina. Era una ragazza esile, bruna, furiosa, scintillante. Il re ordinò che fossero lasciati soli. Le chiese il nome: «Lola Montez». La pregò di rassettarsi, dato che, nel tafferuglio, la camicetta le era stata strappata per metà. La ballerina preferì restare a seno nudo. Parlò. Si spiegò. Supplicò. Il regale amante dell’arte, che aveva accarezzato così tante statue, ora non poteva credere alla perfezione di quella verità palpitante. Allungò la mano; lei la prese e la mise davanti al fatto compiuto. (Così si espresse un rapporto della polizia). Possiamo notare che, in questa faccenda, nessuno era privo di determinazione. Ma il re era perduto.
Già l’indomani, Lola ballava di fronte a un pubblico ammaliato e a un principe schiavizzato. Ricevette versi, firmati «Ludwig». E poi gioielli, abiti, lettere appassionate. E ancora gioielli, moltissimi gioielli, una casa, una carrozza, denaro. L’avaro brizzolato si trasformò in prodigo. In pochi mesi le finanze reali furono prosciugate. Si passò quindi a quelle dello Stato. Il gabinetto fu deposto. Altri lo sostituirono, che caddero a loro volta. Al re importava poco, l’unico suo interesse era ormai la coreografia. Oppure accompagnava l’amante negli atelier dei pittori, per insegnarle le Belle Arti e farne dipingere il ritratto. L’intero 1847 trascorse tra le follie. Si vedeva Lola Montez caracollare per le strade di Monaco, facendosi salutare come una regina e minacciando con il frustino i passanti non abbastanza deferenti. Ricevette il titolo di contessa di Landsfeld. Si scontrava con gli studenti che non dimostravano adeguata ammirazione di fronte a una tale storia d’amore, oppure, quando manifestavano sotto le sue finestre, versava sulla loro testa coppe di champagne. Lola pensava di riscattare le proprie eccentricità «liberando il popolo» e facendo copiare, a beneficio del suo regale cagnolino, il Codice napoleonico. Ma quando il re assisteva alle sedute di posa presso Kaulbach, lo costringeva a inginocchiarsi e gli colpiva la testa con un ventaglio per insegnargli l’umiltà. Il che non dispiaceva più di tanto al complicato sessantenne, sebbene lo indolenzisse parecchio. In quel periodo i sacerdoti predicavano dal pulpito contro la bestia dell’Apocalisse, o dichiaravano che, a Monaco, Venere aveva sostituito sul suo trono la Beata Vergine.
Non poteva che finire male. Un giorno, la ballerina fu braccata dalla folla. Si rifugiò nella chiesa dei Teatini; per liberarla fu mobilitato l’esercito. Ci fu uno spargimento di sangue. Il 12 ottobre 1848 re Ludwig I dovette firmare l’ordine di esilio e, non appena la «diavolessa» lasciò la sua dimora sotto mentite spoglie, la gente vi fece irruzione e sfasciò tutto. Il re si mostrò alla folla, la calmò, poi tornò al palazzo e scrisse queste righe: «Bavaresi! Nuovi tempi stanno iniziando, diversi da quelli previsti da una costituzione in base alla quale ho governato per ventitré anni. Rinuncio alla mia corona a beneficio del mio amato figlio, il kronprinz Maximilian».
Così calò il sipario su questo prologo di tragedia, una tragedia che somiglia a un’operetta. Maximilian iniziava il proprio regno. Il piccolo Amleto, suo figlio, aveva solo tre anni, lui che poi avrebbe detto, come l’altro: «Il secolo è in frantumi. Oh! Che maledizione essere nato per rimetterlo in ordine!».
![]()
2
Un principe da fiaba
Maximilian era molto alto e molto magro, con una piccola testa dalla fronte ampia piantata su un bel busto, tornito e snello. Occhi profondi, voce dolce e acuta da signora; un uomo saggio, privo di genialità, ma risoluto, onesto, desideroso di imparare senza altra passione al di fuori di quella. Sua moglie, la principessa Maria di Prussia, era soprannominata «l’angelo» tanto per il suo volto di Madonna fiorentina quanto per la sua purezza di cuore e semplicità di spirito. Sposata all’età di diciassette anni, era arrivata a Monaco con i suoi giocattoli e le sue bambole appena quattro anni prima di Lola Montez. In quella corte di vecchi scapoli la principessa aveva portato una freschezza ingenua e il sangue patologicamente malato delle casate di Brunswick-Hannover e Brunswick-Hohenzollern. Ma il vecchio re Paride non si preoccupava di destini indecifrabili. Fece fare il ritratto della nuora per la sua galleria di bellezze, dove danzatrici, ragazze del popolo, attrici e principesse rallegravano i suoi ozi di monarca non più al potere.
Max prese molto sul serio la sua carica, circondandosi di dotti e di ministri. Una volta alla settimana, la sera, ricevimento al castello, in marsina e cravatta nera. Si riunivano nel suo studio, che sembrava una cappella, perché era molto pio. E persino tormentato dai misteri della teologia. Fu così che, una volta, chiese al professor Jolly «se la sua scienza non gli permettesse di stabilire con certezza che i signori di questo mondo avrebbero avuto anche nell’altro una posizione privilegiata». I dotti si guardarono l’un l’altro, bevvero la loro mezza pinta di birra e non si fecero scrupolo di rispondere: «Sire, questi sono problemi che non capite». Quanto alla regina, ascoltava come meglio poteva le letture dei poeti, ma garbatamente li pregava affinché, ovunque comparisse la parola «amore», fosse sostituita con «amicizia». Nel frattempo, il piccolo Ludwig, il loro figlioletto, si divertiva a costruire case sul parquet. Cosa che piaceva al nonno. «I Wittelsbach – diceva – ce l’hanno nel sangue».
Passano alcuni anni. Ludwig e il fratello minore Otto crescono senza avvenimenti notevoli e si sviluppano senza gioia. I principi vengono allevati nella bambagia, ascoltano i loro precettori e si annoiano. Un solo piacere all’orizzonte: la campagna e i grandi castelli in Baviera. Soprattutto quello di Hohenschwangau, il paese dei cigni, sulle cui pareti è dipinta la storia del cavaliere Lohengrin: l’addio al castello del Santo Graal; l’imperatore che sente suonare la tromba del cavaliere; la vittoria dell’eroe nel torneo; il matrimonio di Lohengrin con la duchessa di Bouillon.
Ore di uno sfrenato fantasticare di fronte a quelle fantasmagorie. «Ore sprecate! – sbotta il precettore. – Perché non vi fate leggere qualcosa, Altezza, invece di annoiarvi a oziare in questa penombra?». «Oh! Non mi annoio affatto. Immagino cose belle e mi diverto».
Con la violenza si cerca di distrarre questo bambino troppo pensoso. Inutile. Ama il silenzio nelle cui profondità improvvisamente sente delle voci. Quali voci? Ascolta. Smette di scrivere o di giocare. Vorrebbe capire e indica il luogo da cui gli sono giunte le parole di un compagno invisibile.
Il medico di corte, Gietl, assiste a tutto ciò e prende appunti. «Infanzia troppo solitaria – pubertà – non si sa…». Il padre lo rimprovera e non crede nei fantasmi o negli spiriti che parlano. I bambini vengono messi a dieta. Si fa quasi patire loro la fame. Si raddoppiano i compiti. Il padre esige che abbiano una cultura «universale». Loro tremano di fronte a questo rigido pedante, che si atteggia a professore delle realtà regali e bavaresi.
Ma pur essendo molto dotato e intuitivo, Ludwig è uno studente mediocre. Maestri come Liebig, il chimico, e il famoso teologo Döllinger, quasi non ce la fanno a istruirlo. Eppure sono i suoi unici amici. Niente gioventù intorno ai principi, non è ammesso nessun compagno della loro età. E quando tutto non procede come desidera, il padre dalla voce dolce non esita a infliggere lui stesso punizioni corporali. Mai nulla di simile a una paghetta, o comunque cifre quasi irrisorie: una decina di gulden al mese, a diciassette anni.
Sono semplici dettagli, ma che è importante conoscere. Perché è durante questi anni, in cui si preparano alla vita, che si definiscono i piccoli grandi difetti, le abitudini, le antipatie, le tenerezze e le crudeltà che ben presto porteranno queste anime ancora mute e impotenti a vendicarsi sugli altri – e su sé stesse – delle repressioni, delle ferite all’orgoglio, degli egoistici piaceri che lentamente le hanno modellate. La prima volta che, raggiunta la maggiore età, gli fu consegnata una piccola somma, il principe Ludwig volle comprarsi l’intera vetrina di un gioielliere. Non capì mai che i cinque o sei pezzi d’oro che possedeva non erano sufficienti. Da allora in poi, rinunciò per sempre ad approfondire questo genere di cose.
D’altronde, il denaro non è forse una semplice convenzione? E i sentimenti di affetto filiale? (Non osava quasi pensarci). E il potere? E la corona? E la vita? (Tutte astrazioni). Cosa c’è di realmente vero, necessario, personale, buono, in questa fabbrica quotidiana di incombenze in cui ogni quarto d’ora è programmato in anticipo e detestato? Ebbene, ecco qua: l’unica realtà è il sogno; l’unica felicità, la solitudine; l’unico amore, quegli slanci sordi e profondi, pieni di una sensualità attiva, che ti gettano con la bocca protesa verso gli uomini e le donne che compaiono nei libri, nei quadri o sugli arazzi. Il cavaliere dei cigni, la bella duchessa, le nuvole al tramonto, le foreste, il corno dei guardacaccia, il canto di un pastore, le uniche cose che sono veramente vive e che collegano le grandi verità della poesia ai fantasmi della realtà. E anche la pesca al luccio, all’alba, nei laghi. E ancora, e sempre, il poema di Lohengrin, che aveva letto segretamente a tredici anni; poema che, a quanto pare, un musicista aveva composto e che lui conosceva a memoria da cima a fondo, senza dimenticare un solo verso; proprio lui che non riusciva a mettersi in testa una sola pagina di grammatica.
Ora, nel 1861, l’Opera di Monaco aveva messo in scena il Tannhäuser e il Lohengrin. Tremando, Ludwig chiede a suo padre di potervi assistere. Ottenuto il permesso, l’adolescente ci va accompagnato soltanto dal conte di Leinfelder, il suo aiutante di campo. È la prima volta che ascolta la musica di Wagner. Lo shock è tale che l’aiutante di campo, notando le reazioni del principe, osserva trance inquietanti, che sembrerebbero dolorose. «Ad esempio – scrive – quando Tannhäuser torna al Venusberg, il corpo del principe fu scosso da veri e propri spasmi. Erano così violenti che per un attimo temetti una crisi epilettica». Ma la musica non è la causa principale di questo turbamento. Lo sono la poesia, le idee, i simboli dietro i quali si apre tutto un mondo insospettato. Ludwig non riesce a pensare ad altro che a questo, e qualche tempo dopo, sul pianoforte di suo zio, ruba un libro di Wagner, L’opera d’arte dell’avvenire. Che nutrimento! Che programma! Fu soprattutto la parola avvenire a contagiare come una malattia quella sensibilità a rischio di rimozione.
«L’opera d’arte è un atto di vita», leggeva. (Tra quali menzogne era dunque stato allevato?) Soltanto il popolo è latore delle grandi necessità della vita e dell’arte. È la forza efficiente dell’opera d’arte, che è una creazione in comune. «Finora un solo popolo è riuscito a ottenere questa comunità nella pulsione artistica, il popolo greco; perciò dobbiamo fare dell’arte ellenica l’arte umana in generale». (Toh! Ecco che mio nonno è l’unico ad averci visto chiaro!) «L’uomo deve essere considerato il suo oggetto e soggetto artistico. Ma il suo orgoglio, il pieno potere delle sue sensazioni fisiche, e persino i sentimenti del suo cuore, cadranno non appena si manifesteranno all’uomo intelligente, in quanto sentimenti e sensazioni comuni a tutte le specie. Egli non può volere che l’universale, il vero, l’assoluto, il proprio assorbimento, non nell’amore di questo o quell’oggetto, ma nell’amore in generale. Così l’egoista diventa altruista, l’Uno diventa Tutto; l’uomo diventa Dio; e l’artificio, arte». Ora, la musica è il cuore dell’uomo. La sua lingua, l’arte dei suoni. «La musica è l’amore del cuore nella pienezza del suo ribollire; è l’amore che nobilita la voluttà e umanizza il pensiero astratto». «Nel regno dell’armonia non c’è né inizio né fine, così come l’intimo ardore dell’anima non è altro che aspirazioni, slanci, languore, termine, ovvero morte. Ma morte senza morte, a causa di un eterno ritorno a sé stessi». E il poeta? Che decadenza nella sua attuale ricerca delle realtà pratiche! «Il vero bisogno del nostro tempo si manifesta solo in vista dell’utilità più stupida. Esistono solo dispositivi meccanici, ma non creazioni artistiche che siano adeguate». Una sola via d’uscita: «La redenzione nell’opera d’arte dell’avvenire. Arti puramente umane, senza egoismo; la redenzione dell’uomo utilitaristico da parte dell’uomo artistico». Soltanto allora il mondano redento farà scaturire dal profondo del suo cuore la parola che Beethoven ha posto come una corona in cima alla sua opera: «Gioia, abbracciatevi, o moltitudini!» Questo sarà il linguaggio delle opere d’arte del futuro.
Ah! Era davvero il maestro atteso, colui che proclamava una tale speranza.
Nel 1863 Ludwig compì diciott’anni, divenendo così maggiorenne. Quello stesso anno assistette alla questione dello Schleswig-Holstein, che agitò l’intera Baviera. Malato e stanco, re Maximilian era andato in Italia, dove pensava di poter godere di un lungo periodo di riposo. La politica lo richiamò nella sua capitale, perché tutto il popolo voleva che si facesse carico della causa dello Schleswig indipendente. Maximilian non osò opporsi all’Austria né a Bismarck. La lotta che sostenne contro sé stesso e la propria coscienza finì con lo spezzare quella fragile maestà. Dopo tre giorni di malattia, il 10 marzo 1864, senza sofferenze e inquietudini, Maximilian spirò.
In tutta la Germania ci fu stupore. A Monaco la folla in lutto riempiva le strade e il palazzo reale. Benno, la grande campana della Frauenkirche, suonava incessantemente a morto. Il 14 marzo si celebrò il funerale. Tutto il popolo assistette alla processione funebre: principi, ambasciatori, delegati, generali e cavalleria. Poi venne il catafalco. Tutte le teste si protesero per vedere sfilare il nuovo re, quel ragazzo che si diceva fosse selvaggio, enigmatico, scarsamente preparato.
Ora, in un immenso silenzio, dietro il carro funebre un giovane dio avanzava, a testa alta, grave, ma quasi sorridente. Uno sconosciuto, che tutti però ricordavano di aver visto. Visto dove? Visto quando? Cercavano di ricordare. E improvvisamente lo seppero, si batterono la fronte e risero dopo aver capito. No, non era un vero re, un re in carne e ossa, come gli altri. Era un principe da fiaba, un re leggendario, un poeta che gli dèi dell’Olimpo avevano mandato sulla terra in segno di amicizia verso il fedele popolo di Monaco. E già tutti i cuori degli uomini, tutti gli sguardi delle donne sfavillavano d’amore.
![]()
3
Due poeti
Che follia incolpare i giovani di essere troppo precipitosi! Che cosa avremmo a nostro attivo se, per entusiasmo, a volte non sapessimo fare strame di ciò che è ragionevole? Ludwig aveva fretta, come tutti quelli che non provano alcuna simpatia per la vecchiaia. In uno dei libri di Wagner – cari libri usati, consunti fino alla rilegatura – alla fine del prologo dell’Anello aveva letto questa frase: «Si troverà mai il principe che renderà possibile la rappresentazione della mia opera?» Al doloroso appello, il bambino, che l’altro ieri voleva comprare una gioielleria con le sue cinque monete d’oro, pensa di essere in grado di rispondere.
Un mese dopo la morte di suo padre, il 14 aprile 1864, Pfistermeister, consigliere aulico di Sua Maestà, si mette in viaggio per Vienna con l’incarico di portare al suo padrone l’unico essere vivente sulla Terra di cui egli si consideri discepolo. In quattro settimane, il timido bambino è diventato un re che dà ordini. Meglio ancora, un uomo. E un uomo risoluto, impaziente. Ci vuole molto tempo, tuttavia, per raggiungere il compositore braccato, che sta sfuggendo ai suoi problemi e ai suoi creditori da Vienna alla Svizzera, da Zurigo a Stoccarda. «Soltanto un miracolo – aveva scritto – può ancora salvarmi». E il miracolo accade. In una stanza d’albergo, a Stoccarda, Herr von Pfistermeister trova finalmente colui che sta cercando. All’uomo braccato porge un anello, una lettera e una fotografia da parte del suo maestro. Tre giorni dopo, il 5 maggio, Wagner compare davanti al re.
Ludwig, in piedi, è tornato un bambino timido. A malapena osa alzare lo sguardo su questo omino con le gambe corte e una testa troppo grande. Intravede la fronte sporgente, il viso vecchio, i forti lineamenti da tempo scolpiti dalla celebrità. Questo Lohengrin cinquantenne, che amico per la sua anima vergine! Tende la mano. L’altro si fa avanti, la afferra, si inchina. È il momento, come dice Goethe, «dell’ubriacatura senza vino». A lungo Wagner rimane chino, pieno di silenzio. E all’improvviso il re lo attira al petto, pronunciando dentro di sé il giuramento di fedeltà eterna.
«Vi rivolgo» scriveva Wagner il giorno prima al re «le lacrime di un’emozione celeste per dirvi che ora i miracoli della poesia sono entrati nella mia vita infelice e assetata d’amore, come una realtà divina…». E Ludwig risponde ora: «Senza saperlo, voi siete stato l’unica fonte delle mie gioie e, fin dalla mia prima infanzia, il mio miglior maestro, il mio precettore e un amico che, come nessun altro, ha saputo parlare al mio cuore».
Di fronte a una gioia così intensa, Wagner rimane quasi incredulo. Perché gli uomini, che hanno sognato la felicità per tutta la vita, quando finalmente la raggiungono non possono crederci. Il suo conseguimento non trova mai posto in loro. Non c’è dubbio che, dietro questo culmine di felicità, si nasconda qualche sventura. «Mi capisce come la mia anima», confida agli amici di Zurigo… «Della magia del suo sguardo non potete farvi un’idea…». Ma «ahimè, è così bello e così pieno di spiritualità che ho paura di vedere la sua vita svanire come un sogno divino in questo mondo ignobile». «Credo» scrive al suo amico Bülow «che se dovesse morire, morirei anch’io un istante dopo». Ma in un primo momento c’è solo l’entusiasmo e l’azione. Il re paga i debiti del musicista, gli assegna una rendita e fa affittare per lui la villa del conte Pellet, sul lago di Starnberg, a un quarto d’ora di carrozza dal suo castello di Berg. Un mese dopo, il 14 maggio, Wagner vi si trasferisce. Tutto avviene come nelle Mille e una notte. Ora sono così vicini l’uno all’altro, i due poeti, che a qualsiasi ora possono farsi visita, immergersi in immense contemplazioni, elaborare insieme i piani del palazzo dell’ideale che apriranno al mondo, o sprofondare senza dire una parola, tenendosi per mano, negli abissi della propria gioia. Il giovane re ha trovato il suo vero padre, il suo unico amico; il Viaggiatore la sua patria, il suo mon...