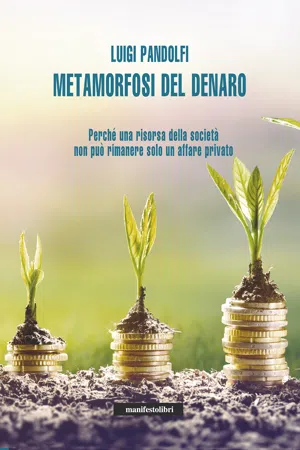![]()
IV
Come si crea il denaro?
Una costante nella storia della moneta è stata la contrapposizione, sia pratica che concettuale, tra moneta del sovrano e moneta del popolo. Chi deve avere la prerogativa del conio? In questa domanda sta il punto di caduta di una questione che ancora oggi è dirimente (ne è prova anche la disputa sulla legittimità delle monete locali complementari sorte un po’ ovunque nel mondo negli ultimi anni). La fine degli accordi di Bretton Woods, tra le altre cose, ha comportato una sostanziale privatizzazione del controllo e della gestione del denaro.
Attualmente, il rapporto tra moneta legale, il contante emesso da una banca centrale, e moneta bancaria, generata in maniera endogena dal sistema attraverso prestiti, carte di credito, assegni, bonifici ed altre attività finanziarie, è totalmente sbilanciato a favore di quest’ultima, complice anche lo sviluppo dell’elettronica e della tecnologia informatica. Se prendiamo come riferimento l’eurozona, vediamo come il 90% del denaro in circolazione, sotto forma di depositi ed altri assets finanziari, è generato autonomamente dal sistema bancario, mentre solo il 10%, del quale il 2-3% è rappresentato da banconote di carta e spiccioli metallici, è emesso dalla Bce per il tramite delle banche centrali nazionali. È del tutto evidente, pertanto, che proprio la perdita di controllo sull’emissione e la gestione del denaro da parte dell’autorità politica costituisca uno dei problemi principali del nostro tempo.
Il ruolo delle banche centrali
Oggi gli Stati, salvo casi eccezionali e residuali, non godono di alcuna potestà nell’emissione e nel controllo della moneta. Semmai, si indebitano per avere moneta. Si è pienamente realizzato il sogno di David Ricardo, che, già agli inizi del secolo diciannovesimo, parlava di separazione istituzionale tra il potere di creare denaro e quello di spenderlo e di divieto di finanziamento monetario del bilancio dello Stato1.
Dunque? Considerata la separazione tra autorità politica ed autorità monetaria, più o meno netta nei vari Paesi del mondo, si potrebbe pensare che le uniche entità preposte a questa funzione siano le banche centrali. A ben vedere, però, le cose non stanno esattamente così. Prendiamo il caso della Banca Centrale Europea (BCE). Essa assolve fondamentalmente alla funzione di banca delle banche commerciali. E in questo modo influenza l’attività di immissione di moneta nel sistema, che, come si è capito, si svolge prevalentemente a latere, attraverso il credito a cittadini, famiglie, imprese e governi. Lo fa dosando i prestiti a breve e lungo termine alle banche e manovrando i tassi d’interesse (tassi più bassi sono un incentivo a chiedere prestiti e viceversa). Ma anche attraverso altre operazioni. Tra queste, l’acquisto o la vendita di titoli di Stato dalle banche ordinarie. Acquistando, immette nuova liquidità nel sistema; vendendo, ritira moneta dal sistema. Le stesse situazioni che si verificano intervenendo sulle riserve obbligatorie, vale a dire l’ammontare di fondi che le banche commerciali devono depositare nei loro conti correnti presso la Banca centrale. Se la Bce decide di alzarlo, ritira moneta; se lo abbassa, di fatto ne crea di nuova. Per quanto riguarda le monete, di carta o metalliche che portiamo nel nostro portafoglio, la Bce ha delegato le banche centrali dei Paesi membri. Sono quest’ultime a stamparle e a coniarle, sulla base dei «volumi di produzione»2assegnati dall’autorità monetaria centrale che ha sede a Francoforte.
Da tutto questo, si evince che la Banca Centrale Europea – il discorso però potrebbe essere esteso anche alle altre banche centrali nazionali dei principali Paesi del mondo – crea certamente denaro dal nulla e governa la politica monetaria in maniera indipendente, ma il sistema si presenta imperniato essenzialmente sulla funzione di sportello (o di rubinetto) delle banche ordinarie. Quest’ultime, non solo godono di margini amplissimi nella creazione di denaro attraverso il credito, ma costituiscono il vero fulcro dell’attuale sistema finanziario ed istituzionale in Europa e nel mondo (sistema bancocentrico). Sono le banche commerciali che danno i soldi agli Stati dietro l’emissione, da parte di quest’ultimi, di titoli obbligazionari, che, a loro volta, sono utilizzati come garanzia dalle stesse banche ordinarie per ricevere liquidità dalla Banca centrale. Un giro, come si può notare, nel quale gli Stati ed i governi giocano un ruolo del tutto passivo, subalterno. Per fare il denaro non c’è più bisogno al giorno d’oggi di avere i forzieri carichi di oro o di altro metallo, né di andare a scavare nuove miniere. Basta la volontà e la necessità. Sono lontanissimi i tempi in cui Marx ricordava come l’aumento dell’offerta di moneta nella seconda metà del suo secolo fosse dipesa da «un afflusso d’oro eccezionale, in seguito alla scoperta delle nuove miniere d’oro australiane e californiane»3. Ma anche quelli in cui Keynes scriveva che quando «l’oro è accessibile a profondità adatta, l’esperienza dimostra che la ricchezza del mondo aumenta rapidamente» e che, quindi, «le miniere d’oro hanno il massimo valore e la massima importanza per la civiltà»4.
Eppure, il governo della moneta fiat – cosa diversa dal semplice potere di emissione – è oggigiorno appannaggio esclusivo del sistema bancario, a sua volta del tutto autonomo ed indipendente dal potere politico, nel quale, per di più, hanno assunto una forza strabordante le banche commerciali. Per quanto si parli di moneta a corso forzoso, alludendo ad una funzione coercitiva dello Stato ed alla dimensione legale della stessa, i sistemi monetari attuali sono molto più vicini a quelli classificati come free banking5 che non a quelli incardinati sulla primazia delle pubbliche autorità e delle stesse banche centrali. I livel li di creazione di moneta, in altri termini, corrispondono sempre più alle esigenze ed agli interessi delle banche e sono condizionati dalle loro aspettative. Gli Stati, in questo sistema, sono solo dei compratori di moneta, al pari dei privati cittadini e delle imprese, mentre le banche centrali ne costituiscono solo le vestali, non riuscendo più a controllare tutta la moneta in circolazione attraverso i cosiddetti aggregati monetari6. Il paradosso di questa situazione è che la separazione tra banche centrali e governi – in Italia formalmente nel 19817 – fu perorata dalle élite e dai tecnocrati di cultura neoliberista perché la caduta del vincolo aureo avrebbe potuto indurre la classe politica a stampare soldi a volontà in base non solo alle esigenze della società, ma anche dei loro interessi elettorali. Il risultato è stato che di soldi se ne stampano a iosa, ma al di fuori di ogni controllo da parte degli organi della rappresentanza democratica e, in molti casi, contro gli interessi stessi della società.
Il laboratorio europeo
In Europa, la separazione funzionale tra governi e autorità monetaria è stata portata fino alle estreme conseguenze. Sicché, l’Unione economica e monetaria è venuta ad assumere sempre più, ed anche per questo, le sembianze di un laboratorio estremo della controrivoluzione neoliberale, il luogo d’elezione per l’implementazione radicale della regola monetarista, dove l’ossessione per l’inflazione è inversamente proporzionale all’attenzione per i bisogni reali delle persone.
In assenza di un esecutivo, di un bilancio e di un tesoro federali, la Banca Centrale Europea è, di fatto, la banca di tutti e di nessuno. Una banca centrale senza Stato e, di converso, un gruppo di Stati che hanno perso la propria banca centrale nazionale (fatte salve alcune funzioni residuali e di complemento dentro il Sistema Europeo delle Banche Centrali, il SEBC): un unicum nella storia della moneta e degli Stati moderni.
La Bce fa la «banca delle banche», come si legge nei documenti ufficiali, ma non assolve alla funzione più importante di una banca centrale: fungere da prestatri ce di ultima istanza (comprare i titoli di prima emissione quando gli investitori recalcitrano, sfidano, speculano) e garantire illimitatamente il debito dei Paesi membri. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, lo fa indirettamente (non è la stessa cosa), in piena discrezionalità e senza alcun raccordo con il livello politico – che poi è il livello democratico – dei Paesi dell’eurozona, i quali, di conseguenza, rimangono costantemente in balia degli appetiti e dei calcoli speculativi dei mercati finanziari.
Quante volte avete sentito dire «bisogna tranquillizzare gli investitori»? Oppure che una data scelta politica potrebbe non essere «gradita» ai mercati finanziari? Ad ogni sessione di bilancio, almeno. Perché sono i mercati che «ci finanziano», che ci danno i soldi. Sono loro che decidono il prezzo del denaro che danno in prestito agli Stati, sottoscrivendo le loro obbligazioni. Pertanto, se gli Stati voglio tenere basso il cosiddetto «servizio del debito», ovvero pagare meno interessi sui soldi che ricevono in prestito, devono rigare dritto, attenersi ad una politica fiscale parsimoniosa, che significa, molto banalmente, spendere meno di quanto si raccoglie attraverso le tasse. È la storia dei cosiddetti «avanzi primari», vale a dire dei saldi tra entrate ed uscite dello Stato, «prima» che vengano calcolati gli interessi sul debito. A questo serve il cosiddetto «pareggio di bilancio», che in Italia è stato addirittura costituzionalizzato. Non è necessario raggiungerlo realmente, basta tenerlo permanentemente come obiettivo, controllando e comprimendo la spesa pubblica, in modo da garantire che una parte del bilancio statale sia sempre a disposizione dei creditori.
L’Italia, da questo punto di vista, è stata la nazione più virtuosa nel consesso europeo. Dal 1992, anno in cui è stato firmato il Trattato di Maastricht, il nostro Paese ha realizzato, infatti, avanzi primari per ben 676 miliardi di euro. Nello stesso periodo, la Germania ha totalizzato, invece, un risultato di 307 miliardi di euro. Meno della metà. In soldoni – è proprio il caso di dirlo! – l’Italia mantiene da decenni, ormai, il livello della propria spesa pubblica al di sotto del livello medio-annuo della raccolta fiscale, trasferendo una quota importante delle tasse che pagano i cittadini al finanziamento del debito. Ma, purtroppo, questi sacrifici non sono sufficienti (nello stesso periodo la spesa per interessi è stata di ben duemila miliardi di euro). Gli interessi galoppano ad un ritmo quasi doppio rispetto ai risparmi statali e il debito, anziché scendere, continua a crescere espon...