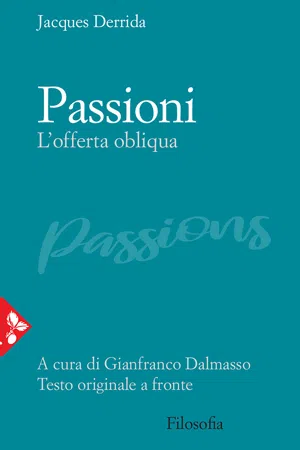Fra l’attore e l’analista, qualunque sia la distanza, quale che siano le differenze, la frontiera sembra dunque incerta. Sempre permeabile. Essa deve anche essere attraversata in un certo punto affinché vi sia un’analisi ma anche perché vi sia comportamento appropriato e normalmente ritualizzato.
Immaginiamo dunque quest’opera proposta (consegnata, offerta, data) ad un lettore analista preoccupato di essere obiettivo. Tale analista può essere tra noi: non importa se come destinatario o destinatore di questo libro. Possiamo immaginare ciò senza aprire ad un tale lettore un credito illimitato. In ogni caso, l’analista (scelgo questa parola, certamente, pensando all’uso che ne fa Poe1) sarebbe sicuro, forbse per imprudenza, di essere qui davanti lo svolgimento codificato, prevedibile e prescritto di una cerimonia. Cerimonia sarebbe senza dubbio la parola più giusta e più ricca per raccogliere tutti i tratti dell’evento. Come potrei, dunque, come potreste, come potremmo, come potrebbero non essere cerimoniosi? Qual è il soggetto, esattamente, di una cerimonia?
Ecco che nella descrizione e nell’analisi del rituale, nella sua decifrazione o, se preferite, nella sua lettura, tutt’ad un tratto sorgerebbe una difficoltà, una sorta di disfunzione, altri direbbero una crisi; traducete: un momento critico. Forse esso2 intaccava già lo svolgimento stesso del processo simbolico.
Quale crisi? Era prevedibile o imprevedibile? E se la suddetta crisi concernesse ancora il concetto stesso di crisi o di critica?
Dei filosofi si sono trovati riuniti in quest’opera secondo procedure accademiche ed editoriali che ci sono familiari. Sottolineamo la determinazione critica, impossibile perché aperta, aperta a voi, esattamente, di questo pronome personale: chi è «noi», chi siamo noi esattamente? Questi filosofi, universitari di vari paesi, sono conosciuti e si conoscono quasi tutti (qui dovrebbe seguire una descrizione dettagliata di ciascuno di loro, del loro tipo e della loro singolarità, della loro appartenenza sessuale – una sola donna –, della loro appartenenza nazionale, del loro statuto socio-accademico, del loro passato, delle loro pubblicazioni, dei loro interessi, etc.). Essi si erano messi d’accordo, su iniziativa di uno tra loro, uno che non può essere non importa chi e gli interessi del quale non sono certo privi di interesse, per riunirsi e partecipare ad un libro il cui centro (relativamente determinato, dunque indeterminato, si potrebbe dire segreto sino ad un certo punto – e la crisi resta troppo aperta per meritare ancora questo nome di crisi) sarà un tale o un tal’altro (relativamente determinato, etc., relativamente identificabile, in principio, per il suo lavoro, le sue pubblicazioni, il suo nome proprio, le sue firme. Lasciamo «firme» al plurale perché è impossibile, all’inizio, ed illegittimo, benché legale, escluderne la molteplicità). Ora se una difficoltà critica si produce in questo caso e rischia, ma non è ancora sicuro, di mettere in difficoltà i programmi del rito o della sua analisi, essa non riguarda necessariamente il contenuto, le tesi, le valutazioni positive o negative, il più delle volte sovradeterminate all’infinito, in breve alla qualità del discorso degli uni e degli altri, a quanto essi traducono ed a quanto fanno circa il loro rapporto al titolo, al pretesto o all’oggetto del libro. Essa3 concerne il fatto che si è creduto di dover chiedere, proporre, offrire (per delle ragioni che è possibile analizzare) al firmatario supposto dei testi che sono al centro del libro («io», non è vero?) d’intervenire come si dice, di «contribuire», ciò che significa apportare il proprio tributo, facendolo liberamente, nel libro. Sul grado di questa libertà diremo una parola fra poco; è quasi il tutto della questione. L’editore dell’opera, capo del protocollo o maestro di cerimonia, David Wood, aveva suggerito che il libro fosse qui stesso aperto in qualche pagina da un testo che, senza veramente rispondere a tutti gli altri, potesse figurare sotto il titolo significante di «L’offerta obliqua» (An oblique offering). Cosa? Di chi? A chi? (resta da vedere). Tutto ad un tratto, dicevamo, lo svolgimento del rito rischia di non essere più conforme alla sua automaticità, cioè alla prima ipotesi dell’analista. C’è una seconda ipotesi. Quale? Ad un certo punto nel sistema, uno degli elementi del sistema (un «io», nevvero, anche se non è sempre e con «disinvoltura4» un «io») non sa più cosa deve fare. Più esattamente, sa che deve fare cose contraddittorie ed incompatibili. A contraddirsi e contrariarsi essa stessa, questa doppia obbligazione rischia di conseguenza di paralizzare, di sviare o di mettere in pericolo il felice compimento della cerimonia. Ma l’ipotesi di questo rischio va contro o al contrario incontro al desiderio dei partecipanti, a supporre che non ce ne sia che uno, che ci sia un solo desiderio comune a tutti o che ciascuno non abbia in sé che un desiderio non contraddittorio? Perché si può immaginare che uno o più dei partecipanti, addirittura il maestro di cerimonia stesso, auspichi in qualche maniera lo scacco della detta cerimonia. Più o meno segretamente, ciò va da sé; ecco perché bisognerà per noi dire il segreto, non rivelarlo, ma sull’esempio di questo segreto pronunciarci sul segreto in generale.
Che cos’è un segreto?
Sicuro, se quest’opera non corrisponde in niente ad una cerimonia segreta, si immagina che non c’è cerimonia, per quanto pubblica ed esposta sia, che non giri intorno ad un segreto, persino se è il segreto del non-segreto, se non ciò che in francese si chiama un «secret de Polichinelle», un segreto che non è un segreto per nessuno. Nella prima ipotesi dell’analista, la cerimonia si svolgerebbe normalmente, secondo il rito; raggiungerebbe il suo fine al prezzo di una svolta o di una sospensione che non solamente non l’avrebbe minacciata in niente, ma l’avrebbe forse confermata, consolidata, aumentata, abbellita o intensificata di un’attesa (desiderio, prima seduzione, piacere preliminare del gioco, preludio, ciò che Freud chiama Vorlust). Ma cosa accadrebbe nella seconda ipotesi? È forse la questione che a mo’ di risposta e in segno di infinita riconoscenza avrei invitato a porre, io, a mia volta e per prima cosa a tutti coloro che hanno avuto la generosità di apportare il loro contributo a quest’opera.
Per amicizia come per gentilezza ci sarebbe un doppio dovere, non sarebbe questo un evitare appunto, a qualsiasi prezzo, e il linguaggio del rito e il linguaggio del dovere? La duplicità, l’essere-doppio di questo dovere non si conta in 1+1=2, o in 1+2, ma si scava al contrario in abisso infinito. Un gesto «d’amicizia» o «di gentilezza» non sarebbe né amichevole né gentile se obbedisse puramente e semplicemente ad una regola rituale. Ma questo dovere di sfuggire alla regola della convenienza ritualizzata esige anche di portarsi al di là del linguaggio stesso del dovere. Non si deve essere amichevole o gentile per dovere. Rischiamo una tale proposizione, senza dubbio, contro Kant. Ci sarebbe, dunque, un dovere di non agire secondo il dovere, né conformemente al dovere, direbbe Kant (pflichtmässig), né persino per dovere (aus Pflicht)? In che cosa un tale dovere, un tale contro-dovere, ci indebiterebbe? Vicino a che cosa? Vicino a chi?
Presa seriamente, questa ipotesi in forma d’interrogazione basterebbe a dare la vertigine. Farebbe tremare, porterebbe persino a paralizzarsi sull’orlo del baratro, laddove sareste soli, del tutto soli o già mobilitati da un corpo a corpo con l’altro, un altro che cercherebbe invano di trattenervi o di precipitarvi nel vuoto, di salvarvi o di perdervi. Si può supporre, ci ritorneremo, che a tale riguardo non si possa mai scegliere.
Poiché noi rischiamo di non sapere più dove potrebbe trascinarci l’evidenza, osiamo dire il doppio assioma impegnato nell’ipotesi o nella questione dalla quale si è dovuto cominciare. Senza dubbio sarebbe scortese dare l’impressione di fare un gesto, per esempio rispondendo ad un invito, per semplice dovere. Sarebbe anche non amichevole rispondere ad un amico per dovere. Non varrebbe di più rispondere ad un invito o ad un amico conformemente al dovere, pflichtmässig (piuttosto per dovere, aus Pflicht, citiamo di nuovo la Grundlegung zur Metaphysik der Sitten [La fondazione della metafisica dei costumi] di Kant, nostro «critical reader» esemplare, indebitati come noi siamo, in quanto eredi, vicino al grande filosofo della critica). Tutto questo aggiungerebbe in effetti all’essenziale mancanza una mancanza ulteriore: credere di rendersi irreprensibili giocando con l’apparenza laddove l’intenzione fa difetto. E dunque poco dire che il «bisogna» dell’amicizia, come quello della gentilezza, non deve essere dell’ordine del dovere. Non deve neppure prendere la forma di una regola e soprattutto non di una regola rituale. Se cedesse alla necessità di applicare ad un caso la generalità di una prescrizione, il gesto di amicizia o di gentilezza si distruggerebbe esso stesso. Sarebbe vinto, battuto e spezzato dalla rigidità regolare della regola, ossia della norma. Assioma da cui non bisogna più concludere che non si accede all’amicizia o alla gentilezza (per esempio rispondendo all’invito, cioè alla domanda o all’interrogazione di un amico) solo trasgredendo ogni regola e andando contro ogni dovere: la controregola è ancora una regola.
Un lettore critico sarà forse sorpreso di veder qui regolarmente associati l’amicizia e la gentilezza, ambedue distinte, da un sol tratto, dal comportamento ritualizzato. E che qui l’ipotesi concernerebbe, nella gentilezza, nella determinazione acuta di questo valore, che sia o meno legato a tale o tal’altra tradizione culturale (occidentale o no), ciò che ingiunge di portarsi al di là della regola, della norma e dunque del rito. La contraddizione interna al concetto di gentilezza, come a ogni concetto normativo di cui sarebbe l’esempio, è che esso implica la regola e l’invenzione senza regola. La sua regola è che si conosca la regola, ma senza mai attenervisi. Non è gentile essere sempre gentili, essere gentili per cortesia. Abbiamo dunque qui una regola – e questa regola è ricorrente, strutturale, generale, ossia ogni volta singolare ed esemplare – che ordina l’agire in modo tale che non si agisca soltanto per conformità alla regola normativa ma nemmeno, in virtù della suddetta regola, per rispetto ad essa.
Procediamo direttamente, senza svolta obliqua, senza astuzie e senza calcolo (N’y allons pas par quatre chemins), si tratta del concetto di dovere e di sapere se o sino a qual punto ci si può fidare di lui, che cosa esso struttura nell’ordine della cultura, della morale, della politica, del diritto e persino dell’economia (specialmente quanto al rapporto fra il debito e il dovere5); cioè sino a qual punto ci si può fidare del fatto che il concetto di dovere detenga una funzione dominante in ogni discorso responsabile sulla decisione responsabile, in ogni discorso, ogni logica, ogni retorica della responsabilità. Parlando di discorso responsabile sulla responsabilità, implichiamo già che il discorso debba sottomettersi alle norme o alla legge di cui parla. Questa implicazione sembra ineluttabile, ma resta sviante: cosa potrebbe essere la responsabilità, la qualità o la virtù della responsabilità, di un discorso conseguente che pretendesse dimostrare che una responsabilità non potrebbe mai essere assunta senza equivoco e senza contraddizione? Che l’autogiustificazione di una decisione è impossibile e non potrebbe, a priori e per ragioni di struttura, rispondere assolutamente di sé stessa?
Abbiamo appena detto: «n’y allons pas par quatre chemins – locuzione francese quasi intraducibile che invoca la croce o il cruciale, l’incrocio delle vie, il quattro e la forca del crocevia (quadrifurcum) per dire: procediamo direttamente, senza svolta obliqua, senz’astuzia e senza calcolo –: si tratta del concetto di […] e di sapere se […]». Cosa suppone una parola d’ordine così imperativa? Che si possa o si debba approcciare un concetto o un problema di fronte, in modo non obliquo. Ci sarebbe un concetto e un problema (di questo o di quello, del dovere, per esempio, poco importa per il momento), ossia qualche cosa di determinabile per un sapere («si tratta di sapere se») e che «si trova davanti a voi, là davanti (problema)6, in front of you, da qui la necessità di approcciare di fronte o di faccia, in modo contemporaneamente diretto, frontale e capitale, ciò che si trova davanti ai vostri occhi, alla vostra bocca, alle vostre mani (e non alle vostre spalle), là davanti come un oggetto pro-posto o pre-posto, un problema da trattare, un soggetto proposto, dunque, parimenti (cioè consegnato, offerto: si offre all’inizio sempre sul davanti, non è vero? In principio). Nel seguire la semantica di problema7, si tratterebbe anche di un fuori-soggetto (ob-sujet) avanzato come una gettatezza o come il promontorio di un capo8, un’armatura o un indumento di protezione. Problema9 di...