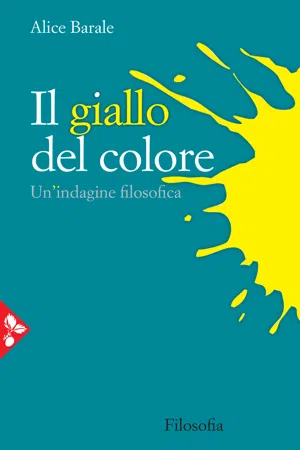1. Una svista di Wittgenstein?
Che cosa succede se dai colori nella loro essenza (il dibattito sull’ontologia dei colori, considerato nel primo capitolo), o dai colori nei loro effetti (la questione del significato simbolico del colore, affrontata nel capitolo scorso), spostiamo l’attenzione sui colori come parole? Cosa significa la parola «rosso», o «blu», o «bianco»? È questa una domanda che sarà capitato a molti di farsi. A cosa penso, quando penso alla parola «blu»: a quel determinato grado di blu che ho appena visto da qualche parte, o a il blu in generale – e in questo caso, come?
Questo interrogativo è stato in un certo senso espunto dal dibattito anglo-americano sull’ontologia del colore, che ha cercato di mirare, come si è visto nel primo capitolo, direttamente al colore «sotto alle parole», al colore nella sua essenza, comunque quest’ultima venga intesa. Il problema ha finito però per riemergere ogni volta che – come nel realismo ingenuo – la filosofia del colore ha voluto fare i conti con la nostra esperienza quotidiana di quest’ultimo. Se il blu, infatti, è anche (o innanzitutto) quello che intendiamo comunemente con la parola «blu», ecco che si pone il problema di spiegare il rapporto tra quest’ultimo – il blu in generale, che la parola indica – e il blu nelle sue determinazioni particolari. Il realismo ingenuo risponde identificando il blu in generale con un’essenza, a cui la parola «blu» rinvia, e separando quest’ultima dai vari blu apparenti (o, nei termini di Gert, dalle particolari modificazioni avverbiali del blu). Svuotato delle sue determinazioni concrete, il colore come essenza reale sembra però così riavvicinarsi al colore come parola1.
D’altra parte, se si cerca di risalire a monte della distinzione operata dal realismo ingenuo tra colore reale e apparente e di rendere, come si è provato a fare nel secondo capitolo, al colore il suo carattere temporale, il problema del legame tra colore e linguaggio si ripresenta in modo ancora più forte. Ciò che emerge dal nesso tra le caratteristiche «naturali» del colore e i significati nuovi, legati al tempo, che esso di volta in volta assume – tra il bianco, ad esempio, come soglia tra il colore e la luce, e il bianco del cemento e delle città – è sempre innanzitutto, infatti, un concentrato di tempi e di storie, reali e possibili, che si depositano in un nome, il nome di quel determinato colore. Così possiamo dire con Vitali (o con Humphrey) «il giallo (o il rosso) sono io».
È necessario, quindi, tornare alla domanda iniziale: «Che cosa significano la parola “rosso”, o “blu”?». Uno degli studiosi che hanno affrontato più a fondo questo interrogativo – e che costituisce una sorta di «presenza fantasma», una singolare presenza-assenza, all’interno dell’attuale dibattito sul colore – è senz’altro Ludwig Wittgenstein. In una delle sue Osservazioni sui colori Wittgenstein scrive:
Se ci chiedessero: «Che cosa significano le parole “rosso”, “blu”, “nero” e “bianco”?» potremmo di certo indicare immediatamente certe cose che hanno quei colori, – ma la nostra capacità di spiegare i significati di queste parole non va più oltre! Del resto non ci facciamo nessuna rappresentazione [Vorstellung] del loro impiego, oppure ce ne facciamo una del tutto rozza e parzialmente falsa2.
Proprio questo passo è citato da Michel Pastoureau alla fine del suo libro I colori dei nostri ricordi3. Le osservazioni di Wittgenstein vengono interpretate dallo studioso francese, però – e questo risulta particolarmente interessante per la nostra indagine – in un senso che non sembra del tutto in accordo con le intenzioni del loro autore.
Il passo di Wittgenstein, infatti, mette in luce secondo Pastoureau il carattere «inafferrabile»4 del colore. I colori, per lo studioso francese, non corrispondono, come si è accennato nel terzo capitolo, ad alcuna realtà, ma sono una pura astrazione, un prodotto del tutto arbitrario della cultura e del linguaggio5. È questa, però, anche la visione di Wittgenstein? Davvero per Wittgenstein i colori sono «inafferrabili»? O non potrebbero i colori, proprio per il loro non poter essere ridotti a «cose»6, rappresentare piuttosto qualcosa da afferrare?
La domanda ci riporta alla questione del rapporto tra colore e tempo, sollevata nei paragrafi precedenti. Prima di rispondere, però, occorre innanzitutto inserire l’interpretazione che Pastoureau dà di Wittgenstein – interpretazione non isolata, come vedremo, all’interno dell’attuale discussione sul colore – nel suo contesto, che è quello di un dibattito ormai quasi cinquantenario7 tra i sostenitori di una concezione relativista e quelli di una concezione universalista nei confronti dei concetti e dei termini di colore. Pastoureau si schiera dichiaratamente dalla parte del relativismo: i concetti di colore non hanno un fondamento universale, ma sono il prodotto di differenze culturali e linguistiche. Vedremo nel prossimo paragrafo i possibili vantaggi e svantaggi di questa posizione. Per ora importa osservare che lo stesso Pastoureau, in un altro passo de I colori dei nostri ricordi, sembra accorgersi che la posizione di Wittgenstein non è del tutto in accordo con la sua. Lo studioso francese muove, infatti, alcune critiche al filosofo viennese, citando in particolare un’osservazione di Wittgenstein che gli pare il frutto di una clamorosa svista:
Se per i colori esistesse una teoria dell’armonia dei colori, questa dovrebbe cominciare con una ripartizione dei colori in gruppi, e dovrebbe vietare certe mescolanze o certi accostamenti e permetterne altri. E come la teoria dell’armonia, non darebbe una fondazione alle proprie regole8.
Una teoria di questo tipo tuttavia esiste, osserva Pastoureau, ed è la teoria dell’armonia dei colori araldici. È strano, secondo lo studioso francese, che Wittgenstein non se ne sia reso conto:
Senza rendersene conto, o facendo finta di non rendersene conto, Wittgenstein formula, con altre parole, la regola per l’impiego dei colori araldici in vigore dal XII secolo. Suona strano che il filosofo nato e cresciuto a Vienna e che ha compiuto parte dei suoi studi e della sua attività a Cambridge, due città dove l’araldica è presente ovunque, non si sia mai fatto delle domande sul colore del blasone né sulle loro regole di associazione – regole rigidissime, la cui origine resta ignota. A meno che il frammento di frase che ci è giunto sia solo l’introduzione a una lunga argomentazione, mai svolta, sui colori dell’araldica. Chi lo sa9.
Nel passo che Pastoureau cita, però, Wittgenstein non sembra riferirsi a un’armonia tra le tante (secondo la concezione relativistica dello studioso francese), ma a un’armonia possibile e, quindi, a un’armonia universale. Questo non significa che il filosofo viennese non abbia interesse per l’aspetto considerato da Pastoureau: la variabilità storica e culturale dei sistemi di colori. Nell’osservazione a cui lo storico francese fa riferimento Wittgenstein sembra chiedersi, però, anche qualcosa di diverso. Per comprendere esattamente che cosa, occorre considerare innanzitutto, come si è accennato, lo storico dibattito tra universalismo e relativismo nei confronti dei concetti di colore. È sullo sfondo di questo dibattito, e dei suoi esiti più recenti, infatti, che è possibile chiederci cosa la filosofia del colore di Wittgenstein abbia ancora da dirci.