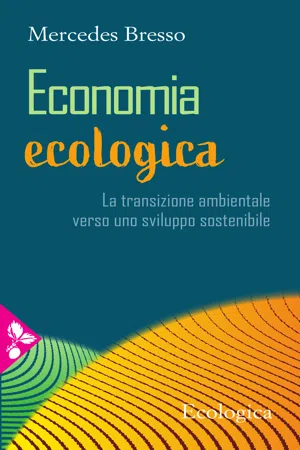
eBook - ePub
Economia ecologica
La transizione ambientale verso uno sviluppo sostenibile
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Economia ecologica è diventato un piccolo classico della riflessione sul rapporto fra economia e ambiente. Viene ora riproposto in una versione riveduta e arricchita, in un momento caratterizzato dall'impegno delle istituzioni europee e di molti giovani sulla transizione ecologica. L'autrice ha aggiunto una nuova introduzione sul percorso che l'economia ha compiuto, dagli anni '70 ad oggi, nello studio del rapporto fra le società umane e l'ambiente. Nella nuova postfazione, Bresso apre delle piste per un futuro caratterizzato da un paradigma che intrecci sapere economico e sapere ecologico.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Economia ecologica by Mercedes Bresso in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Biological Sciences & Ecology. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
LA MICROECONOMIA DELL’AMBIENTE
La derivazione disciplinare dell’economia dell’ambiente dalla scuola marginalista e dall’economia del benessere ne spiega il prevalente interesse per la microeconomia. In effetti anche se già negli anni Sessanta alcuni lavori di Kenneth Boulding ponevano la questione ambientale come un problema di limiti globali, nella maggior parte dei casi gli economisti si limitavano a suggerire limitate correzioni alle attività economiche, che permettessero di internalizzare alcuni costi esterni, non percependo la globalità e la pervasività delle questioni ambientali.
Lo sviluppo dei lavori di economia ambientale inizia, come si è detto (con l’eccezione di alcuni cenni pioneristici in Jevons, Pigou, Malthus), negli anni Sessanta come risposta all’esplosione dei primi rilevanti problemi di inquinamenti atmosferici e idrici causati dallo sviluppo industriale negli USA e in Europa e della crescente pressione sugli usi del suolo derivante dai rapidissimi processi di urbanizzazione.
I due decenni del secondo dopoguerra sono caratterizzati, nel mondo occidentale e nell’area di influenza sovietica, da una crescita continua e sostenuta del Prodotto interno lordo (PIL) globale e pro-capite e, come conseguenza, almeno all’ovest, da un’esplosione dei livelli di vita e dei consumi delle famiglie. Insieme al crescente benessere materiale, inizia a essere percepita dall’opinione pubblica l’altra faccia della crescita economica: città nere di fumo, fiumi trasformati in fogne, traffico caotico, periferie urbane senza verde e servizi collettivi, disseminazione di discariche selvagge di rifiuti industriali e domestici, mari inquinati da versamenti di petroliere, crescita dei prodotti di sintesi (come le plastiche) non biodegradabili dagli organismi decompositori che assicurano il «riciclaggio» della materia vivente organica.
È sempre più evidente che le diseconomie esterne (o esternalità negative) sono un fenomeno di ampia portata che pervade tutte le attività umane. La questione attrae l’attenzione di una piccola pattuglia di economisti, che ne propongono un’analisi teorica e mettono a punto alcuni strumenti di politica economica per intervenire sugli effetti. Nasce così, soprattutto nel mondo anglosassone, una branca specialistica dell’economia, denominata environmental economics («economia dell’ambiente»). Tra i primi economisti ambientali vanno ricordati, per i loro lavori pionieri: William Kapp, Kenneth Boulding, Robert U. Ayres, Allen V. Kneese, William Baumol, Peter Bohm, James M. Buchanan, Robert Dorfman, Wassily Leontief, Ezra J. Mishan, Robert M. Solow, Nicholas Georgescu-Roegen. In Italia i primi lavori sono degli anni Settanta (Emilio Gerelli, Gian Paolo Cesaretti, Giorgio Nebbia, Mercedes Bresso).
Il ragionamento su cui ci si basa è il seguente: l’esistenza di una diseconomia esterna postula che esista una differenza fra il costo sostenuto dal privato (per produrre o nell’acquistare e consumare un bene) e il costo sostenuto dalla società. Ad esempio, se un’attività produttiva non depura le acque e i fumi e non smaltisce i rifiuti non sostiene che una parte dei costi di produzione effettivi: l’altra parte viene rigettata sulla società che subisce un danno senza nessuna contropartita. Poiché, come abbiamo già rilevato, possono esistere anche delle esternalità positive, in termini formali potremo dire che:
costo sociale = costo privato + esternalità negative - esternalità positive
Il punto di partenza dell’economia dell’ambiente consiste nel proporre metodi e strumenti per avvicinare il più possibile il costo privato al costo sociale, facendo internalizzare al produttore tutti i costi. Questi ovviamente si incorporeranno nei prezzi e il consumatore nel fare le proprie scelte non sarà indotto a scegliere beni a basso prezzo che non incorporano tutti i costi sociali. D’altra parte, diventerà conveniente per il produttore ricercare tecnologie efficienti nella riduzione dell’inquinamento per evitare di dover sopportare costi troppo alti.
Il dibattito sugli strumenti più adatti a realizzare in modo efficiente l’internalizzazione nei costi delle esternalità è stato lungo e accanito, fra sostenitori di una soluzione normativa (regole, divieti e sanzioni, dette altresì norme «comando e controllo») e sostenitori di una soluzione tutta di mercato, basata su meccanismi di incentivi/disincentivi (tasse ambientali, diritti di emissione negoziabili, incentivi di vario tipo). Tuttavia, è sempre più evidente come una buona politica ambientale debba in effetti utilizzare un ampio ventaglio di strumenti, coinvolgendo anche i consumatori che devono essere spinti a tenere comportamenti e a fare scelte attente a ridurre i danni all’ambiente.
Vediamo brevemente i principali strumenti per realizzare l’internalizzazione dei costi esterni. È appena il caso di ricordare che le esternalità possono essere oltre che ambientali anche sociali.
Le norme «comando e controllo»
La maniera più semplice ed evidente per evitare che qualcuno inquini o danneggi l’ambiente è quella di fare delle norme che vietino e sanzionino i comportamenti devianti. Tuttavia, a una riflessione più attenta appare subito chiaro come l’eliminazione totale di un inquinamento sia spesso impossibile dal punto di vista tecnico: la depurazione di un fumo o di un refluo può raggiungere dati livelli (che dipendono dall’evoluzione delle tecnologie), il trattamento o il riciclaggio dei rifiuti sono possibili solo parzialmente. In sostanza il danno può essere rimosso solo in parte e la società dovrà stabilire fino a che livello di qualità dell’ambiente vuole arrivare, tenendo conto che il costo marginale della depurazione cresce al crescere del livello di purezza ottenuta.
Per questa ragione la regolamentazione ambientale dovrà stabilire degli standard di riferimento per le emissioni di un dato impianto o prodotto e imporre a tutti soggetti di ridurre le proprie emissioni fino al livello degli standard di riferimento: ovviamente l’ente che dà il comando avrà anche l’onere del controllo.
Vi sono diversi tipi di standard: di emissione (per fumi o acque), di prodotto (per esempio, la biodegradabilità dei detersivi), di qualità del corpo ricettore (in tal caso le emissioni in un dato luogo, per esempio una strada o un corso d’acqua, non possono superare un dato standard di riferimento).
Gli standard possono essere uniformi o differenziati per aree territoriali, ad esempio aree urbane e rurali, quartieri residenziali e aree industriali o per tipo di prodotto, di fonte emittente, ecc.
L’uniformità rende più semplice il controllo ma anche più costoso attenersi allo standard da parte dei soggetti obbligati, mentre troppe differenziazioni complicano la comprensione della norma e il costo del controllo.
Tasse e canoni ambientali
Si è già rilevato come le nocività ambientali legate alla produzione e al consumo siano un fatto non occasionale ma pervasivo, presente in quasi tutte le attività umane: è quindi facile capire perché le normative sull’ambiente sono numerose e molto complicate sul piano tecnico, dovendo dettare standard per migliaia di casi diversi. Per questa ragione gli economisti si sono, fin dall’inizio, preoccupati di cercare delle soluzioni più duttili e meno costose, per la collettività, delle regolamentazioni «comando e controllo». Tra queste un ruolo di primo piano assumono le cosiddette «tasse ambientali».
Anche in questo caso abbiamo diversi tipi di tasse: sulle emissioni, sui prodotti, canoni per servizio reso, depositi cauzionali.
Il principio delle tasse sulle emissioni, quelle su cui la teoria economica si è maggiormente soffermata, è il seguente: poiché i costi di depurazione sono molti diversi da impresa a impresa (si possono avere impianti vecchi e nuovi, tecnologie poco o molto inquinanti, ecc.), conviene spingere a depurare quelle imprese che hanno bassi costi di depurazione e far pagare una penalità a quelle che hanno alti costi.
Si fissa così una tassa per unità di inquinamento emesso (in aria o in acqua) e ogni impresa potrà scegliere se pagare la tassa moltiplicata per le unità sversate, oppure se depurare. Naturalmente sceglieranno di pagare quelle imprese che hanno costi di depurazione alti e di depurare quelle che li hanno bassi. In tal modo, se il livello della tassa sarà stato ben scelto, la depurazione voluta sarà ottenuta al minor costo possibile per l’insieme delle imprese.
È evidente che sarà comunque sempre necessario effettuare dei controlli, ma essi potranno essere concentrati sulle aziende che scelgono di depurare, mentre per quelle che pagano basterà verificare le quantità prodotte. Si ottiene così un incentivo alla ricerca e all’adozione di tecnologie pulite per ridurre l’ammontare delle tasse da pagare.
Le tasse sulle emissioni non sono state molto usate, ma dove sono state sperimentate, come in Olanda, hanno dato ottimi risultati. Spesso non viene offerta l’alternativa secca, ma viene imposto uno standard di qualità e una tassa sulle quantità scaricate. Ciò produce un incentivo a ridurre le emissioni riciclando, ad esempio, l’acqua o il rifiuto.
La più importante tassa sulle emissioni di cui si sta discutendo all’Unione Europea e all’ONU è la cosiddetta «carbon tax» sulle emissioni dei prodotti combustibili, finalizzata a contrastare l’effetto serra e il cambiamento climatico. Viene espressa in euro per tonnellata di CO2 emessa.
Le tasse sui prodotti sono quelle che hanno conosciuto il maggiore successo. Esse sono state utilizzate per incitare le imprese a produrre beni a ridotto impatto sull’ambiente, tassando i prodotti ad alto impatto, come le auto più inquinanti, i sacchetti di plastica, gli aerei rumorosi, i prodotti contenenti CFC, ecc.
Il principio generale è quello di correggere il prezzo di mercato del bene facendo assumere al produttore tutti i costi del bene stesso, comprese le esternalità ambientali. In tal modo il prezzo diventerà un indicatore anche del costo sociale di un prodotto, i consumatori saranno orientati verso i beni a basso impatto (che aumenteranno di meno) e la ricerca verrà indirizzata verso i prodotti «puliti».
Naturalmente si possono anche usare degli incentivi, dando dei contributi a coloro che acquistano beni meno inquinanti, come le auto elettriche, o che installano i pannelli fotovoltaici sui tetti di case e stabilimenti. L’effetto sarà analogo, di modifica delle convenienze relative, certo più gradito ai consumatori ma anche più costoso per la collettività.
Le tasse, o canoni, per servizio reso sono il corrispettivo di un’attività di disinquinamento (depurazione di acque luride o raccolta e trattamento rifiuti, per esempio): se sono obbligatorie assumono il carattere della tassa. Hanno un effetto incitativo solo quando sono commisurate alle quantità effettivamente conferite, mentre non lo hanno se il canone è definito su base forfettaria, come nel caso della raccolta rifiuti.
Il deposito cauzionale è una somma fatta pagare all’atto della vendita di un prodotto, che viene restituita quando il consumatore riporta l’imballaggio vuoto o il prodotto non più utilizzabile. Il tipo più noto di deposito cauzionale è quello sui vuoti delle bottiglie, ma può essere utilizzato anche per i beni durevoli (auto, elettrodomestici) per evitare che le carcasse vengano abbandonate. Ha carattere di tassa quando è obbligatorio. Un esempio è quello della tassa a rendere sulle bottiglie e lattine per bibite imposta dallo Stato di New York: i pochi cents di differenza fra deposito e somma restituita vengono utilizzati per finanziare la raccolta dei vuoti e il loro riciclaggio. Ciò ha determinato la raccolta di percentuali elevatissime di vuoti (che arrivano al 90%) e il fiorire di piccole attività collegate all...
Table of contents
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Prefazione: Un libro «sempreverde»
- Il rapporto economia/ambiente
- La microeconomia dell’ambiente
- La macroeconomia dell’ambiente
- Dall’economia dell’ambiente all’economia ecologica
- Postfazione: Verso la transizione ecologica?
- Bibliografia
- Le riviste accademiche
- I Luoghi
- Dal catalogo