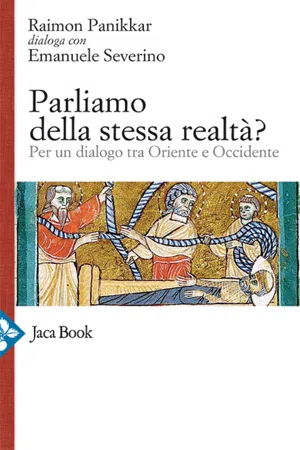![]()
INCONTRO PANIKKAR-SEVERINO
Venezia, Aula magna di Architettura
9 marzo 2004
TARCA: Siamo qui per ascoltare la parola di due autentici Maestri del pensiero contemporaneo, mi permetterei quasi di dire: Maestri dell’umanità contemporanea. È qui presente un pubblico, oltre che numeroso, qualificatissimo: vedo grandi studiosi che non nomino uno per uno ma che ringrazio per essere venuti.
Il mio compito ora è semplicemente quello di attizzare il fuoco. La prima domanda che propongo al professor Panikkar e al professor Severino è questa: entrambi proponete una visione del mondo in qualche modo complessiva e organica, ma anche caratterizzata dal fatto di essere radicalmente alternativa a quella che potremmo definire la visione del mondo oggi dominante. Tuttavia le vostre prospettive sono profondamente diverse. Vorrei quindi che incominciaste a delineare sinteticamente i tratti che caratterizzano la vostra prospettiva, in particolare evidenziando quelli che la differenziano dal modo di pensare e di vivere oggi dominante.
SEVERINO: Ho molto piacere di essere qui oggi con il professor Panikkar, che conosco da molto tempo.
Non so se lui si ricorda di quando eravamo a Roma, tanto tempo fa, e i convegni internazionali organizzati da Enrico Castelli erano un’abitudine molto bella. Ricordo come il giovane Panikkar fosse già una figura eminente di questi convegni. Poi ci siamo visti anche recentemente. Come diceva il professor Tarca, quello che ci avvicina è l’essere entrambi controcorrente, sia pure in modi diversi, rispetto a ciò che oggi è dominante. Oggi domina la civiltà della tecnica.
È molto difficile rispondere alla domanda posta dal professor Tarca, perché, se si vuole parlare di filosofia, allora esporre una “visione del mondo” limitandosi a enunciare delle tesi senza vederne il fondamento significa non fare filosofia. Ho però già introdotto una parola compromettente: “fondamento”.
Volendo comunque indicare come primo tema quale sia, nei miei scritti, il senso complessivo di ciò che viene chiamato “storia dell’Occidente”, direi che se si parte dal pensiero greco – e la storia dell’Occidente incomincia appunto con tale pensiero – allora è inevitabile arrivare alla dominazione planetaria della civiltà della tecnica. Questo “se”, questa ipotesi, non è innocente perché credo che Panikkar, nonostante tutto, parta proprio da quell’ontologia fondamentale che i Greci hanno per primi portato alla luce. E questo potrebbe essere, penso, un primo punto di discussione.
Che cosa porta alla luce il pensiero greco? Porta alla luce la fede nella forma estrema del “divenir altro”: il mondo è un “divenir altro”. E in senso estremo, cioè ontologico, perché l’“altro”, che il diveniente diviene e da cui diviene, è il non essere, cioè l’esser nulla da parte del diveniente.
Questa fede si manifesta ben prima dell’Occidente come volontà preontologica. L’uomo vuol diventare altro cibandosi delle forze supreme della realtà. Eritis sicut dii, dice il serpente: «sarete come dèi», se mangerete il frutto che vi è stato proibito. Quindi quel frutto è il divino, perché se mangiandolo ci si porta all’altezza di Dio, ossia ci si impossessa dello spazio del divino, diventando pertanto il divino (diventando quell’“altro” dall’umano che è il divino), allora quel frutto è Dio.
Il tema del cibo divino percorre tutte le religioni e arriva fino al concetto cristiano del cibo eucaristico. Anche qui si mangia il Dio per impossessarsi della potenza della sua santità. Nutrirsi di Dio non è un atto innocente, ma è l’espressione che originariamente indica la fede, essa stessa apparentemente innocente, da cui sono guidati i mortali sin dall’inizio e che culmina nella sua forma ontologica: la fede, appunto, che le cose sono un diventar altro e che la volontà divina e umana ha la capacità di farle diventare altro.
Questa fede domina, indiscussa, la storia dell’uomo, quindi l’intera storia dell’Oriente e dell’Occidente (preontologica quella, ontologica questa). Non è messa in discussione, quindi, nemmeno nel pensiero di Panikkar.
Eppure questa fede è la follia estrema. Questa, la semplice tesi. Ma si tratterebbe di scorgere perché e in che senso la si afferma (smisurata com’è). Intanto, va rilevato che l’intera tradizione dell’Occidente intende sì avvolgere e inscrivere il diventar altro in una dimensione immutabile, non trascinata via dal tempo e pertanto “divina”, ma proprio per questo intendimento in tale tradizione si riconosce che l’esistenza del diventar altro è il punto di partenza “evidente” e ineludibile del pensiero. Compiendo questo primo passo, in cui la follia estrema è posta come l’“evidenza” fondamentale, la tradizione è destinata a veder fallire ogni suo tentativo di sfuggire all’angoscia che il “diventar altro” produce. Da ultimo il “diventar altro” è la morte, e, infine, l’annientamento della morte. Ogni tentativo di sfuggire all’angoscia evocando un Dio immutabile all’interno di una verità assoluta è destinato a fallire. Che cosa produce questa destinazione?
La risposta – daccapo enunciata in forma di semplice tesi – è: la coerenza del sottosuolo essenziale della filosofia del nostro tempo, la sua radicale coerenza alla fede nel diventar altro. Tale sottosuolo ha, rispetto alla tradizione, una potenza concettuale (e pratica) distruttiva di cui, perlopiù, non si è consapevoli. Ma se si è in grado di scendere in esso attraverso alcuni, rari, crepacci (si chiamano Leopardi, Nietzsche, Gentile e pochissimi altri nomi), allora in esso appare l’impossibilità di ogni “Verità definitiva” e di ogni “Ente immutabile” (divino).
Richiamo in modo sommario il motivo di fondo di questa affermazione del sottosuolo. Se esistessero “Verità definitive”, “Enti immutabili”, Dèi, essi occuperebbero tutti gli spazi vuoti che sono indispensabili alla realizzazione del divenire1. “Che cosa mi resterebbe da creare, se gli Dèi esistessero?”, dice Zarathustra. Il divenire è infatti la produzione di qualcosa che non c’era: divenire e agire umano richiedono spazi vuoti da riempire, cioè il non essere da cui gli enti provengono e in cui vanno. Ma se esistesse un Immutabile, esso sarebbe la Legge assoluta di tutto (quindi, oltre che del presente, anche del passato e del futuro), e riempirebbe essa ogni vuoto, rendendo impossibile e una semplice apparenza quel divenire e quell’agire umano che tuttavia, sia per la tradizione che evoca gli Immutabili, sia per il sottosuolo che le distrugge, è l’evidenza originaria e assolutamente non smentibile.
Il sottosuolo del nostro tempo è la forma più coerente della follia della fede nell’esistenza del divenir altro.
Ma noi diciamo: l’evocazione greca di un sapere assolutamente incontrovertibile è impossibile se si procede, assumendola come fondamento, dalla fede nel divenire altro, anch’essa evocata, quanto alla sua forma estrema, dal pensiero greco. Ma se si mette in questione questa fede che ormai domina il Pianeta – poiché è necessario metterla in questione e negarla – allora non solo è daccapo possibile (non solo è stato già da sempre possibile), ma è necessario affermare una dimensione in cui appare con verità assoluta il senso del mondo. In questa dimensione appare qualcosa che porta al di là sia della tradizione dell’Occidente (e di ogni sapienza dell’Oriente), sia del sottosuolo e a maggior ragione della superficie della filosofia del nostro tempo (peraltro destinata a spingere il passato al tramonto).
PANIKKAR: Finalmente un discorso filosofico! Congratulazioni.
Ho tante cose da dire. La prima immagine, non so se è opportuno dirla qui, non viene dall’Oriente, viene dal centro della Spagna, dalla Castiglia. Prima però voglio dire che, per quanto ho potuto capire, sono pienamente d’accordo con il professor Severino. Sono molto lieto di questo, sinceramente, in quanto non siamo qui per fare teatro. L’immagine che veniva alla mia mente è quella di Don Chisciotte che lottava contro i mulini a vento. Si è fatta una costruzione che non nego abbia una fondazione in re, ma che certamente non è la mia, né come occidentale né come orientale. È stata fatta questa costruzione; attenzione però che questi mulini a vento sono molto reali e a Don Chisciotte sembravano giganti.
Vorrei ora domandare a Severino cosa intende per “follia”, parola che trovo molto simpatica. Non sto pensando solo a Dostoevskij, ma anche ai “folli di Cristo” e altre cose analoghe. Trovo simpatica questa parola perché ritengo che rompa questa specie di razionalismo in cui la follia è sempre intesa come qualcosa di negativo, anzi di patologico. Per me, la follia sarebbe quasi quasi un complimento.
Passo ora a un secondo argomento: come è stato detto molto bene, bisogna andare ai fondamenti. En passant, poi, è stato detto che oggi domina la tecnica. Non lo sapevo! Se comincio ad accettare le regole del gioco di quelli con cui non sono d’accordo… sono perduto. Oggi domina la tecnica nei giornali, oggi domina la tecnica nel personal computer, ecc. A me, non mi domina. Qualsiasi persona che vuol essere tale, e che lo è, supera il possibile dominio della tecnica; e questo, senza far filosofia e nemmeno dicendo che si tratta di māyā, e che dunque non è vero. No, questo fatto è molto reale, ma penso anche che la tecnica non mi domina. Certamente sono stato obbligato a prendere il treno e poi il traghetto per venire qua, ma non mi sento dominato da questo.
Se si parte dalla Grecia – così è stato detto, e questo mi pare un sillogismo molto profondo – si deve arrivare alla tecnica. Sono d’accordo. Quello su cui sarei più critico, nel senso kantiano, è che questo punto di partenza non è il mio e neanche quello dell’Oriente (accettando questa semplificazione eccessiva). Inoltre, anche dentro all’Occidente vi sono registri che permettono una scappatoia con molto garbo. Che Dio sia un assoluto né io né, per stare nella tradizione cristiana, i veri filosofi cristiani, cioè i mistici, lo hanno mai creduto. È un concetto contraddittorio. Se si parte dalla Grecia, evidentemente si arriva alla tecnica. Ma è un cammino che non è l’unico. È stato criticato – non so se in senso parmenideo o non parmenideo, ma non importa – con una critica molto azzeccata, che accetto. Divenire altro è alienazione, è una tautologia. Divenire se stesso non è una tautologia.
L’India non è mai voluta diventare “altro”; buona parte della filosofia indiana ha voluto divenire ciò che uno “è”, non “altro”. Quindi non ha voluto cambiare. Il cambiamento, la modificazione, sono altri paradigmi di pensiero. L’esempio portato era quello dell’eucarestia, nel senso più ortodosso della parola, ma non è vero che la si assume per diventare Dio. Io mangio pane perché il pane diventi “me”, non perché io diventi il pane. Prendo l’eucarestia non per diventare Dio-altro, ma perché questo Dio-altro (che non è “altro”) possa diventare “me”, essere in me. Quindi, quando mangio il pane, quando bevo il vino, io non voglio diventare né pane né vino: voglio che il pane e il vino diventino me.
Uso questa parola peculiare del “divenire”. Questo comporta che l’angoscia del divenire altro di cui si è parlato, e che caratterizza l’Occidente in modo evidente, non è la stessa cosa della non-angoscia del “divenire se stesso”. Non direi che “divenire” è identico a “divenire-altro”: «Plus ça change, plus c’est la même chose», dicono i francesi.
C’è poi un’altra cosa importante che ricordo, e mi fa rinno...