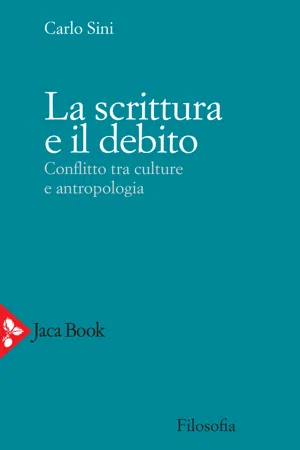![]()
II
LA SCRITTURA E IL DEBITO
La natura e la comprensione della natura sorgono insieme, come l’antichità e la conoscenza dell’antichità; infatti ci si sbaglia di grosso se si crede che esistano antichità. Soltanto ora l’antichità incomincia a sorgere. Essa si forma davanti agli occhi e all’anima dell’artista. I resti dell’evo antico sono soltanto stimoli specifici alla formazione dell’antichità. L’antichità non si fa con le mani. Lo spirito la produce mediante l’occhio – e la pietra scolpita è soltanto il corpo che per essa riceve un significato e ne diventa il fenomeno (…).
Nessuna nazione moderna ha avuto l’intelligenza artistica in un grado così elevato come gli antichi. Per loro tutto è opera d’arte – ma forse non si direbbe troppo supponendo che lo sono e possono diventarlo soltanto per noi. Alla letteratura classica avviene come all’antica: a rigore non ci è data – non esiste –, ma deve essere prodotta da noi. Con lo studio diligente e intelligente degli antichi sorge per noi una letteratura classica – che gli antichi stessi non avevano.
Novalis
«Sembra che la scrittura non registri null’altro che il debito». Così scrive Clarisse Herrenschmidt nel saggio appena riassunto. Il primo debito, dunque, è il nostro. Mi accingo a pagarlo a mia volta in termini di scrittura e nella forma di un commento che ha insieme un intento più generale: quello di mostrare il debito che i nostri saperi contraggono nei confronti della vita e della vita passata. E così paghiamo tutti insieme, Clarisse Herrenschmidt inclusa, anche il nostro debito nei confronti della filosofia: nella sua scrittura da sempre ne va della vita e del senso della vita; e quindi della morte. Ma poiché ogni scrittura è appunto in debito, anche la filosofia dovrebbe sforzarsi di pagare il suo, esibendo il carattere finito, contingente e in errore del suo gesto, ossia del suo commento, nel cui cerchio incantato stanno peraltro tutti i saperi che assegnano alla nostra cultura il volto che le è proprio e un significato peculiare. Col che il senso ultimo del commento qui tentato esibisce quanto meno la sua intenzione.
Possiamo allora cominciare.
Il racconto della Herrenschmidt si riferisce a un luogo e a un tempo del passato in ogni senso remoti. Degli Elamiti, tranne pochi specialisti, sappiamo tutti pochissimo e naturalmente è già disorientante, per noi profani, sentir parlare del IV o del III millennio prima della nostra era. Come ha osservato Moses I. Finley, di fronte alle cronologie archeologiche, espresse in migliaia e in decine di migliaia d’anni, la nostra mente si confonde e cade facilmente in abbagli. Che consistenza reale ha un fenomeno la cui evoluzione è misurata in termini di secoli? Quando mai è stato presente nella concreta esperienza degli uomini con i caratteri che noi gli attribuiamo, osservandolo (ovvero ricostruendolo immaginariamente) in base a una così spropositata lente d’ingrandimento? Sarebbe come dire che la nostra terra è una sfera perfetta, in base a una fotografia scattata a molte migliaia di chilometri di distanza. Bisogna di continuo correggere il senso delle nostre espressioni, mettendo in linea di conto il luogo dell’osservatore. Ma poi anche il modo dell’osservazione. Sicché non sembri inutile sottolineare che, ovviamente, il IV o il III millennio prima della nostra era (e la nostra era stessa) sono espressioni immaginarie, misure convenzionali, indicatori di direzione e nulla più. Lo studioso lo sa benissimo, sebbene anche lui, come ogni comune mortale, tenda a dimenticarsene.
Resta il fatto che, per quanto concerne gli Elamiti, noi ci troviamo di fronte, almeno attualmente, a una sorta di ultima Tule: nella fuga storica di quelle che Thomas Mann chiamava «le quinte del tempo», una volta pervenuti all’Elam il panorama si chiude. Non conosciamo altri popoli che abbiano abitato l’Elam prima degli Elamiti, che in questo senso appaiono a noi «autoctoni». Sappiamo però chi furono coloro che, «linguisticamente, politicamente e culturalmente», dice la Herrenschmidt, li soppiantarono, cioè gli Iranici. Fatto che si profila, ai nostri occhi, con tinte tragiche e che suscita meditazioni malinconiche sul destino delle umanità che ci hanno preceduto e quindi anche sul destino della nostra. Verrà un giorno, pensiamo, come in una sorta di somnium Scipionis, in cui si dirà: «Quando gli Italiani abitavano la penisola che si protende nel mare chiamato un tempo Mediterraneo, in una lingua ormai scomparsa da molti secoli…».
Ma la cosa diventa meno drammatica, se si tiene presente che l’evento del «soppiantare» prese più di mille anni, il che traduce l’«avvenimento» in una sterminata serie di eventi assai meno traumatici, anche se non necessariamente pacifici. E lo stesso è da dirsi della profezia relativa alla nostra futura scomparsa: è difficile credere che, a distanza di millenni, ci saranno ancora archeologi e una scienza archeologica, la quale parli sempre con le nostre categorie e cronologie e senso «storico» della verità. Questo infatti è il punto che facilmente sfugge. Non è solo che l’archeologia opera (come ogni scienza, del resto) con grandi generalizzazioni e astrazioni, sicché ciò che dice va preso con competenza e con buon senso e riportato poi alla concretezza minuta dell’esperire quotidiano (così la fisica parla a suo modo della «luce», ma poi è di questa luce in cui ora mi muovo che in ultimo si tratta); oltre a ciò bisogna aggiungere che l’archeologia medesima è un’astrazione; voglio dire: il suo punto di vista e le sue procedure metodologiche, il suo «fare» specifico e il pensiero che lo muove e che insieme ne deriva. Ciò che invece implicitamente si intende è che l’archeologia (come ogni scienza) parli della «realtà»: quella cosa che gli Elamiti ignoravano, ma che noi con verità, e sia pure molto in generale e con molti dubbi e problemi irrisolti, sappiamo di loro. Sicché ci viene spontaneo almanaccare ciò che l’archeologia potrebbe dire di noi a distanza di millenni; che poi sarebbe come se un Elamita si fosse chiesto come onoreranno i suoi dei le umanità future (ma, non possedendo senso storico né cronologie archeologiche, è improbabile che se lo sia chiesto). In tal modo, direi, noi manchiamo proprio di cogliere l’insegnamento profondo che può venirci dall’archeologia, il suo nascosto senso «filosofico»: che le umanità, in un modo o in un altro, si «soppiantano», linguisticamente, politicamente e culturalmente, sicché vengono meno i loro saperi, le loro realtà e le loro verità. Allora davvero la profondità del tempo ci spaura, non per la psicologica difficoltà di misurarlo conformemente all’esperienza abituale dei nostri giorni e anni, ma per l’impossibilità di farlo coincidere con la nostra esperienza della verità e con il senso stesso che la parola verità ha assunto, nel tempo, per noi.
«La storia della scrittura nell’Iran elamita può fornire un eccellente terreno storico per una riflessione generale sulla scrittura, e sui suoi rapporti con la storia e la cultura da un lato, con la lingua e il linguaggio dall’altro». Perché il terreno sia eccellente non è necessario ripeterlo qui. Importa invece avvertire che noi ci occuperemo esclusivamente della «riflessione generale» cui l’Autrice fa riferimento. La Herrenschmidt dice inoltre che, «per tentare di comprendere le operazioni mentali realizzate dagli uomini più di cinquemila anni fa (nell’elaborare segni di scrittura), non abbiamo bisogno di una ricostruzione proveniente dalla nostra intuizione, ma di una descrizione, anche imperfetta, di quel che ha avuto luogo nella storia». Precisazione da un lato ovvia (la scienza ha bisogno di documenti, rigorosamente accertati, e non di spiegazioni basate sulla «entropatia» e su sin troppo facili nessi analogici); da un altro lato altamente problematica. Infatti, che cosa sono mai il «terreno storico», la «cultura», la «lingua», il «linguaggio», se non appunto nostre intuizioni, prodotti caratteristici della nostra cultura e della nostra storia, della nostra lingua e delle nostre operazioni mentali? Oppure questi termini avrebbero la magica capacità di evocare direttamente cose reali in sé stesse? Che cosa ci autorizza a usarli come unità di misura dell’umano, proiettandoli indietro di migliaia di anni? In che modo la nostra implicita credenza nel loro contenuto semantico sarebbe meno «superstiziosa» delle credenze elamite relative ai loro miti e ai loro dei?
Prendiamo ad esempio le «operazioni mentali». La Herrenschmidt ragiona, sembra, in questo modo: i segni di scrittura sono prodotti dalle operazioni mentali. L’esistenza di queste ultime è fuori discussione. Tutti gli uomini, da quando sono uomini, compiono da sempre operazioni mentali. Anche i bambini, i selvaggi, le donne e gli schiavi; Aristotele, come si sa, non sarebbe del tutto d’accordo, ma anche il suo disaccordo è un’operazione mentale. Piuttosto bisogna dire che le operazioni mentali sono diverse nel tempo. Come ragiona un filosofo del IV secolo o un Elamita del IV millennio non è facile ricostruirlo, perché il modo di operare delle operazioni mentali dipende da moltissimi fattori. È solo ricostruendo «ciò che ha avuto luogo nella storia», in base a fatti e documenti oggettivi, che noi possiamo sperare di comprendere le operazioni mentali di uomini ignari di ciò che ha luogo nella nostra storia, eminentemente logica, egualitaria, democratica e scientifica. Un Elamita che «scrive» non fa le stesse cose che faccio io col mio computer. Però fa anche lui operazioni mentali e anche per lui, benché ignaro, qualcosa di «storico» ha luogo e accade. Se poi si vuole apprendere una definizione più «tecnica» e più precisa circa le operazioni mentali, si è pregati di rivolgersi allo psicologo, al neurologo o al cognitivista.
Bene. Ma ora prendiamo in considerazione la cosa da un altro punto di vista e in base ad altri incontestabili fatti. Per esempio che proprio la pratica della scrittura ha progressivamente educato la mente umana, ha innescato e accompagnato l’articolazione del linguaggio e poi la sua riproduzione come un fatto oggettivo osservabile e analizzabile distintamente in sé. Infine, che solo uomini educati dalla scrittura alfabetica hanno imparato a ragionare per concetti, sicché solo per loro è stato possibile farsi un’idea di cose separate in sé come appunto «la realtà», «l’uomo», «la mente» e simili. E da ultimo che solo a partire da un’umanità dedita alla scrittura e alla lettura alfabetiche si è resa possibile la scienza occidentale, vale a dire una considerazione «oggettiva» e «universale» delle cose (anche la Herrenschmidt, più avanti e a proposito della scrittura greca, accennerà a qualcosa del genere, senza peraltro riflettere sulle conseguenze generali di una siffatta ammissione). Ora, se c’è una relazione interna, costitutiva e speculare tra scrittura e mente (e naturalmente tra innumerevoli altre cose), non ha senso alcuno presupporre la mente, le «operazioni mentali», alla scrittura. La «mente» degli Elamiti è qualcosa di circoscritto, anzitutto o in modo peculiare, dalla loro scrittura, quindi in nessun caso qualcosa di identico alla nostra. Le nostre operazioni mentali sono in larga misura «oggetti» del nostro sapere, oggetti resi possibili, cioè visibili e pensabili, dalla nostra scrittura; sicché, retrocedendole sugli Elamiti, non stiamo facendo altro se non mostrare qual è il nostro modo di intendere la realtà, presente e passata (il nostro modo di «intuirla»). Se la verità è, tra l’altro, una funzione interna alla scrittura, l’esercizio della nostra verità sulle altrui scritture è da un lato un arbitrio, dall’altro una mera tautologia. Infatti, dire che la nostra scrittura, in particolare quella scientifica, è la scrittura della verità, scrittura che vale oggettivamente da sempre e per sempre per tutti, non ha altro significato se non quello di enunciare, appunto, il carattere funzionale e strutturale del nostro modo di intendere e di scrivere l’esperienza. Qualcosa di tautologicamente vero in sé e, di conseguenza, per noi. Nella scrittura degli Elamiti, invece, non possono stare né storia, né operazioni mentali, né verità universali e oggettive in sé, né, infine, la realtà così come noi la concepiamo scrivendola. Infatti non vi stanno. Perché però e in che senso la nostra scrittura godrebbe di un privilegio assoluto sulla loro non è stato ancora né detto, né pensato, e neppure affrontato come problema. Né si è riflettuto sul fatto che la nostra scrittura ci mostra e ci insegna a vedere, in modo incontestabile, che anche la nostra scrittura muterà nel tempo, sicché sa il cielo cosa diremo in futuro al posto delle attuali «operazioni mentali». Diremo altro, e in base a questo altro anche la verità degli Elamiti «per noi» sarà mutata. Non è tanto o soltanto che scopriremo nuovi «documenti»; piuttosto, muteremo lo sguardo e ciò che osserveremo muterà «significato» (sempre in base alla nostra «intuizione»).
Si aggiunga che, naturalmente, sappiamo bene che la nostra scrittura non è venuta dal cielo. Essa, come ogni altra, è sorta in contesti di pratiche di vita, di espressione e di sapere volta a volta determinati da quelle che noi chiamiamo funzioni materiali, storiche e sociali. Quindi la nostra scrittura è un fatto contingente; se il suo influsso sul nostro modo di intendere la verità è innegabile, allora anche questa verità (e la verità stessa di quel che stiamo dicendo) è contingente. E poi si aggiunga che la nostra scrittura è a sua volta una conseguenza «storica» delle scritture che l’hanno preceduta, senza le quali essa sarebbe inimmaginabile. Queste sono appunto «verità» che la nostra scrittura ci insegna a pensare, sono parte della sua indiscussa potenza ed efficacia, il tratto caratteristico della sua verità. Proprio per ciò non possiamo fare a meno di applicarne le conseguenze anche a noi e ai nostri discorsi «scientifici» sulla realtà, sulla storia e sulla mente.
Andiamo avanti. Dobbiamo molta gratitudine alla Herrenschmidt per la ricostruzione limpida, minuziosa e intelligente che essa ci offre relativamente alla genesi della tavoletta di scrittura. Non sappiamo se dappertutto le cose siano andate esattamente come presso gli Elamiti; tuttavia, possiamo ragionevolmente pensare che i tratti generali del processo, il suo significato complessivo, siano stati colti in modo soddisfacente. Ed è appunto questo che qui conta, essendo noi interessati, come abbiamo detto, a una riflessione generale sulla scrittura.
Dunque: dalle bolle, con dentro i calculi (strumenti per contare già ritrovati nel VII millennio a.C.) e all’esterno un sigillo, si passa alle tavolette a forma di cuscinetto, che sono poi le antiche bolle divenute compatte. Documenti contabili cui si accompagnano nello stesso periodo (non sappiamo per quale differente funzione) dei gettoni di terracotta in forma di testa di bue, di brocche, di triangoli, ecc., privi dell’impronta del sigillo, conservato invece dalle tavolette assieme a segni chiaramente preannuncianti, dice la Herrenschmidt, i pittogrammi.
Essa sottolinea poi che, da un punto di vista formale, l’invenzione della scrittura risale alle bolle con sigillo alla superficie (raffigurante talora anche scene di lavoro o scene religiose) e calculi dentro. Abbiamo qui un bell’esempio di quello che si potrebbe definire il «processo di astrazione». Il bastoncino di argilla (il calculus) per raffigurare un’unità è ovviamente già un segno. Poi il bastoncino va nella bolla e fuori compare una tacca a rappresentarlo. La tacca è così segno di un segno. Poi il bastoncino scompare e resta solo la tacca sulla tavoletta: la corrispondenza all’unità è ora solo «mentale», cioè legata al segno grafico. Il medesimo processo (va però aggiunto) è accaduto anche nel passaggio bastoncino-bolla-tavoletta: la tavoletta è ora un semplice supporto di scrittura, del tutto smaterializzato rispetto alla bolla e al bastoncino. Cioè, è un vero e proprio supporto di scrittura (sebbene anche il sigillo sulla bolla lo sia, così come le scene di lavoro, ecc.: allora quella parte della superficie della bolla si stacca idealmente dalla bolla e non significa più «bolla», ma significa appunto supporto di raffigurazione).
Naturalmente queste operazioni, considerate in generale, non accadono lì per la prima volta. È evidente che gli Elamiti, da tempo immemorabile, «raffigurano» sulle pietre, le rocce, le brocche d’argilla, gli strumenti del lavoro, della caccia, della guerra, ereditando pratiche di raffigurazione che risalgono addirittura al paleolitico. E lo stesso deve dirsi per gli oggetti destinati al calcolo: bastoncini, biglie, dischi, coni (un po’ come le fiches al casinò). Anche qui l’origine è antichissima, risalendo, tanto per fare un esempio, alle prime tacche o altri segni materiali dei calendari preistorici nell’America precolombiana.
La numerazione sembra essere una delle più antiche origini della scrittura: necessità di calcolare il tempo e di misurare gli oggetti. Riferiamoci brevemente allo straordinario libro di Karl Menninger (Zahlwort und Ziffer. Eine Kulturgeschichte der Zahl, pp. 17-24 passim). Scrive Menninger: «Può essere contato tutto ciò che è distinto, concreto o astratto che sia, della stessa natura o di natura diversa». Già, ma come qualcosa è distinto e perciò contato? Ciò può accadere solo attraverso la mediazione di un segno, e in particolare di un segno di scrittura, inteso in senso lato. Posso usare le dita (una sorta di scrittura del corpo, per indicare, per contare, ecc.) e posso imprimere la traccia delle dita su una superficie idonea. Poi la traccia diviene segnale di direzione o segno dell’unità. Ma non c’è «prima» l’idea mentale di voler contare e «poi» l’uso di strumenti «empirici» come le dita o le tracce. È l’operazione concreta che, «iscrivendosi» visibilmente, rimbalza indietro, fa da specchio, e riflette così un’immagine mentale nel suo operatore e fruitore. Ciò che dobbiamo vedere all’opera è una successione di «stacchi»: il dito si stacca dalle sue funzioni connesse alla manipolazione e dalla mano; la traccia si stacca dal gesto che l’ha tracciata e dall’oggetto che la ritiene e si mostra separata conservandosi nel tempo (a differenza dal gesto delle dita), e così via. È il cammino di questi «stacchi», connessi a concrete pratiche di vita e di espressione, ciò che genera l’astrazione (e non una supposta o presupposta mente che farebbe, chissà come, astrazione). La mente «astratta» (o sempre più astratta) è un prodotto e un effetto del carattere di «stacco» connesso alle pratiche, in particolare alle pratiche di scrittura in ogni senso intese; un effetto di rimbalzo o di riflesso. È la pratica dello «scrivere» che fa astrazione, per la sua stessa natura operativa, e non una mente «astraente» presupposta; questa è invece il risultato di quella.
Prendiamo l’esempio di Menninger della «serie numerale vuota» (con i segni verbali che la significano o l’immagine di una serie infinita di caselline vuote da riempire): noi abbiamo la tendenza a pensare che essa «esista», indipendentemente dal fatto di conoscerla, cioè di nominarla o di riempirla o meno. «Finché non si conta», dice Menninger, «essa sta lì, distaccata da tutte le cose, vuota ma a disposizione». In realtà non sta affatto lì (se ancora non si conta) né da nessun’altra parte. È la pratica del contare, e del contare in un certo modo, che la fa emergere, come possibilità strutturale inerente a quella pratica. Il fatto che ora noi, che contiamo, ne prendiamo coscienza come di una possibilità «reale» non ci autorizza a retrocederla come «reale anche prima che si sia contato». Infatti, le cose stanno proprio così e gli esempi suggestivi di cui è pieno il libro di Menninger ce ne danno conferma. «Il distacco della serie numerale dalle cose», come si esprime Menninger, non avviene infatti in un colpo solo e soprattutto non si muove su una linea omogenea di successioni operative di carattere astraente. Questo è un punto essenziale sul quale è necessaria la più solerte attenzione e riflessione.
È, dice Menninger, «l’ambiente che fa scattare il pensiero e l’azione». Io non credo che sia l’«ambiente» e neppure la «struttura economica» del modo di vita, come anche egli dice, perché queste espressioni valgono solo per noi e sono equivalenti alle «operazioni mentali», alla «cultura» e alla «storia» di cui parla la Herrenschmidt. Però gli esempi di Menninger sono efficaci e parlano da soli. Una tribù pigmea che vive nella giungla senza contatti con il fuori non ha motivi né occasioni per contare oltre il due; tutto ciò che supera il due è, per essa, semplicemente «molto». Ma una tribù di coltivatori di bestiame è costretta a contare sino a cento e anche oltre; in questo caso il «molto» si sposta considerevolmente e soprattutto mutano i sistemi segnici connessi al contare, la loro configurazione e il loro senso. Col che non si ha però bisogno della serie numerale vuota. Gli oggetti, cioè le loro identità e i segni che le significano, non emergono entro una immaginaria storia della matematica, del linguaggio o della scrittura; e...