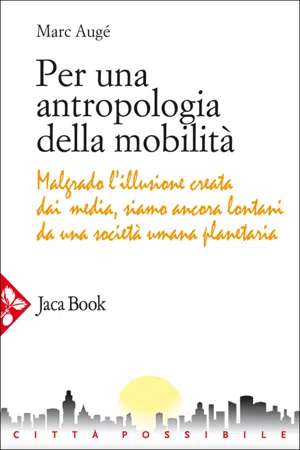![]()
1
IL CONCETTO DI FRONTIERA
Se il concetto di frontiera è «buono da pensare» è perché è al centro dell’attività simbolica che sin dalla comparsa del linguaggio – riprendendo Lévi-Strauss – è stata impiegata per conferire un significato all’universo, per dare un senso al mondo e renderlo vivibile. Ebbene, questa attività è essenzialmente consistita nell’opporre categorie come maschile e femminile, caldo e freddo, terra e cielo, secco e umido, per simbolizzare lo spazio suddividendolo.
Oggi stiamo incontestabilmente vivendo un periodo storico in cui la necessità di suddividere lo spazio, il mondo o il vivente per comprenderli sembra meno evidente. Il pensiero scientifico non si basa più su opposizioni binarie, ma si sforza di rivelare la continuità dietro le apparenti discontinuità, per esempio cercando di comprendere e forse ricreare il passaggio dalla materia alla vita. L’uguaglianza tra i sessi è un’esigenza del pensiero democratico, ma, al di là di questa uguaglianza, è un’identità di funzioni, di ruoli e di definizioni a essere postulata nel momento in cui si mette l’accento sulla preminenza del concetto stesso di essere umano. Infine, la storia politica del pianeta sembra mettere in discussione le frontiere tradizionali nel momento in cui il mercato libero mondiale prende forma e le tecnologie della comunicazione sembrano di giorno in giorno cancellare gli ostacoli legati allo spazio e al tempo.
Tuttavia, sappiamo bene che le apparenze della mondializzazione e della globalizzazione nascondono anche delle ineguaglianze: assistiamo infatti, a scale diverse, alla rinascita di frontiere la cui esistenza costituisce una smentita della tesi della fine della storia. L’opposizione Nord/Sud si è ormai sostituita a quella tra paesi colonizzatori e paesi colonizzati. Nelle grandi metropoli del mondo, i quartieri ricchi si contrappongono ai quartieri «difficili», dove tutta la disparità, tutte le ineguaglianze del mondo si coagulano. In vari continenti esistono addirittura quartieri privati e città private. Le migrazioni dai paesi poveri verso quelli ricchi assumono spesso forme tragiche e sono i paesi liberali a erigere muri per proteggersi dagli immigrati clandestini. Da un lato, si disegnano nuove frontiere, o meglio si innalzano nuove barriere, sia tra paesi poveri e paesi ricchi, sia all’interno degli stessi paesi sottosviluppati o emergenti, tra i settori ricchi connessi alla rete della globalizzazione tecnologica ed economica e gli altri. Dall’altro lato, quanti sognano un’unica società umana e considerano quale patria il pianeta non possono ignorare né la forza dei ripiegamenti comunitari, nazionali, etnici o di altro genere, che si ripropongono di restaurare i confini, né l’espansionismo dei proselitismi religiosi, che aspirano a conquistare il pianeta annullandone tutte le frontiere.
Nel mondo «surmoderno», sottoposto alla triplice accelerazione delle conoscenze, delle tecnologie e del mercato, il divario tra la rappresentazione di una globalità senza frontiere che permetterebbe a beni, esseri umani, immagini e messaggi di circolare senza limitazioni, e la realtà di una pianeta diviso, frammentato, in cui le divisioni negate dall’ideologia del sistema si ritrovano al cuore stesso del sistema, si fa sempre maggiore. Si potrebbe contrapporre l’immagine della città-mondo, quella «metacittà virtuale», secondo l’espressione coniata da Paul Virilio, costituita dalle vie di circolazione e dai mezzi di comunicazione che abbracciano il pianeta intero nella loro rete e diffondono l’immagine di un mondo sempre più omogeneo, alle dure realtà della città-mondo in cui si ritrovano e anche si scontrano differenze e ineguaglianze.
L’urbanizzazione del mondo consiste al tempo stesso nell’estensione del tessuto urbano lungo le coste e i fiumi e nell’infinita crescita delle megalopoli, ancora più rilevante e cospicua nel terzo mondo. È questo fenomeno la verità sociologica e geografica di quella che chiamiamo mondializzazione o globalizzazione, ed è una verità infinitamente più complessa dell’immagine della globalità senza frontiere che funge da alibi per gli uni e da illusione per gli altri.
Oggi dobbiamo quindi ripensare la frontiera, questa realtà continuamente negata e continuamente riaffermata. Il fatto è che essa si riafferma spesso sotto forme indurite che fungono da divieto e comportano esclusioni. Occorre ripensare il concetto di frontiera per cercare di comprendere le contraddizioni che colpiscono la storia contemporanea.
Molte culture hanno simbolizzato il limite e il crocevia, luoghi particolari in cui si gioca una parte dell’avventura umana quando uno parte all’incontro dell’altro. Esistono frontiere naturali (montagne, fiumi, stretti), frontiere linguistiche, frontiere culturali o politiche. La frontiera segnala anzitutto la necessità di apprendere per comprendere. Naturalmente l’espansionismo ha trascinato alcuni gruppi a violare i confini per imporre ad altri la propria legge, ma è capitato che, anche in questo caso, il superamento della frontiera non sia stato privo di conseguenze per coloro che lo hanno compiuto. La Grecia vinta ha civilizzato Roma e contribuito al suo fulgore intellettuale. In Africa, i conquistatori adottavano tradizionalmente le divinità dei popoli sui quali avevano trionfato.
Le frontiere non si cancellano, si ritracciano. È ciò che ci insegna il meccanismo della conoscenza scientifica, che progressivamente sposta le frontiere dell’ignoto. Un sapere scientifico non è mai concepito come assoluto; è ciò che lo distingue dalle cosmologie e dalle ideologie: all’orizzonte ha sempre nuove frontiere. La frontiera, in questo senso, ha sempre una dimensione temporale: è la forma dell’avvenire e, forse, della speranza. Non dovrebbero dimenticarlo gli ideologi del mondo contemporaneo che, di volta in volta, soffrono di eccessivo ottimismo o di eccessivo pessimismo, in ogni caso di troppa arroganza. Non viviamo in un mondo compiuto, del quale non avremmo che da celebrare la perfezione. Non viviamo nemmeno in un mondo inesorabilmente abbandonato alla legge dei più forti o dei più folli. Viviamo innanzitutto in un mondo in cui la frontiera tra democrazia e totalitarismo esiste ancora. Ma l’idea stessa di democrazia è sempre incompiuta, sempre da conquistare. Come quella della politica scientifica, la grandezza della politica democratica risiede nel rifiuto delle totalità perfette e nel fatto di porsi delle frontiere per esplorarle e superarle.
Nel concetto di globalizzazione, e in coloro che si richiamano ad esso, c’è un’idea di compiutezza del mondo e di arresto del tempo che denota un’assenza d’immaginazione e un invischiamento nel presente profondamente contrari allo spirito scientifico e alla morale politica.
![]()
2
L’URBANIZZAZIONE DEL MONDO
L’urbanizzazione del mondo è un fenomeno che un demografo ha paragonato al passaggio all’agricoltura, cioè al passaggio dal nomadismo cacciatore alla sedentarietà. Il paradosso, tuttavia, sta nel fatto che questo fenomeno non corrisponde a una nuova sedentarizzazione, ma piuttosto a nuove forme di mobilità. Esso presenta due aspetti distinti e complementari:
a) la crescita dei grandi centri urbani;
b) la comparsa di «filamenti urbani», per riprendere l’espressione del demografo Hervé Le Bras, filamenti che saldano una all’altra le città esistenti lungo le vie di circolazione, i fiumi o le coste marittime.
Questo fenomeno è la traduzione spaziale di ciò che viene chiamato mondializzazione. Con il termine «mondializzazione» si intendono contemporaneamente la globalizzazione, caratterizzata dalla diffusione del libero mercato e dallo sviluppo dei mezzi di circolazione e di comunicazione, e la planetarizzazione o coscienza planetaria, che è una coscienza ecologica e sociale. Siamo sempre più consci di abitare un pianeta fisicamente minacciato, e siamo ...