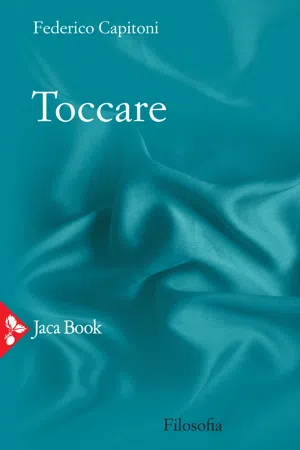1
PICCOLA STORIA FILOSOFICA DEL TATTO. A TENTONI
Nella Flatlandia, la terra fantastica immaginata da Edwin Abbott Abbott alla fine del 1800, ove tutto è piatto e non esiste la terza dimensione, le figure geometriche che la abitano devono toccarsi per riconoscersi. Apparendo ognuna, alla vista, come una linea retta, l’operazione del «tastare» si rivela il mezzo più efficace per capire se si è intercettato un triangolo, un quadrato o un poligono dai lati più numerosi. Anche l’udito gioca un suo ruolo: permette di riconoscere le caste poligonali (il genere) con minore precisione, ma funziona bene come principio di individuazione per indovinare le singole “persone”, cioè le figure particolari (ognuno ha la sua propria voce). Ma nella Flatlandia, sebbene molto affidabile nell’accertare la forma, il tatto non è infallibile, soprattutto nell’identificare con esattezza i poligoni con molti lati – considerando che li deduce a partire da un angolo, essendo sconveniente tastare la figura per tutto il suo perimetro (cioè contando) – e nel rilevare le dimensioni. È qui che arriva in soccorso la vista, che lavorando a distanza consente di far ricorso alla misura e mettere in relazione le lunghezze mostrandosi più precisa nel rispondere delle grandezze. E tuttavia, anche quanto captato con la vista andrebbe poi verificato tattilmente. Quello della vista però, in un mondo a due sole dimensioni, è un senso che va allenato, essendo meno immediato dell’approccio tattile, e appartiene quindi a una classe di abilità superiori che non tutti possono esercitare. Tant’è che nelle caste più elevate viene assunto a unico degno mezzo di riconoscimento («mirabile esercizio per l’intelletto»), poiché alle persone maggiormente altolocate «non sta bene chiedere di lasciarsi tastare» per capire chi sono.
Una tale classificazione dei sensi, con le loro caratteristiche e i relativi vantaggi, ha caratterizzato la storia della filosofia almeno fino all’epoca del positivismo. I tre sensi ritenuti attori principali nella partita della conoscenza (tatto, udito e vista) sono sempre stati oggetto di una valutazione teoretica dai filosofi, così da trovarsi quasi in gara tra loro.
Ora, è evidente tanto per l’uomo moderno quanto per quello antico che il tatto sia il senso dei sensi. Il Senso. E non solo perché passa attraverso la pelle, che ricopre la totalità del corpo umano (il tatto è «quel senso che è diffuso in tutto il corpo», dice Agostino nelle Confessioni), e particolarmente tramite la mano, che è il nostro arto più sensibile ed efficace; non solo perché anche gli altri sensi sono – a pensarci bene – forme più evolute (o più particolareggiate) di tatto. Ma per il semplice fatto che senza tatto non potremmo stare al mondo; non sentiremmo cioè la terra sotto i piedi, né l’aria sul nostro corpo, non ci percepiremmo come esseri viventi… Il tatto è il senso della nostra esistenza. Il senso della vita (anche perché quello che trionfa nel sesso, e nel quale il sesso trionfa).
Tuttavia non per tutti i pensatori questa caratteristica essenziale è bastata per eleggere il tatto a re dei sensi, considerato anche il fatto che, essendo il dispositivo sensorio inteso come più corporale e primitivo, avesse poco a che fare con la conoscenza: l’idea metafisica della fallibilità delle sensazioni nel raggiungimento della verità (concezione ribaltata da sensisti ed empiristi) correrà spesso parallelamente a un pensiero che guarda al corpo con sospetto quando non mostrando per esso paura e disprezzo. Nell’iconografia cristiana il patimento del corpo è evidente (piaghe, uomini trafitti, petti aperti a scoprire il cuore vivo): diventa incarnazione di punizione e sacrificio.
Il corpo è sempre stato scomodo affaire per mistici e filosofi, per i religiosi come per gli intellettuali: la cura dello spirito e della mente mal si conciliava con l’attenzione all’aspetto e al piacere fisici. Adorno e Horkheimer condanneranno la dedizione al corpo come indizio di indebolimento dell’intelletto (le conseguenze culturali di questa posizione sono ancora evidenti oggi nella figura dell’intellettuale che svaluta – e invece sottovaluta – l’aspetto, la cura e l’allenamento fisici). Ben più spirituale era la «vergogna del corpo» di Plotino, il quale vedeva nelle membra una trappola per l’anima, aggravata da una spoglia pesante che ne impediva l’innalzamento. Nel considerare però il corpo come un elemento illusorio di separazione dal cosmo e che dota quindi l’individuo della percezione concreta di una singolarità che lo divide dagli altri rendendolo egoisticamente autosufficiente, Plotino inaspettatamente custodisce la speranza che l’uomo impari a “toccare” il resto del mondo, cioè a eccedere il proprio corpo, a “sconfinarlo”, seppur con mezzi spirituali: ricordarsi di essere un’unica anima è il corrispettivo trascendentale di un pensiero che riconosce il mondo e gli esseri umani come un corpo solo.
Il corpo umano è il corpo dell’intera umanità.
È all’interno di un pensiero etico-politico che il piacere corporale è stato riabilitato da alcuni – pochi – pensatori (Spinoza e Foucault, per esempio). Scarsi i filosofi che si sono, propriamente, sporcati le mani.
Prima ancora dei rapporti con l’altro, avere – anche da soli – una buona coscienza del proprio corpo ha una valenza estetica e politica: la frustrazione data dall’incapacità o dall’impossibilità di provare piacere influisce sui comportamenti. Questo è un indirizzo somaestetico sdoganato solo di recente, nel ’900, anche grazie all’intervento della psicologia moderna nella speculazione filosofica (teorie delle emozioni, filosofie dell’amore ecc.) e in una discesa degli intellettuali nel concreto mondo dell’attualità attraverso un’osservazione sociale e antropologica che spesso l’elucubrazione solipsistica aveva volentieri lasciato da parte. Invece siamo corpi, di sicuro agenti; per alcuni, pensanti: il corpo è saggio e ne sa più di noi, sosteneva Nietzsche anticipando il ribaltamento di una dominante teoria somatica dualista che voleva la mente sovrintendere le funzioni corporali.
Già, la mente, che nell’immaginario comune prende corpo attraverso il cervello, i cui organi di senso più prossimi sono stati considerati per lungo tempo gli occhi (e che dire allora della cute del capo?), quasi come proiettori dei contenuti mentali e – al contempo – portali di introiezione delle informazioni: «Lo so perché l’ho visto», si usa dire. L’associazione tra sapere e visione (nell’immaginario comune la cultura usa gli occhi della lettura per accrescersi) è storicamente dominante, ma l’ambito in cui si edificano le classifiche è originariamente etico. Le “graduatorie” dei sensi hanno origini antiche, e sovente il tatto, assieme al gusto e all’olfatto, è stato inteso connesso al lato meno nobile della corporeità, quello degli istinti carnali, quindi posto più in basso di vista e udito, i quali pure sono strumenti di godimento ma più puri, minormente compromessi. Tra i sensi meno “morali”, il tatto era associato all’elemento terra, necessario quanto “basso” e pesante, nella cosmografia ideale della simbologia. Dunque, inizialmente la classificazione non ha a che vedere tanto con la conoscenza (tutti i sensi sono mezzi per conoscere, ancorché in maniera elementare, secondo Platone per esempio) ma con uno dei più prosaici aspetti della moralità: il contatto diretto con la pelle e le mucose. Tommaso d’Aquino, nella Summa Theologiae, riprende pressappoco questa prospettiva dicendo che vista e udito sono i sensi atti alla conoscenza, il tatto della sopravvivenza.
Per Platone (lo dice nel Timeo) il tatto non figura tra le funzioni sensoriali del corpo (vista, udito, gusto e olfatto) perché in realtà le comprende interamente, esprimendosi i sensi tutti attraverso il tocco: gli stimoli toccano gli organi di senso (occhi, orecchie, bocca e naso) che dunque “sentono”. Una concezione plurale del tatto è sostenuta da molti nell’antichità ed espressa dalla gran parte dei filosofi naturalisti. Lucrezio, nel De rerum natura, non esita a dichiarare che il tatto è «il senso principale del corpo», e non solo al suo esterno, ma anche al suo interno: infatti, i moti dei nostri organi interiori li percepiamo attraverso una facoltà tattile. E un po’ tutti i sensi sono forme di tatto, dal momento che ascoltiamo e vediamo perché gli atomi colpiscono le nostre orecchie e i nostri occhi. Plinio il Vecchio (Naturalis Historiae) è tra i pochi a ritenere come insuperabilmente umani gusto e tatto, dato che di contro ci sono animali con vista, olfatto e udito ben più acuti dei nostri.
Pure per Aristotele il tatto, in quanto risorsa sensibile per il nutrimento, è il senso di base necessario («tutti gli animali lo possiedono», scrive nel De anima) che può esistere da solo, mentre gli altri sensi lo sottintendono. Peraltro, nella puntuale disamina dei sensi, nota da subito un aspetto tipico della speculazione fenomenologica: il corpo che tocca è anch’esso toccato (mentre per esempio un oggetto inanimato che vediamo non vede noi, né uno sguardo che non incrocia chi guarda sa di essere visto; tant’è che per parlare di contatto visivo occorre che gli sguardi si incontrino). Però proprio da qui, e dai pensatori più teoretici, parte l’idea di una preminenza nobiliare – non meramente funzionale – di alcuni sensi su altri, eleggendo in particolare quello della vista quale senso filosofico per eccellenza perché il più destinato alla conoscenza: «tutti gli uomini per natura desiderano vedere, perché la vista, tra i sensi, è quella che ci fa conoscere di più», dice Aristotele nella Metafisica (intendendo però la vista come senso raffinato e avanzato, mentre quello primario, discriminante – s’accorge bene il filosofo –, resta il tatto); Agostino gli fa eco quando dice che usiamo il termine “vedere” anche se indirizzato all’acquisizione di nozioni per mezzo di altri sensi («vedi com’è profumato, vedi com’è duro…»). La parola “idea” proviene dal greco idein (vedere). Ma normalmente, quando ci si fa un’idea, essa è vaga. Perché sia solida, bisogna toccare con mano. Si deve ap-prendere, però, non sfiorare (si accarezza un’idea). È quando si passa dall’astratto all’empirico che si fa strada il concetto. E il concetto effettivamente si afferra (in tedesco Begriff, da -greifen, afferrare): secondo una metafora metafisica di qualcosa di molto fisico, rimane nel parlare comune il modo di dire “afferrare il concetto”. Penetrare a fondo, toccare l’essenza, è giustappunto accarnare, entrare nel corpo del concetto, stringere, sentire tutto. L’azione del vedere è quindi intuitiva e lavora a distanza; quella del toccare è volta a verificare. Posso intuire dimensioni, forme e materiali con la vista, ma le ratificherò misurando – appunto in pollici, mani, spanne, piedi – a contatto. La tastazione è una constatazione. Pure dell’idea innata, con la quale l’esperienza dovrebbe combaciare, aderire per contatto. Quand’anche si adottasse teoreticamente una posizione di interdipendenza e contestualità tra intuizioni (sensibilità) e concetti (pensiero), per dirla con Kant (secondo il quale senza il concetto le intuizioni non vedrebbero alcunché), e che pure rovescia la concezione empirica del concetto, continuerebbe a essere l’aspetto “tattile” e attivo (quello concettuale, dunque, che rende rappresentabile e quindi comunicabile la sensazione: perché è vero che la sensazione “tocca”, ma chi toccherebbe, manipolerebbe, la sensazione se non il concetto?) a costituire la salda base su cui poggiare le proprie certezze esperienziali: le immagini sono il tessuto di sogni e illusioni (quelle ottiche sono più frequenti di quelle tattili), la concretezza materiale pertiene invece all’esperienza inconfutabile. Anche perché ne lascia i segni. E sì, del resto anche le immagini lasciano il segno, come un’incisione, metaforicamente un’impressione tattile, nella memoria. L’immagine mentale, già reale, assume una fattezza di realtà condivisibile quando riprodotta, segnata, codificata. Il toccare ha infatti a che fare con il segno e la comunicazione ed è la nostra prima capacità linguistica. Per alcuni è addirittura la fonte del nostro linguaggio. Il segno, quel qualcosa che rimanda ad altro, è per certi pensatori stabilito dal tatto, non dalla vista (né tantomeno da idee innate).
Secondo Berkeley le cose che vediamo mutano troppo spesso percettivamente in base alla distanza che intercorre tra l’oggetto e chi osserva, e alla luce; quelle che tocchiamo non cambiano. La vista, per quanto strumento indispensabile di orientamento nel mondo, non percepisce nell’immediato figure o dimensioni, ma solo luci e colori: sono esse a impressionare la retina. La facoltà geometrica per eccellenza – ciò che ha a che fare con l’apparire delle cose in quanto forme – è quindi il tatto, che conosce per esperienza prima della vista, la quale dal canto suo coglie delle idee che mette in relazione con quell’esperienza tattile primaria. Per Berkeley l’occhio non vede la distanza, tra sé e l’oggetto, che si può conoscere solo dopo confronti di numerose percezioni visive e grazie all’aiuto degli altri sensi (la distanza, infatti, non si vede con l’occhio più di quanto non si senta con l’orecchio), il tatto in primis. Senza tatto, in sostanza, saremmo ciechi: non avendo mai imparato a misurare attraverso il corpo le distanze, andremmo a sbattere contro i muri. Riprendendo un esempio di Cartesio, Berkeley ribadisce come un cieco che tiene incrociati due bastoni di cui ignora la lunghezza sappia però dire – perché lo sente tattilmente – dove si trova il punto di intersezione. A ogni modo, il filosofo non assegna una preminenza al tatto. Ritiene i sensi interdipendenti: anche un oggetto toccato, ma non visto, non può esistere nella mente di una persona se privo di colore (che non sentiamo al tatto).
Da buon sensista, più deciso è invece Condillac che, attribuendo estrema fiducia al tatto, ribalta tutte le classifiche. Se Berkeley aveva immaginato come si sarebbe comportata un’intelligenza fornita di tutti i sensi tranne il tatto, Condillac propone un esperimento mentale ipotizzando una statua la quale possa avere un solo senso alla volta, giungendo alla conclusione che solamente il tatto è il senso necessario (perché permette a un corpo di percepirsi come vivente e quindi esistente) e sufficiente anche da solo per una minima conoscenza del mondo a cominciare da sé stesso («sono io», può dire muovendosi e poi toccandosi). Per un filosofo che crede nel primato gnoseologico delle sensazioni il tatto non può apparire come strumento probatorio di un’idea, ma piuttosto come primo e ineludibile produttore di idee. I segni, il linguaggio, i concetti, quindi, nascono grazie e attraverso la sensazione primaria (quella tattile in questo caso). Già nella metafora della tavoletta di cera c’è la figurazione tattile dell’impressione.
Sebbene le tesi degli empiristi possano essere discusse facendo leva sul fatto che possediamo (in forza a un senso comune o a un certo innatismo) una facoltà intuitiva tale da permetterci di ipotizzare (anzi, di sapere), senza prove tattili, che – per dire – i binari paralleli davanti ai nostri piedi rimarranno paralleli anche lì dove il mio occhio li vede incontrarsi in lontananza, l’aspetto gnoseologico importante del tatto sta nell’essere questo un dispositivo di precomprensione, un attrezzo di decodifica un po’ grossier, che accede immediato al trucco senza fronzoli. È vero che è la mano a risolvere il trompe-l’oeil, ma una volta che mi rendo conto, toccando, dell’illusione ottica, è di nuovo l’occhio a ricercare e a capire le leggi di quel gioco; quando usiamo le dita per accorgerci che nel tranello visivo di Ebbinghaus (quello – per capirci – dei due cerchi identici che, circondati da altri cerchi di dimensioni diverse, non sembrano uguali) le due circonferenze hanno il medesimo diametro, è con gli occhi che misuriamo la distanza tra le dita stesse. Perché il tatto svela sì l’inganno, ma non può essere il senso c...