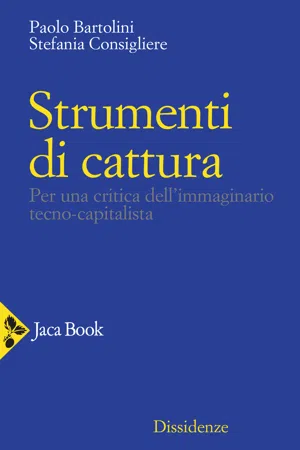L’unico grande testo di demonologia che l’età borghese ha prodotto: così Calasso definisce Il Capitale di Marx1. L’indicazione va presa sul serio. Appare nel commento a un’opera di Wedekind in cui è narrata la giovinezza sospesa e incantata di bellissime fanciulle, a lungo “coltivate” in uno splendido giardino isolato dal mondo. Questo tempo finisce quando esse compaiono infine, come perfetta forma-merce, sui palcoscenici di squallidi teatri e nei bordelli della città. L’esito inevitabile è lo stupro, oppure l’assassinio. Non si comprende la breve e intensa violenza che conclude la vita delle ragazze riferendola alla psicologia dei loro clienti o all’infamia dei bassifondi urbani: essa è già prefigurata in tutta la loro vita precedente, inscritta per intero nei passaggi più eterei della loro educazione, nel profumo dei fiori del giardino. Può essere compresa solo a livello di sistema: il teatro che eccita gli uomini e uccide le donne non è il luogo dove si manifesta un’eterna natura umana o l’immutabile lotta fra i sessi, ma una macchina perversa storicamente prodotta, il cui funzionamento è tanto più efficace quanto più è occulto, misterioso, inafferrabile. Da qui la necessità di farne un arcano: accuratamente macchinati fin dall’inizio, stupro e assassinio si presentano alla fine come sacrificio alle forze oscure e immutabili che fanno girare il mondo.
Questa mistificazione è uno dei trucchi più tipici del dominio: ciò che è artificiale deve apparire naturale, ciò che è stato lungamente preparato deve presentarsi come l’ordine stesso delle cose2. La reificazione di un fenomeno consiste appunto nel cancellare le tracce della sua produzione: il sopruso originario viene occultato e i suoi esiti presentati come un’ineludibile necessità cosmica. Non è un’invenzione dei moderni: dalla superiorità maschile nel patriarcato fino alla divinità dei re e alla più recente sociobiologia, l’oblio della violenza nasconde il processo che produce il dominio. Ma è stato senz’altro il capitalismo a perfezionarlo, innestando sopra l’antico dispositivo a due braccia un intero arsenale di tecniche di cattura basate più sulla fascinazione che sull’asservimento, più sulla persuasione che sulla coazione. Le braccia, così, diventano tre: violenza, oblio, fascinazione. La dissociazione raggiunge lo zenit.
Non solo siamo tenuti a dimenticare la brutalità della storia da cui veniamo e di quella che abitiamo (fatte di espropri, migrazioni coatte, slums, necroindustria, inquinamento, stragi, schiavismo e fascismi in ogni salsa), ma ora infine, nelle mille delizie del consumo, possiamo scordarci anche di noi stessi: di ciò che ci fa male, delle esperienze illegittime, delle memorie clandestine, di certe improvvise aperture di cuore. Al punto tale che da molto tempo chiamiamo libertà la nostra disempatia e nulla apprezziamo più della possibilità di recidere a nostro piacimento gli attaccamenti a luoghi, persone, idee, collettivi – di separarci, cioè, dalla nostra stessa storia, da ciò che ci ha fatto, da quel che sentiamo. Tutto è dismissibile nella continuità del godimento delle merci: cittadini globalizzati, siamo costruiti in modo da poterci muovere ovunque purché ad attenderci ci sia una bolla di Occidente del tutto simile a quella appena lasciata, fatta di supermercati aperti 24/7, di velocità, di grandi marche, di bancomat, di quartieri bianchi, di schermi, di servizi sessuali in libero accesso. Chi non vorrebbe vivere come noi? Peccato per quei risvegli nel mezzo della notte; per gli attacchi di panico che tagliano le gambe ai più giovani; per i momenti attoniti in cui sentiamo, con terrore, di non sentire più niente; per l’inconsapevolezza di sé che arriva fino a farsi cancro o depressione; per quelli fra i nostri contemporanei che hanno bisogno, per vivere, di continui supplementi psicoattivi. Qualcosa non torna.
Il primo indizio del disastro in corso siamo noi stessi, l’angoscia che ci attanaglia, l’incapacità di immaginare un tempo diverso dall’eterno presente che viviamo e che ci soffoca. Indizio misterioso, inspiegabile entro il quadro ufficiale della libertà e del progresso, ma di interpretazione assai semplice in altre cosmovisioni.
L’impresa che fa coincidere l’asservimento, la messa a servizio e l’assoggettamento, ovvero la produzione di quelli e quelle che, liberamente, fanno quel che devono fare, ha un nome antico. È qualcosa di cui i popoli più diversi – tranne noi moderni – conoscono la natura temibile, e la necessità di sviluppare mezzi adeguati per difendersene. Il suo nome è stregoneria3.
La parola è forte, fastidiosa. Concettualmente promettente.
Nonostante il timbro provocatorio (nessuno può impunemente parlare di stregoneria senza evocare tutti i fantasmi della modernità…), l’ipotesi stregonesca dispone già di una certa sedimentazione disciplinare. Ha una sua tenuta e una sua speciale potenza epistemologica.
Si presenta in due declinazioni. Quella più generale ipotizza una connessione fra modernità capitalista e stregoneria: qui si trovano l’analisi del totalitarismo di Hannah Arendt, le ricerche degli storici sul nesso, tradizionalmente percepito come misterioso, fra la caccia alle streghe e l’instaurarsi delle condizioni di produzione capitalistiche, le intuizioni (allora del tutto inattuali) di Parinetto, gli spettri di Marx descritti da Derrida, le ricerche meno note, ma cruciali, condotte in campo antropologico sulla strettissima relazione che ovunque si registra fra l’arrivo della modernità e la diffusione della stregoneria. La seconda declinazione, più forte, legge la modernità stessa come sistematica impresa di assoggettamento costruita sui tre assi elencati sopra: violenza, oblio e cattura. Nel 2005 lo storico del farmaco Philippe Pignarre e l’epistemologa Isabelle Stengers pubblicano in Francia un testo apertamente politico e “movimentista” intitolato La sorcellerie capitaliste, che propone un deciso salto in avanti nell’utilizzo critico della categoria. Oltre a ciò, negli ultimi anni non si contano le interpretazioni, spesso eccellenti, del capitalismo come teologia (a partire dalla riscoperta di un breve testo di Benjamin intitolato La religione del capitale4) e come macchina magica di cattura e distruzione (com’è il caso nei testi di Mark Fisher). Questa messe di testi sarà l’humus di questo scritto, il cui senso è di prolungare nel presente l’impresa di disvelamento a cui Marx dedicò tanta energia.
Essa passava, allora, per categorie che suonano lise alle nostre orecchie ma che erano all’epoca veri e propri dispositivi di visione, tanto sorprendenti quanto per noi la stregoneria: alienazione, feticismo, reificazione5. Non è per caso, nota Parinetto, che nel disvelare Marx impiega un vocabolario immaginifico liberamente tratto dall’alchimia, dalla freniatria, dalla tragedia. Se avesse descritto il mondo attorno a sé con il vocabolario degli apologeti del mercato, non sarebbe riuscito a sollevare il velo di Maia che quelle stesse descrizioni “oggettive” gettano sul mondo. Per bucare l’ideologia occorre uno stratagemma: bisogna contro-descrivere il mondo a partire da un punto di osservazione totalmente altro. Spaesarsi.
A un secolo e mezzo di distanza possiamo riattualizzare l’operazione marxiana estendendola e approfondendola in più direzioni: dall’enorme rimosso coloniale all’uso della violenza come condizione permanente di possibilità, dai meccanismi di cattura e plasmazione delle soggettività ai fantasmi della vita spicciola. Come all’epoca di Marx, in quest’impresa ne va della nostra possibilità di esistenza al di là della sopravvivenza aumentata in cui galleggiamo (mentre ne va della sopravvivenza stessa per tutti coloro che, fuori dalla fortezza-Occidente, sono investiti dall’espansione del capitale)6. E, come allora, abbiamo bisogno di un punto di osservazione totalmente altro che ci costringa allo straniamento. Qui proveremo a farlo a partire dalle categorie indagate da quella paradossale “scienza dell’altrove” che è l’etnologia.
E in effetti non è terrorizzante pensare che, se il nostro nemico non compare mai di persona, non è perché si sta nascondendo, ma perché non è un uomo? Perché non esiste allo stesso modo in cui esiste un uomo. E che, come uno spirito, non dispone di un corpo proprio, ma ha la capacità di fare di ogni corpo un’antenna/relè delle sue intenzioni? E nondimeno, non lo vediamo ogni giorno? Non è innanzitutto uno spirito, uno stato d’animo, a condannare queste folle immense a trascinare nella malinconia l’intera loro vita di schiavi? Cos’altro, se non uno spirito, poteva impadronirsi e nutrirsi delle gioie naturali dei corpi? Per condannarli poi a portare a termine, nel loro lavoro, il processo della loro stessa distruzione? Non abbiamo dunque, nella società capitalista, un caso compiuto e altamente contagioso di possessione? Di possessione collettiva? Un’operazione gigantesca, non già segreta ma a cielo aperto, di manipolazione mentale, d’influenzamento comportamentale attraverso i media, la pubblicità, l’architettura? Non è attraverso lo spirito che siamo in prima istanza incatenati? Le cose che ci impediamo di fare o di pensare, non sono forse strappate alla radice da un condizionamento permanente e devastante del nostro pensiero? Un militante diceva recentemente che l’attuale problema climatico ed ecologico è, innanzitutto, un problema di ordine psicologico. È tale la discrepanza fra i nostri discorsi, i nostri valori e i nostri atti, da rientrare a buon diritto nella patologia mentale. Quale forza può indurci a una simile negazione e condannarci a una simile impotenza, se non una sorta di affatturazione7?
Superato lo scandalo, l’utilità critica del concetto di stregoneria si rivela notevole. Esso spiega, per cominciare, perché l’apostrofe di Calasso suoni al contempo sorprendente ed esatta: in fondo, tutta la complicata operazione che Marx svolge nel Capitale consiste proprio nello studiare il capitalismo come un enorme dispositivo stregonesco che, con la sua potenza e i suoi trucchi, fa dimenticare la quantità di sangue e sudore che sono serviti per edificarlo e che, da allora, continuamente l’alimentano. Ma soprattutto, permette di affrancarci da uno dei più perniciosi strumenti di cattura della modernità: la pretesa di avere l’ultima parola su ciò che è reale e sulla verità.
(Qui è indispensabile un inciso. La modernità è molte cose, spesso anche di segno opposto: il romanticismo è tanto moderno quanto l’illuminismo, Spinoza come Hobbes, l’utopismo rivoluzionario come il totalitarismo. Conteneva e contiene possibilità ben diverse da quelle attualizzate nel nostro presente e alcune di queste sono, per chi scrive, attaccamenti irrinunciabili: la liberazione dalla parte più disperante della fatica del lavoro, un diverso rapporto con il potere, la possibilità della divergenza, soggettiva o collettiva che sia8. Tacitando volta dopo volta le speranze e le emergenze rivoluzionarie, la modernità capitalista si è tuttavia declinata come la civiltà egemone totalizzante e distruttiva che vediamo attorno a noi. Quando in queste pagine si leggerà la parola “modernità”, essa sarà da intendersi come abbreviazione per indicarne la versione egemone, figlia legittima del dominio coloniale, del plusvalore capitalista e dell’ideologia riduzionista. A valle di una lunga erranza antropologica non so più se una modernità noncoloniale, non-capitalista e non-riduzionista sia possibile: quel che è certo, e per me di grande conforto, è che le istanze di liberazione, di lavorazione del potere, di eguaglianza, democrazia e tolleranza – che presuntuosamente abbiamo attribuito al solo Occidente moderno – si ritrovano, mutatis mutandis, anche altrove, presso altri collettivi e in modo particolarmente evidente laddove mondi umani differenti entrino in regime di scambio reciproco)9.
E dunque: la modernità egemone s’è fatta gran vanto della sua impresa di disincanto, che relega nella natura, o nell’impostura, tutto ciò che non fa interamente capo alla società degli uomini e al suo campione, il cittadino-individuo, unico ente nel cosmo ad avere un’intenzione e, quindi, una soggettività. Reintroducendo non solo l’incanto, ma anche il pericolo che lo caratterizza, il concetto di stregoneria permette un primo recupero, tutt’altro che ingenuo, di prospettive che parevano perdute. È una questione di poetica politica: stregoneria è il nome di un luogo concettuale dove il conoscere e il sentire si toccano e, nel toccarsi, producono effetti spaesanti. Si apre allora una possibilità di reincantamento del mondo, dopo i barili di acido disincantante che abbiamo dovuto berci negli ultimi cinque secoli. E si può riprendere il vocabolario immaginifico di Marx e della rivolta romantica e surrealista – le “fantasmagorie”, i “sogni di una cosa”, l’“alchimia della natura”, le “illuminazioni profane” – come parte di una strategia che, nel criticare il mondo, vorrebbe smettere di inaridirlo ulteriormente.