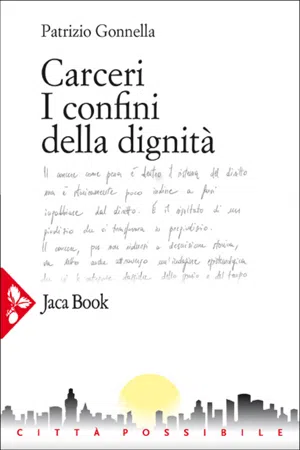![]()
Parte seconda
LA DIGNITÀ UMANA E I DIRITTI
![]()
1
LO SGUARDO ESTERNO DELLA SOFT LAW INTERNAZIONALE
La questione criminale è stata per lungo tempo considerata una questione di esclusiva pertinenza nazionale. Il campo della penalità ha costituito uno degli ambiti di sperimentazione dell’esercizio monopolistico del potere da parte dello Stato sovrano moderno. Il potere di punire proprio delle autorità pubbliche, senza condizionamenti esterni, è stato identificato come il nucleo essenziale di uno Stato che andava a mano a mano perdendo altrove sovranità a causa di una globalizzazione che non ha risparmiato la politica e l’economia.
Negli anni, tuttavia, anche la questione carceraria – trascinata dal processo di internazionalizzazione dei diritti umani – è diventata sempre più una questione non soltanto nazionale. Una stratificazione di norme e di atti avvenuta nel tempo è andata a costituire quella che sempre meno è una soft law internazionale sui diritti delle persone private della libertà e sempre più costituisce un sistema giuridico/diplomatico capace di condizionare la vita interna alle carceri delle singole nazioni. Per tentare di ricostruire tale sistema, bisogna innanzitutto distinguere l’ambito universale da quello continentale europeo. In entrambi vanno individuate le norme specifiche in campo penitenziario e spiegate assieme a quelle generali sui diritti umani le quali, in quanto appunto generali, valgono anche per le persone private della libertà. Vanno differenziate le norme vincolanti da quelle che non lo sono e va raccontato un sistema composto non solo di norme bensì anche di sentenze, di rapporti, di monitoraggi, di raccomandazioni, di risoluzioni, di operazioni di fact-finding, di consulenze su scala internazionale. Il tema penitenziario è inoltre sovranazionalizzato non solo perché vi è una produzione normativa o giurisprudenziale di organismi sovranazionali indirizzata ai singoli Stati, ma anche perché esistono norme, giudici e carceri che sono essi stessi costitutivi di un livello non nazionale.
Ne esce un sistema composito, la cui ricostruzione, trattandosi di un sistema non pensato come tale, non è affatto scontata. Tentiamo allora, per quanto è possibile, di addentrarci in essa, seguendo un racconto cronologico che ci aiuterà a tenere il filo del discorso.
Se partiamo dal livello delle Nazioni Unite, incontriamo in primo luogo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Nel sistema dei diritti umani la Dichiarazione del 1948 è considerata una sorta di Grundnorm, per quanto formalmente sia priva di una efficacia normativa vincolante. Nel diritto internazionale, infatti, una Dichiarazione non è altro che un suggerimento, un invito rivolto agli Stati. Eppure nessuno sosterrebbe mai che la Dichiarazione del 1948 sia ridimensionabile a livello di atto non normativo. La sua forza sta nei contenuti e nei promotori (l’intera comunità mondiale). Dopo il richiamo alla dignità umana che si legge nel Preambolo, l’articolo 5 afferma che nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudele, inumana o degradante; l’articolo 9 prevede che nessuno può essere sottoposto ad arresto arbitrario; l’articolo 11 sancisce che chiunque viene accusato di avere commesso un reato ha il diritto di essere considerato innocente fino a eventuale condanna e deve vedersi riconosciute tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nel 1957 l’ONU ha adottato le Standard Minimum Rules for the Treatment of the Prisoners1, che sono state successivamente modificate nel 19772. Tali regole, anch’esse prive di vincolatività, non impongono un modello penitenziario bensì stimolano uno sforzo degli Stati verso un’umanizzazione della pena detentiva e verso l’adozione di politiche di graduale reinserimento sociale. Non vi è ancora un elenco tassativo e inderogabile dei diritti dei detenuti. Fin dal titolo si intravede il senso delle regole ONU, che sono per l’appunto regole minime. Individuano standard al di sotto dei quali non bisogna scendere. Non suggeriscono standard elevati, non scelgono la via del massimo comune denominatore, ma introducono concetti chiave che si ripeteranno in tutta l’ampia produzione dell’ONU. All’articolo 60 si afferma che: «Vanno minimizzate tutte le differenze tra la vita in carcere e la vita libera le quali riducono la responsabilità dei detenuti e la loro dignità umana». Si pone attenzione ai concetti chiave di responsabilità e di dignità umana. Le prigioni devono proporre un’organizzazione di vita interna che aspiri a somigliare alla vita vera. Se così non fosse – si afferma – sarebbe messa a rischio la dignità umana dei prigionieri e non sarebbe favorito il processo di responsabilizzazione del detenuto.
Nel 1966 vengono adottati dalle Nazioni Unite i due Patti sui Diritti civili e politici e sui Diritti sociali, economici e culturali. Si tratta di convenzioni internazionali che hanno una più intensa cogenza per i Paesi che le ratificano. Essi introducono la nozione di interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani, che poi sarà solennemente ribadita nella Dichiarazione e Programma di azione sui diritti umani, esito finale dei lavori della Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993. I due Patti non prevedono sanzioni per chi non ne rispetta i contenuti, ma si limitano a rafforzare obblighi di presentare rapporti periodici a organismi internazionali. La Comunità degli Stati è divisa e non sempre pronta a farsi giudicare per come protegge e promuove i diritti umani. Il Patto sui Diritti civili e politici all’articolo 7 proibisce la tortura e ogni altra forma di trattamento inumano o degradante. L’articolo 9 ribadisce che: «Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona». È questa la codificazione dell’habeas corpus. Il successivo articolo 10 prevede che: «Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana. Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate; gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico». Un detenuto che si vede trattato senza umanità può ricorrere al Comitato istituito dal Patto ONU, purché lo Stato di appartenenza abbia riconosciuto espressamente la competenza del Comitato a ricevere comunicazioni dai singoli individui. Si tratta di una procedura mista, che ha pochi tratti giurisdizionali e molti invece di natura evidentemente diplomatica.
Nel 1979 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato un Codice di condotta per gli appartenenti alle forze dell’ordine3. Sono poche norme, che non lasciano dubbi sui comportamenti ammessi e su quelli vietati. Ridisegnano un ruolo delle forze dell’ordine proiettato all’obiettivo della protezione dei diritti umani. Un ruolo che le obbliga esplicitamente a non violare quei diritti che esse stesse per mandato dello Stato devono proteggere. Il codice etico voluto dall’ONU è una sorta di giuramento di Ippocrate delle forze dell’ordine, che intende favorire un rapporto fiduciario e non impaurito fra cittadini e istituzioni. Vi è la consapevolezza che il tema dei diritti dei detenuti si lega a quello del ruolo pubblico dell’operatore di polizia.
Il 10 dicembre 1984 è stata messa alla firma degli Stati la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti, crudeli, inumani o degradanti. Il testo offre una definizione formale di cosa sia la tortura e indica alcuni obblighi di adeguamento normativo e operativo a carico degli Stati. Nasce così un altro filone di impegno della comunità sovranazionale in funzione della prevenzione della tortura. Esso avrà una coda nel 2002 con l’adozione del protocollo opzionale alla Convenzione del 1984. Quest’ultimo prevede, tra l’altro, la nascita di un organismo internazionale dotato di compiti ispettivi di tutti i luoghi di detenzione, nonché l’obbligo per ciascuno Stato di dar vita a un organismo nazionale di controllo e monitoraggio di carceri, caserme di polizia, centri di detenzione per immigrati4. È evidente che ogniqualvolta il diritto internazionale tratti il tema della tortura, indirettamente esso tratta il tema delle carceri, orientando la loro gestione a principi di umanità e di rispetto dei diritti.
Nel 1988 l’Assemblea Generale ha adottato il Corpo dei Principi per la protezione di tutte le persone da ogni forma di detenzione o imprigionamento, che presenta poche novità rispetto alle Regole del 1957.
Il sistema ONU dei diritti umani ha traballato a seguito dei colpi subiti da parte delle legislazioni nazionali dopo l’attentato terroristico dell’11 settembre 2001. In molti Stati – USA e Regno Unito in primis, ma anche su iniziativa dell’Unione Europea (si pensi alla direttiva sul mandato di arresto europeo) – sono stati messi in discussione principi secolari come quello del divieto di arresto arbitrario o di detenzione non giurisdizionalizzata. La prigione a cielo aperto di Guantanamo è l’esemplificazione truce della dottrina del cosiddetto «diritto penale del nemico»5, ovvero di un diritto da applicare ai nemici, privo di quelle garanzie pensate invece per i cittadini e i criminali comuni, sgrammaticato e non conforme a dignità umana.
Nonostante sia stata in parte anestetizzata, la machinery ONU ha tuttavia resistito e non ha subito modifiche formali. Essa si compone anche di gruppi di lavoro6, di Rapporteurs speciali7, nonché di organi di giustizia sovranazionale deputati a giudicare criminali di guerra e autori di crimini contro l’umanità.
È nata a Roma nel 1998 la Corte Penale Internazionale che, muovendosi nel solco delle Corti ad hoc per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia e in Rwanda, ha previsto proprie procedure investigative e penitenziarie. Esiste quindi un carcere sovranazionale non gestito da alcun singolo Stato.
Infine, un occhio alle vicende penitenziarie interne degli Stati è dato dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, che periodicamente8 li pone sotto osservazione chiedendo spiegazioni intorno alle denunce di violazioni sistemiche o sistematiche di diritti umani. Nelle sessioni del Consiglio ci si è spesso occupati delle insufficienze della legislazione nella protezione dei diritti delle persone detenute, delle condizioni di vita nelle carceri, dei trattamenti arbitrari, della violenza istituzionale e della tortura.
Se ci spostiamo adesso dal livello universale a quello regionale europeo, vediamo che anche qui l’apparato a tutela dei diritti delle persone detenute è composto di norme, sentenze e ispezioni. È un apparato complesso, dotato di forza persuasiva maggiore nei confronti dei singoli Stati rispetto a quanto accade per le Nazioni Unite. L’ambito di operatività è quello del Consiglio di Europa, composto da 47 Stati che vanno dall’Atlantico agli Urali. Un ambito largo, dove sono reclusi circa un milione e ottocentomila detenuti. L’apparato europeo si compone di molti strati, che sempre più si vanno reciprocamente a intersecare e che penetrano nella dimensione nazionale a prescindere dalla loro cogenza formale.
In primo luogo vi sono le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, deputata a decidere intorno alle violazioni delle norme presenti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Nella Convenzione, ad eccezione dell’articolo 3 che proibisce la tortura e le pene e i trattamenti inumani o degradanti, non vi sono norme specifiche riguardanti la condizione di privazione della libertà personale. Eppure nel tempo si è consolidata una giurisprudenza ampia e approfondita in materia di diritti dei detenuti. L’articolo 14 prevede che il godimento dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione sia assicurato a chiunque, senza discriminazioni legate allo status. Quello di detenuto non priva dunque la persona dell’insieme dei diritti proclamati nella Convenzione. Ogni differenziazione di trattamento rispetto ai diritti, ha nel tempo affermato la Corte, richiede l’esplicitazione dello scopo legittimo perseguito. Le interferenze nell’area dei diritti dei detenuti sono ritenute ammissibili solo nei casi in cui vi sia – citando le parole usate dalla Corte9 – «un bisogno sociale imperioso» ritenuto necessario in una società democratica.
Le sentenze della Corte possono segnalare una mancanza legislativa e soprattutto imporre un risarcimento economico ai danni dello Stato responsabile della violazione, secondo il principio che negare i diritti umani oltre che essere indegno deve risultare anche oneroso. In alcuni casi si può giungere a sentenze che sono moniti politici e intimano agli Stati di cambiare le proprie norme e le proprie pratiche. Così è avvenuto in materia carceraria con la sentenza Torreggiani, precedentemente citata, che ha visto l’Italia protagonista in senso negativo di una condanna giuridica con obblighi di intervento politico. Nella storia della Corte molte migliaia sono state le decisioni prese a seguito di ricorsi presentati da detenuti soprattutto in violazione dell’articolo 3. I lavori preparatori della Convenzione testimoniano che, attraverso tale articolo, si voleva allargare lo spazio del giudizio e della condanna a tutte le questioni cui rimanda la quotidianità penitenziaria. Una classificazione delle sentenze della Corte sull’articolo 3 può essere sommariamente la seguente: 1) casi riguardanti i maltrattamenti fisici; 2) casi concernenti le condizioni di detenzione: spazi insufficienti, condizioni igieniche inadeguate, cibo insufficiente, prestazioni mediche inadeguate, isolamento prolungato, eccesso di rigore nelle sanzioni disciplinari; 3) casi riguardanti le punizioni corporali; 4) casi riguardanti i divieti di espulsione o estradizione verso Stati dove la persona è a rischio di essere sottoposta a tortura o a trattamento inumano o degradante. Accanto a queste, vi sono le sentenze nelle quali la condanna è esito della violazione di altri articoli della Convenzione, da quelli che proteggono il diritto dei detenuti alla riservatezza della corrispondenza a quelli che si occupano del diritto alle relazioni affettive.
I Rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) sono un altro degli elementi che compongono l’apparato europeo di tutela dei diritti dei detenuti. Il Comitato è stato istituito dall’omonima Convenzione adottata in via definitiva dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 26 giugno 198710. La Convenzione non contiene alcuna definizione di tortura o di trattamenti inumani o degradanti. Suo scopo esclusivo è l’istituzione del relativo Comitato, che ha il compito di monitorare i luoghi di limitazione o privazione della libertà personale. Esso non ha compiti giurisdizionali o quasi giurisdizionali, bensì funzioni di natura ispettiva. Il Comitato visita periodicamente carceri, commissariati, caserme, ospedali psichiatrici, centri per immigrati. Può anche organizzare visite straordinarie ad hoc, quando le informazioni in suo possesso lo rendano necessario. Le delegazioni possono accedere senza limiti ai luoghi di privazione della libertà personale presenti nel territorio dello Stato, assumere tutte le informazioni utili, parlare riservatamente con detenuti e testimoni, interrogare il personale o chi si ritenga opportuno, fare osservazioni in tempo reale o aprire procedure diplomatiche. La sanzione più grave a disposizione del Comitato è la Dichiarazione Pubblica di Biasimo, che consiste nel rendere pubbliche le annotazioni del Comitato stesso in assenza dell’autorizzazione delle autorità statali coinvolte. Tale sanzione è comminabile in caso di infrazioni gravi11. Da ciò si desume il genere di azione proprio del CPT, che deve ottenere risultati con il dialogo, la persuasione delle autorità politiche nazionali, l’uso sapiente dei media e la collaborazione con le organizzazioni non governative. Dai Rapporti del Comitato e dalle risposte degli Stati si evince quale sia la condizione di vita nelle prigioni, quali i maggiori problemi, quali i diritti più a rischio di violazione, nonché quanto alta sia la considerazione dei singoli governi nei confronti degli organismi sovranazionali. Il dialogo serrato del Comitato con le autorità nazionali ha prodotto risultati anche in Italia: da modifiche normative, attraverso lo strumento delle circolari, a decisioni amministrative, quali la chiusura di reparti detentivi o l’eliminazione di pratiche illegali.
Vi sono infine le norme. Molte sono le Risoluzioni del Consiglio d’Europa – atti normativi non vincolanti per gli Stati membri, dotati di cogenza morale p...