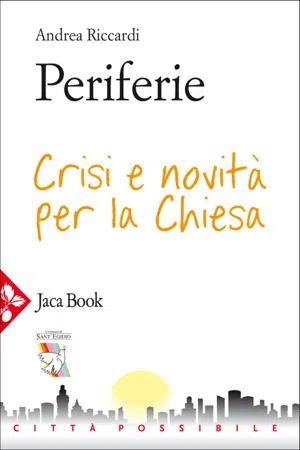La nascita delle periferie contemporanee
Le periferie si sono riproposte con forza al cristianesimo del Novecento, non tanto come luogo di elezione dove vivere la fedeltà al Vangelo e la ricerca di Dio, quanto come spazi problematici per la sopravvivenza del cristianesimo. Si sono qualificate, con tutti i loro bisogni, quasi come terra straniera o in via di estraniazione dalla presenza dei cristiani del Novecento, soprattutto agli occhi di quanti hanno saputo leggere con sensibilità la nuova geografia dell’umanità in cambiamento. Spesso, invece, una Chiesa, attenta solo al centro, non si è sentita sfidata dall’allontanamento delle periferie, proprio perché autocentrata e autoreferenziale, per usare le espressioni di papa Francesco.
Le periferie divengono una «terra nuova» anche in società caratterizzate da un’antica continuità storica del cristianesimo. Dall’Ottocento la rivoluzione industriale addensa masse di proletari e di operai nelle città, impiegati nell’industria. Costruisce nuovi quartieri ai margini della città storica o di quella più recente, spesso con condizioni abitative precarie e scarsi servizi. Sono mondi di immigrati, che si sono allontanati dalle campagne dove, per tradizione, vigeva un regime sociale cristiano. Le nuove periferie sembrano la «città dei poveri», di cui parla Giovanni Crisostomo nelle sue omelie ad Antiochia1.
La costante caratteristica della storia contemporanea è l’inurbamento delle masse (e quindi la crescita delle periferie), ma anche il progressivo spopolamento delle campagne o la riduzione di esse a periferie delle città. La città moderna «mangia» le periferie (questo avviene con tanta rapidità oggi in Africa, un continente in cui il mondo rurale è ancora molto importante), mentre le campagne perdono una parte dei loro abitanti. Così le periferie sono spesso abitate da gente marginale estranea al benessere della città, ma funzionale ai suoi bisogni o alle necessità di lavoro.
La Chiesa cattolica, nei secoli, ha stabilito un rapporto giuridico-pastorale articolato con il territorio. Nel Novecento, l’intero globo viene mappato dalle circoscrizioni ecclesiastiche al servizio della cura pastorale dei fedeli ovunque abitino seppure con intensità differente, come si vede nell’Atlas hierarchicus. Non c’è un angolo – lo dico paradossalmente – della terra che non risponda a una diocesi e a una circoscrizione ecclesiastica e che, quindi, non abbia un suo responsabile pastorale. La diocesi è poi articolata in circoscrizioni ecclesiastiche minori, le parrocchie, che esercitano la cura dei fedeli su di un territorio determinato e si collegano a una o più chiese. Sulle regioni di missione (quelli su cui si esercita il controllo della congregazione romana de Propaganda Fide), cioè dove l’implantazione della Chiesa è più recente, questa struttura è forse più approssimativa, benché il modello sia lo stesso. Nelle terre di antica cristianità, invece, la sua articolazione raggiunge un’aderenza totale al territorio, simile a quella dell’amministrazione dello Stato. Questa aderenza, centrata sulla parrocchia, è rimessa in discussione e infragilita oggi dalla mancanza di preti. Tale impostazione delle strutture corrisponde anche a una visione statale e – vorrei dire – imperiale, con un precipuo rapporto con il territorio. Lo stesso termine di «diocesi» (che significa «amministrazione») è mutuato dalle circoscrizioni dell’impero romano.
Si può dire che nessun luogo sia escluso dalla geografia della Chiesa, che abbraccia il globo nella sua interezza. C’è un’idea «romana» del controllo geografico o della cura della gente che vi abita, per cui la Chiesa copre con la nomina dei responsabili – vescovi, parroci o altro – ogni parte delle circoscrizioni ecclesiastiche. In un certo senso, dal centro si governano le periferie: dal centro diocesano o dal centro parrocchiale… Altre Chiese, diverse da quella cattolica, hanno una visione meno completa e territoriale della cura pastorale, come quella russa che non conosce fino a oggi l’idea di circoscrizioni parrocchiali, anche se realizza chiese per il culto dei suoi fedeli, vicino al luogo dove abitano.
Le periferie mettono in crisi questa visione romana della Chiesa e non da oggi. Innanzi tutto con la crescita tumultuosa della loro popolazione. Perché le parrocchie non siano circoscrizioni troppo grandi, senza rapporto con la popolazione, le diocesi si sono impegnate in un’opera importante di costruzione di nuove chiese come sedi parrocchiali. Si tende a evitare, così, che l’edificio della chiesa, dove si svolge il culto, sia lontano dalle abitazioni della gente, irraggiungibile per essa.
Tra Ottocento e Novecento (ma specie in quest’ultimo secolo), il cattolicesimo ha compiuto un’importante e grande opera di edificazione di complessi pastorali nuovi nelle periferie delle città, specie quelle più grandi e sviluppate. Spesso, in un quartiere marginale, la parrocchia è una «cittadella» della Chiesa, immersa in un ambiente investito da processi di secolarizzazione, esterno agli antichi riferimenti religiosi delle campagne, o da un’immigrazione di popolazioni non cattoliche. La parrocchia non è più il cuore del villaggio, come la descriveva per i tempi della cristianità in un suo importante libro Gabriel Le Bras, L’Eglise et le village2. Allora la chiesa era il centro della vita sociale del villaggio, circondata dal cimitero, e richiamava un universo cristiano ordinato. La parrocchia in periferia, talvolta costruita in un angolo del quartiere, non ha più la centralità tradizionale sulla piazza dove si svolge la vita sociale e cittadina. Infatti la centralità della chiesa nel villaggio e della cattedrale nella città manifesta una condizione di cristianità ormai perduta, anche nei paesi di antica tradizione cristiana.
Il tessuto religioso nelle città storiche, però, era caratterizzato non solo dalla parrocchia, ma da una complessità di realtà cristiane, a partire dalle confraternite con le loro chiese, dagli oratori, dalle case religiose maschili e femminili, dalle diverse opere. La chiesa, centrale nella città, nel quartiere o nel villaggio, era accompagnata da un plesso di istituzioni religiose e pastorali che permeavano la società cristiana. Talvolta restano antiche chiese, ma la società è cambiata, non è più solo cristiana, bensì pluralista, mentre si sono smarriti i comuni riferimenti socio-religiosi di ieri3. Le istituzioni cristiane sono ormai una realtà isolata nel contesto sociale.
Nella periferia contemporanea, la Chiesa finisce per ridursi alla sola presenza della parrocchia, quando c’è ed è accessibile. Questo avviene anche nelle città storiche – in parte –, spesso perché gli Stati laici hanno secolarizzato beni, edifici e istituzioni della Chiesa, ma anche per la riduzione del numero dei preti. Le misure di secolarizzazione della Chiesa, da parte degli Stati laici, hanno voluto ridurla alle sole strutture parrocchiali. Ma lo stesso sviluppo urbano ha imposto alla Chiesa di limitare la sua presenza agli edifici parrocchiali, la cui costruzione ha rappresentato uno sforzo finanziario e organizzativo importante nell’ultimo secolo, per presidiare pastoralmente il territorio.
Non si tratta solo di realizzare nuove istituzioni religiose nelle periferie, ma anche una presenza in mondi in trasformazione. Queste nuove realtà, per il processo di inurbamento della loro popolazione, per il distacco dal mondo religioso tradizionale della campagna, per nuove esperienze umane, di lavoro e sociali, divengono progressivamente estranee alla Chiesa. Il mondo dei devoti cattolici si restringe agli ambienti che fanno capo alla parrocchia, ridotti e connotati socialmente, che sono solo una componente d’una società pluralista.
La maggioranza dei fedeli divengono infedeli – diceva il card. Montini, arcivescovo di una grande città come Milano, pensando all’Italia degli anni Cinquanta4. La Chiesa resta il mondo dei devoti, spesso differenziato da quello delle masse dei periferici, che sono la maggioranza. Nuove condizioni di lavoro particolarmente dure hanno indotto mutazioni profonde nella mentalità di quella che veniva chiamata la classe operaia. Già si è detto dello spazio del movimento socialista in questi ambienti. Certo non tutti gli uomini e le donne delle periferie sono operai, ma la mentalità operaia segna fortemente queste realtà e le caratterizza per una crescente estraniazione al mondo e ai riti della Chiesa. Il grande problema della Chiesa nel Novecento – come ho già detto – è il rapporto con periferie sempre più impenetrabili alla sua presenza, in particolare quelle urbane e operaie che la Chiesa sente ostili o estranee a sé.
Estraneità dal cristianesimo
Si ritorna così alla questione esemplificata in maniera significativa dalla risposta di Corbon al vescovo Dupanloup che chiedeva: «Chi mi dirà perché questo popolo ci abbandona?». A fine Ottocento, la Chiesa aveva la percezione – lo dice chiaro mons. Dupanloup – che il popolo o una parte di esso abbandonasse le istituzioni cattoliche e la fede cristiana. Era soprattutto il mondo del proletariato, che attraversava una transizione profonda nelle periferie delle città e nel lavoro industriale. Non si trattava solo di un distacco dalle istituzioni ecclesiastiche, ma della nascita di nuove aspettative rivolte dal mondo proletario ad altri movimenti rispetto alla Chiesa.
Il riscatto delle masse operaie e periferiche non veniva più dalle speranze e dalle consolazioni della Chiesa, spesso invece considerata alleata con i ricchi o il potere, ma dall’autorganizzazione del mondo operaio e dalla sua capacità di lottare e di liberarsi, quindi dal movimento socialista e comunista. È una lunga storia, che non può essere riassunta in poche righe, quella della lotta del riscatto delle masse operaie attraverso i partiti, i sindacati, i movimenti, spesso facenti riferimento all’ideologia socialista o al marxismo. È un altro universo di riferimenti e valori, in cui la fede religiosa e la Chiesa non hanno posto o sono considerate in modo negativo. Ed è un universo sovente in conflitto con la Chiesa e i movimenti ad essa legati. È il grande problema della Chiesa in Europa lungo il ventesimo secolo.
La storia delle periferie si incrocia con il socialismo o il marxismo, insomma con una «nuova» politica, che assume spesso il carattere di riscatto messianico (quasi religioso ed esclusivo) delle masse proletarie. In questa vicenda, che dura più di un secolo, non bisogna pensare che la Chiesa sia immota e rinchiusa nella cittadella della parrocchia o nelle sue istituzioni, insomma bloccata in una fissità. Esiste pure un importante movimento sociale e operaio cattolico, che sale da fine Ottocento sulla scia della Rerum novarum di Leone XIII. C’è insomma un vasto e variegato cattolicesimo sociale che va dall’Ottocento al Novecento, talvolta competitivo con il movimento operaio5. Ma l’anima del riscatto – specie nelle periferie – è tendenzialmente quella del movimento socialista.
Negli ambienti periferici, spesso, regna un grande abbandono dei lavoratori e delle loro famiglie. I romanzi dell’Ottocento hanno messo in luce le privazioni del proletariato, il dramma delle famiglie, le dure condizioni di lavoro, lo sfruttamento dei bambini come lavoratori e l’assenza di educazione e assistenza. Le prime inchieste sociologiche sul lavoro e sugli ambienti dei lavoratori mostrano le pesanti condizioni di vita nelle periferie e di occupazione nell’industria. In questo quadro nuovo e difficile, avviene un progressivo distacco delle masse operaie dalla vita religiosa: è la secolarizzazione dei periferici (che talvolta abitano anche in malsani quartieri al centro delle città). La «secolarizzazione», espressione in voga nella sociologia e nella pastorale del Novecento (descrittiva di un fenomeno di scristianizzazione e di autonomia dal riferimento ecclesiastico), è un movimento complesso, che mette in discussione le acquisizioni certe e le appartenenze tradizionali, soprattutto che segna il distacco da un quadro di vita sociale regolato dalla religione.
In ogni modo, il mondo della cristianità, quello urbano e quello delle campagne, è ormai finito. C’è una secolarizzazione ottonovecentesca della borghesia, impregnata di cultura positivista, scientifica o liberale, accanto a cui si realizza – con altri percorsi – la secolarizzazione degli ambienti popolari6. È una storia che riguarda complessivamente tutto il mondo della città, divenuta ormai una realtà secolare7. Progressivamente, la cultura urbana plasma – in tempi più recenti, specie con lo sviluppo dei mass media – l’intera società.
Le realtà periferiche, specie il proletariato – come ho detto –, si autorganizzano nella lotta per il proprio riscatto. Nel cuore dell’Ottocento, Pierre Proudhon proclama con forza l’irreligione di un ambiente popolare che si libera con le proprie mani: «Il popolo non ci casca più, e benché gli sia impossibile di seguire col ragionamento la catena delle idee e dei fatti… il suo istinto gli dice che la sola cosa che gli impedisce di essere felice e ricco per mezzo del suo lavoro, è la teologia, e nel cuore non è più cristiano»8. Si è già parlato di quello che Olivier Clément efficacemente definisce il divorzio tra il sacramento dell’altare (la vita religiosa) e il sacramento del povero: insomma il distacco tra la Chiesa e il mondo dei poveri e dei periferici, tra la fede e le loro lotte.
Naturalmente questo processo di secolarizzazione delle attese e delle speranze delle periferie è complesso e variabile: dipende dalla vicenda dei vari paesi, vive differenziazioni secondo le diverse economie e storie, ha cicli e movimenti diversificati. È però uno dei grandi drammi del cristianesimo novecentesco: l’estraniazione d’importanti gruppi della popolazione dalla pratica delle comunità cristiane e dai riferimenti religiosi.
Eppure le periferie divengono un polo dec...