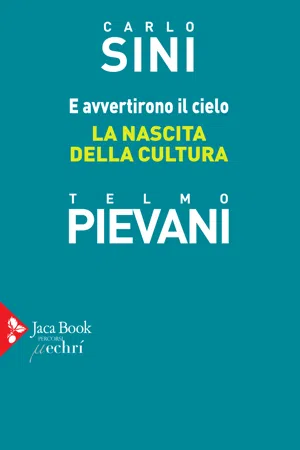Sini: Inizierei il nostro dialogo con delle considerazioni tratte dal fondamentale libro di Luigi Luca Cavalli-Sforza, Evoluzione culturale (1989), Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma 2019; e in particolare dal tuo prezioso saggio che accompagna il libro (Gli intrecci tra biologia e cultura, a partire da Luigi Luca Cavalli-Sforza): così siamo subito al centro del nostro tema.
Ricorderei anzitutto al lettore la pagina iniziale del tuo scritto, un lavoro che è una presentazione molto ampia ed efficace della ricerca grandemente innovativa di Cavalli-Sforza, ma la faccio precedere da un’osservazione che dice: «Le ondate migratorie in un luogo lasciano tracce genetiche e linguistiche allo stesso tempo» (p. 105). Penso che questa frase susciti ancora in molti (e di sicuro anche in me) una sorta di “stupore cartesiano”; siamo talmente abituati da secoli alla separazione netta tra le produzioni del corpo e quelle dello spirito, quindi alla separazione dei due regni della natura e del pensiero, che di primo acchito la dichiarata, clamorosa soppressione di questa differenza ci lascia fortemente stupiti. Questa constatazione mi sembra significativa anche per un altro aspetto: la perdurante distanza tra quelle che sono state definite le “due culture”. Il mio stupore dice della mia colpevole ignoranza dei progressi della scienza e così resto colpito di fronte a conoscenze che sono state certamente e grandemente innovative anni fa, ma che ora, per gli scienziati, penso siano ovvie. Vorrei però anche aggiungere che all’interno della mia sensazione di stupore si è risvegliato il ricordo di un evento di molti anni fa, quando mi capitò di leggere un bellissimo libro di Giacomo Devoto (credo che fosse I dialetti delle regioni d’Italia, Sansoni, Firenze 1972): l’autore, in forza delle sue straordinarie competenze filologiche, ricostruiva i percorsi della progressiva discesa di popolazioni indoeuropee in Italia attraverso le tracce che quei percorsi avevano lasciato nei dialetti delle popolazioni autoctone: lessi e rimasi stupefatto della potenza della scienza filologica. Oggi si potrebbe forse avviare una ricerca parallela sulla base del DNA (credo), ma nel primo caso restavamo all’interno delle scienze dello spirito (il linguaggio ecc.); nel caso di Cavalli-Sforza questa frattura si è colmata e alla meraviglia si aggiunge subito il desiderio di conoscere il come e il perché. La tua presenza è in proposito preziosa e per certi versi insostituibile: ricordo, come è del resto noto, sia la tua collaborazione con Cavalli-Sforza, sia il libro Cavalli-Sforza, Pievani, Homo sapiens. La grande storia della diversità umana, Codice Edizioni, Torino 2016, catalogo della mostra che ebbi la fortuna di poter visitare al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
Bene, veniamo alla promessa citazione della tua, anzi delle tue due pagine iniziali. «Trent’anni fa, da Stanford un genetista italiano si apprestava a rinnovare la sua fama di pioniere. Negli anni Quaranta del Novecento aveva partecipato ai primi studi italiani sulla genetica del moscerino della frutta e poi alle prime scoperte sul sesso nei batteri, cioè lo scambio orizzontale di pacchetti di informazione genetica tra un batterio e l’altro […] Poi era stato tra i primi a insegnare in Italia genetica umana, intuendo che i geni recano con sé non solo informazioni cruciali di valore medico, ma anche preziose tracce della storia umana profonda e degli antichi spostamenti di popolazioni. Non contento, aveva gettato le basi tecniche delle analisi statistiche che oggi si usano in tutti i laboratori del mondo per ricostruire le filogenesi molecolari e computazionali degli esseri viventi. Insofferente tanto alle logiche quanto agli steccati accademici, aveva inaugurato un metodo di lavoro interdisciplinare che univa l’analisi dei gruppi sanguigni, la ricerca di marcatori genetici in popolazioni umane, i registri parrocchiali, la storia demografica, gli alberi genealogici, persino le distribuzioni di cognomi e toponomastiche. Dalla biologia alla cultura, appunto. […] Nel 1971 aveva lasciato l’Italia per insegnare genetica delle popolazioni e delle migrazioni a Stanford, dove aveva assunto la guida di un programma di ricerca mondiale che mirava a ricostruire per via genetica l’albero genealogico dell’umanità. Oggi migliaia di studiosi lavorano sulle spalle di questo gigante. Le analisi sempre più raffinate sulla variabilità umana (prima sul DNA mitocondriale e sul cromosoma Y, poi sull’intero genoma) lo avevano portato a scoprire che la specie Homo sapiens ha avuto un’origine unica, africana e recente, confutando il vecchio modello che prevedeva centri multipli di origine graduale in differenti regioni. La sua idea, poi confermata e precisata, fu che una grande diaspora fuori dall’Africa aveva prodotto, circa 70-60.000 anni fa, il meraviglioso ventaglio delle popolazioni umane attuali, ma anche le culture e le lingue del mondo. Siamo tutti parenti, tutti differenti, e tutti africani» (pp. 91-92).
Aggiungo semplicemente due notazioni, prima di lasciarti la parola. Questa faccenda della statistica certamente riaccende in un filosofo il ricordo del grande Kant, che nei suoi studi di antropologia pragmatica aveva scoperto, tra i primi, appunto le virtù della statistica; per esempio che gli individui, come dire, prendono le loro decisioni, affrontano esperienze che immaginano strettamente personali e singolari, ma la statistica, diceva Kant, li corregge. Essa mostra che il numero annuale dei matrimoni e dei decessi, per esempio, segue una certa linea e proporzione costante, quindi indipendentemente dalle decisioni individuali e dai casi personali contingenti. Dietro l’individuo c’è e si muove una dimensione anonima, una dimensione collettiva, naturale e storica. Ecco quindi la sorprendente connessione tra biologia e storia umana. E, infine, ecco la seconda notazione, che è anche una cosa sulla quale certamente torneremo: come tu dici giustamente, la grandezza di Luigi Luca Cavalli-Sforza è anzitutto nella comprensione che il lavoro scientifico è un lavoro progressivamente e fortemente interdisciplinare, che la conoscenza, diciamo così, è un progetto strutturalmente interconnesso, un progetto che quindi si svolge con una collazione di percorsi, di esperienze, di dati oggettivi, di ipotesi, ecc. Naturalmente per il filosofo questo fatto suscita, come tu sai bene, anche la questione del nesso comune e del fondamento unitario dei “saperi” differenti e collaboranti: dove e come, al di là dell’interdisciplinarità operante, si pone e si affronta il problema di cosa sia il sapere inteso, non come somma di parti, diciamo, ma come unità sistemica e globale della conoscenza? È un po’ quello che facciamo a “Mechrí”, il Laboratorio di filosofia e cultura attivo a Milano già da cinque anni e al quale anche tu hai offerto un prezioso contributo filosofico e scientifico: ci chiediamo se sia possibile delineare un sapere non semplicemente (ovviamente, che sia semplice… si fa per dire!) interdisciplinare, ma, in qualche modo, transdisciplinare, capace di movenze integrative dei saperi, delle loro “pratiche” e dei modelli di formazione che potrebbero forse derivarne.
Pievani: Hai evocato temi che mi sono molto cari. Tra l’altro, per un mio prossimo libro ho ripercorso il De Rerum Natura di Lucrezio e ho ritrovato uno spunto che non ricordavo dai miei studi filosofici: il bellissimo parallelismo tra gli atomi e le lettere, natura e cultura ante litteram, potremmo dire. Ci sono diversi passaggi nel De Rerum Natura in cui Lucrezio sostiene proprio che come la natura è composta da un intricarsi e districarsi di unità elementari, di semina, di primordia – ci sono vari termini che lui usa in latino per «atomo» – così il linguaggio ha nelle lettere i suoi atomi ed è anch’esso un gioco combinatorio di aggregazioni e di disgregazioni. Questa idea piaceva molto a Italo Calvino, che la riprende nelle Lezioni americane. Ma Lucrezio aggiunge un’ulteriore nota, importante: come negli atomi ci sono urti e deviazioni, così anche nel linguaggio può succedere che una mutazione casuale possa cambiare completamente l’area semantica di una parola. Fa l’esempio di lignum, legno, e ignis, fuoco. Basta una elle in più o in meno nella radice di una parola per cambiarne completamente il significato. Credo che lui avesse tratto questa analogia da Aristotele, non era farina del suo sacco, però è molto interessante il fatto che utilizzi questa metafora e che poi aggiunga – anacronisticamente lo dico con il linguaggio di oggi – il concetto di mutazione e di errore generativo. Rileggere Lucrezio mi ha portato a riflettere sul fatto che in fondo l’analogia del linguaggio come codice e poi come mutazione di entità discrete è molto antica nel pensiero occidentale. Se ci pensi, noi fin dall’inizio, dalla scoperta della sua struttura a doppia elica nel 1953, definiamo il DNA proprio come un “linguaggio” scritto con quattro lettere (le basi nucleotidiche), le cui corrispondenze con il linguaggio parallelo degli aminoacidi generano un “codice”, e via di questo passo parliamo di “alfabeto della vita” o di “libro della vita”, spieghiamo le mutazioni genetiche come sostituzioni o aggiunte di lettere nelle parole, che in fondo è esattamente il gioco di lignum e ignis di Lucrezio. Oggi sappiamo che la mutazione genetica è un processo molto simile all’errore di copiatura che l’amanuense introduceva durante il processo di trascrizione di un manoscritto, tanto è vero che lo stesso metodo di ricostruzione degli alberi di discendenza attraverso l’individuazione degli errori-mutazioni si applica sia ai manoscritti medievali sia al DNA. Quindi forse non è soltanto un parallelo metaforico tra due discipline, ma, come tu sostieni, potrebbe essere l’indizio di una connessione più profonda, transdisciplinare.
S.: Qui c’è anche di più. Nella tradizione della scuola atomistica di Democrito si utilizzavano le lettere greche per raffigurare le aggregazioni degli atomi; quindi per esempio NA e AN come caso di due figure aggregative di atomi tra altre figure innumerevoli. Quanto alla faccenda del clinamen reinterpretata in un’accezione biologica attuale mi pare molto stimolante e significativa. In Epicuro aveva in realtà un intento morale: tutto non è mai deciso del tutto. Nella vita c’è sempre una scappatoia possibile per la variabilità del destino e del movimento meccanico degli elementi. Dal punto di vista degli atomisti antichi l’interpretazione di Epicuro sarebbe stata considerata piuttosto un errore, credo. Quindi sotto un profilo “cosmologico” la posizione di Democrito appariva per così dire più “avanzata”. Egli infatti non concepiva, come invece intende Epicuro, la “caduta” degli atomi (e quindi la possibilità di inserire un clinamen), poiché verso dove cadrebbero gli atomi? Questo è un pensiero che sembra piuttosto evocare i “luoghi naturali” di Aristotele. Nel vortice democriteo sono presenti invece tutte le direzioni possibili. Ma resta nondimeno importante che l’intuizione di Epicuro ripresa da Lucrezio torni in altro senso d’attualità nei nostri giorni. D’altra parte la riscoperta del poema di Lucrezio (1417) ha esercitato in generale un’influenza grandissima sulla nascita della scienza moderna.
P.: Certo, Lucrezio ispirò Lavoisier nel 1789, per ammissione dello stesso Lavoisier, nell’elaborazione del principio di conservazione della materia. Anche i fisici lo hanno ripreso. Heisenberg citava Lucrezio come esempio della prima intuizione circa l’indeterminismo quantistico. Ovviamente qui si corrono molti rischi di anacronismo storico e di accostamenti indebiti, come anche Einstein aveva ammonito, ma è pur vero che la dinamica della scoperta scientifica non è soltanto logica e razionale. Nel processo di elaborazione di una teoria, la creatività dello scienziato attinge a fonti di ispirazione spesso esterne alla scienza, che lo aiutano a trovare la metafora rivelatrice, lo schema interpretativo iniziale che poi tradurrà in termini tecnici e formali quando la teoria viene costruita, giustificata e difesa. La scoperta scientifica è un momento aurorale in cui secondo me, di nuovo, la transdisciplinarità ha un ruolo. Tornando a Cavalli-Sforza, lavorando con Luca imparavi subito che per lui, nel suo lavoro di scienziato, non c’erano steccati disciplinari definiti in un senso preciso. Era rigorosissimo nella fase sperimentale e, appunto, nell’analisi statistica. Non transigeva. Quando le prime volte gli dicevo che io ero un filosofo della scienza, mi guardava con un certo sospetto, temeva fumosità. Poi si accorse che in biologia evoluzionistica avevo avuto buoni maestri a New York e che me la cavavo quel tanto che bastava in genetica, e tutto andò bene. A quel punto divenni un suo alleato nella transdisciplinarità, che per lui aveva un valore euristico. A Cavalli-Sforza interessava capire se una regolarità riscontrata in un certo campo, per esempio le comparazioni genetiche e l’orologio molecolare, potesse essere di ispirazione per scoprire qualcosa di interessante in un campo diverso, per esempio la linguistica e la glottocronologia. La compenetrazione tra discipline aveva per lui in primo luogo questo valore euristico, di indagine, di costruzione di buone domande di ricerca. In questo era molto ottocentesco e darwiniano. Anche Darwin non era per nulla appassionato agli steccati disciplin...