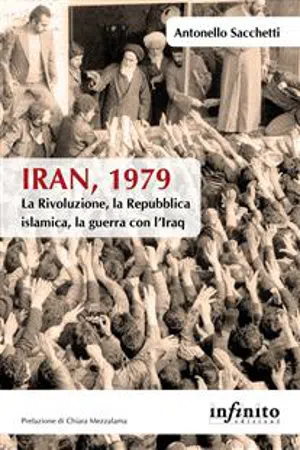«Fino allo scoppio della guerra, la rivoluzione è stata una cosa, dopo è stata un’altra». Non ha dubbi Massud, quando si arriva al passaggio cruciale della storia che stiamo ricostruendo. E cambia anche il tono con cui affronta il ricordo di quel momento: «Nel gennaio del 1980 l’elezione di Bani Sadr fu davvero partecipata, divenne presidente con un numero altissimo di voti. Ma le sue idee di democrazia e partecipazione non coincidevano, dopo la guerra, con quelle di Khomeini. Personalmente imputo alla guerra la svolta verso la teocrazia, molto violenta all’inizio. La guerra ha dato adito a quelli che erano a capo del governo di impostare le relazioni tra “o sei con noi o contro di noi”».
Saddam attacca
Il 22 settembre 1980 Saddam Hussein invase l’Iran, dando inizio a una guerra che terminerà soltanto nel luglio del 1988. La scintilla, il pretesto, fu l’annosa questione del diritto di navigazione di un fiume, chiamato Shatt al Arab dagli iracheni e Arvand Rud dagli iraniani, che sfocia nel Golfo Persico. La questione era stata regolata dal trattato di Algeri, siglato nel 1975 dal predecessore di Saddam Hussein, Ahmad Ali Hasan al-Bakr e dallo scià Mohammad Reza Pahlavi. Saddam Hussein, all’epoca vicepresidente iracheno, compare nelle foto ufficiali accanto allo scià iraniano. Perché cinque anni dopo, diventato leader assoluto del partito Baath e del Paese, decise di avventurarsi in un conflitto che si sarebbe rivelato lunghissimo e catastrofico?
Saddam cambiò quando, mirando a divenire leader del mondo arabo, pensò di trovare a est lo sbocco naturale per le sue ambizioni espansionistiche. Non si trattava tanto di annettere nuovi territori, ma di conquistare autorevolezza e rispetto dagli altri Paesi arabi. E per fare questo, Saddam aveva due possibili nemici da attaccare: Israele e Iran. Troppo rischioso un confronto diretto col primo, vista la netta supremazia militare di Tel Aviv. Più fattibile lo scontro col secondo, visto il caos evidente in cui versavano le forze armate iraniane dopo la rivoluzione e ancora di più dopo il repulisti operato dal regime all’indomani del fallito golpe del luglio 1980. Non solo: Saddam puntava ad annettere all’Iraq il Khuzestan, la provincia sudorientale dell’Iran, ricchissima di petrolio, che il regime iracheno chiamava Arabistan, in virtù dei tanti abitanti (circa il 40 per cento) che parlavano un dialetto arabo. All’indomani della rivoluzione, in Khuzestan era sorto un movimento secessionista chiamato Jibhat al-Tahrir (Fronte di liberazione), finanziato dall’Iraq, che non ebbe però grande seguito, neppure tra i sunniti locali. All’inizio del 1979, il Fronte avanzò tre richieste al nuovo governo rivoluzionario di Teheran: adozione dell’arabo come lingua ufficiale nella provincia, utilizzo privilegiato dei proventi dell’export del petrolio e un governo autoctono di membri che parlassero arabo. Il confronto col governo provvisorio andò avanti per mesi, perché Teheran non aveva alcuna intenzione di cedere alle pressioni autonomiste. Il 29 maggio 1979 la tensione sfociò in un confronto armato a Khorramshahr tra esercito e forze ribelli, con almeno venticinque morti. La Repubblica islamica, al pari del vecchio regime monarchico, puntava a uno Stato centralizzato.
Saddam, dal canto suo, temeva anche che la rivoluzione iraniana divenisse un modello per gli sciiti iracheni che nel 1977, guidati dal partito Da’wa, erano insorti a Najaf. Il regime baathista aveva represso nel sangue quella sollevazione, ma il successo di Khomeini in Iran era fonte di allarme per Saddam. Nella primavera del 1980 aveva perciò scatenato una feroce repressione nei confronti del Da’wa, impiccandone il leader più noto, Muhammad Baqir al-Sadr, un teologo molto noto e rispettato, e arrestando, torturando e uccidendo molti militanti. Khomeini aveva trascorso molti anni in esilio a Najaf, dove il clero sciita lo seguiva con un misto di ammirazione e ansia: la teoria del velayat-e faqih non aveva grande presa né presso la maggioranza dei religiosi né sulla popolazione. Come si vedrà durante il conflitto, gli sciiti iracheni combatterono nell’esercito del loro Paese contro i confratelli sciiti iraniani: l’appartenenza nazionale si rivelerà più importante di quella religiosa.
Convinto di poter avere rapidamente la meglio sul disastrato esercito iraniano, Saddam si preparò alla guerra già dal luglio 1980. Una settimana dopo la morte dello scià al Cairo, il presidente iracheno tenne un discorso in televisione in cui denunciava gli accordi di Algeri e rivendicava per l’Iraq l’intero corso dello Shatt al Arab. In questo modo, Baghdad avrebbe avuto un accesso strategicamente vantaggioso al Golfo Persico, a totale discapito dell’Iran. Con questi obiettivi, il 22 settembre scatenò l’operazione Qadisiya, dal nome della battaglia che nel 630 determinò la vittoria delle truppe arabe islamiche sui sasanidi persiani. La propaganda irachena giocò anche la carta religiosa e nazionalista, incitando a più riprese alla guerra contro gli ajam (termine dispregiativo che si riferisce ai non arabi e ai persiani in particolare), “i falsi musulmani sciiti”, gli “zoroastriani”. Aerei iracheni bombardarono subito l’aeroporto di Mehrabad di Teheran e diverse basi aeree iraniane. Contemporaneamente, truppe di fanteria e corpi anfibi attraversarono il fiume della discordia e invasero la provincia del Khuzestan. Nonostante le avvisaglie ormai in corso da mesi, l’Iran si fece cogliere totalmente impreparato a respingere l’aggressione. All’inizio del conflitto, il rapporto di forze era nettamente a favore di Baghdad che poteva contare su un esercito di duecentomila uomini, dotato di carri armati moderni e mezzi di trasporto corazzati. L’esercito iraniano invece era ridotto a meno di 160.000 effettivi, mentre prima della rivoluzione erano 285.000. Mancavano inoltre pezzi di ricambio per l’artiglieria e molti equipaggiamenti erano fuori uso. L’Iran era invece più forte nell’aviazione, potendo contare su 450 aerei, contro i 340 dell’Iraq. Nonostante la riduzione del personale – dovuta anche in questo caso alle purghe post-rivoluzione – poteva vantare anche un migliore addestramento. I piloti iraniani, infatti, all’epoca dello scià erano stati preparati da tecnici americani, mentre gli iracheni avevano avuto per lo più istruttori sovietici. La situazione cambiò in parte negli anni successivi, quando l’Iraq ricevette aerei e addestramento dalla Francia.
La città di Abadan, sede delle principali raffinerie del Paese, venne gravemente danneggiata dai bombardamenti, con ripercussioni molto gravi per l’economia dell’Iran. Gli iracheni presero possesso delle alture della catena dello Zagros, del Luristan e del Kurdistan, assicurandosi un vantaggio strategico fondamentale. Per l’Iran il primo colpo fu terribile, ma nell’arco di pochi giorni le truppe di Saddam incontrarono una resistenza inaspettata. L’Iraq credeva che, soprattutto nel Khuzestan, la minoranza araba si sarebbe schierata con gli invasori e che, in generale, il popolo iraniano non avrebbe reagito con tanto vigore. C’è un episodio che, forse meglio di molti altri, spiega il sentimento con cui gli iraniani affrontarono quella che presto venne ribattezzata “guerra imposta” ( jang-e tahmili). L’Iran, da un punto di vista militare, era in particolare sofferenza con l’Iraq in campo aereo, dopo le purghe dei mesi precedenti. Moltissimi ufficiali erano in carcere da luglio. Il presidente Bani Sadr propose loro di combattere in cambio della liberazione. Gli ufficiali accettarono a condizione che alla radio venisse trasmesso il vecchio inno imperiale, messo al bando dopo la rivoluzione. E così, il 24 settembre, gli iraniani rimasero di stucco nell’ascoltare quell’inno che non si eseguiva più da oltre un anno, mentre centoquaranta caccia iraniani bombardavano Baghdad. Fu la prima reazione iraniana in territorio iracheno, ma a un prezzo altissimo: la metà di quegli aerei non tornarono alla base.
La reazione iraniana
Nel giro di poche settimane, gli iraniani seppero ricompattarsi e opporre una degna resistenza all’invasore. Fu determinante l’apporto dei volontari, e dei pasdaran in particolare. Accanto – o, meglio, al di sotto dei pasdaran – dall’aprile del 1980 c’erano anche i basij, ( Nirouy-e moqavemat-e basij, Forza di resistenza di mobilitazione), milizia composta inizialmente da uomini ancora troppo giovani o troppo anziani per il servizio militare regolare. Col tempo i basij diventarono una forza ausiliaria, svolgendo nella guerra contro l’Iraq un ruolo fondamentale.
Guerra che divenne presto “per la sacra difesa” ( defa’-e moqaddas) e si rivelò, per Khomeini e la Repubblica islamica, un’opportunità inattesa. Si tratta di un tema che, a distanza di tanti anni, andrebbe affrontato sgomberando il campo da molta retorica e da una serie di luoghi comuni creati spesso dalla propaganda, tenendo comunque sempre presente che fu e rimane un dramma che ha interessato e interessa tuttora milioni di persone.
Non c’è dubbio: per gli iraniani si trattò davvero di una “guerra imposta” dall’invasore iracheno. Rimane emblematico un episodio che ebbe per protagonista l’allora ministro degli Esteri italiano Giulio Andreotti, che anni dopo lo ricordò così: «Durante la guerra Iraq-Iran ci trovammo di turno nel Consiglio di sicurezza dove il favore per il nemico di Khomeini era prevalente. Una certa equidistanza italo-tedesca-giapponese era vista male. Ricordo che fuori seduta troncai la proposta di una commissione di inchiesta sulla responsabilità della guerra, con relative spese per la commissione stessa (gli aspetti burocratici sono inesorabili). Bastava acquistare con mezzo dollaro un numero arretrato del New York Times con il testo del proclama con cui Saddam aveva iniziato le ostilità» .
È però altrettanto vero che da subito Teheran rifiutò qualsiasi tentativo di mediazione che non implicasse una quanto mai improbabile rinuncia al potere da parte di Saddam Hussein. Indubbiamente l’Iran era la parte aggredita, ma il conflitto si sarebbe potuto contenere o gestire in altro modo se non fossero intervenuti fattori interni alla situazione politica iraniana che vedremo più avanti. Quello che la guerra comportò immediatamente, fu un ulteriore isolamento internazionale dell’Iran. Sarebbe però una forzatura affermare – come sostiene qualcuno – che Saddam attaccò l’Iran su mandato degli Stati Uniti. Non tanto perché gli Usa non fossero in contrasto con l’Iran rivoluzionario (la crisi degli ostaggi era in corso da quasi un anno), ma perché anche l’Iraq di Saddam Hussein era in quel momento considerato da Washington un nemico, soprattutto per la minaccia che rappresentava per Israele.
Nei mesi convulsi che seguirono la fuga dello scià, avvenne però un passaggio molto importante e poco ricordato. Nell’agosto del 1979 il capo del governo provvisorio iraniano Mehdi Bazargan decise di annullare tutti i contratti di acquisto di armi dagli Stati Uniti per cercare di limitare i danni provocati dal crollo delle vendite del petrolio dopo la rivoluzione. Secondo i consiglieri di Bazargan, le colossali spese dello scià avevano dotato l’esercito di un equipaggiamento moderno a sufficienza. La decisione mandò in fumo contratti per dieci miliardi di dollari, facendo imbestialire la lobby dei produttori di armi statunitensi. Di conseguenza, il Congresso Usa pose l’embargo sull’invio dei pezzi di ricambio per l’equipaggiamento precedentemente acquistato. Fu una decisione che si sarebbe rivelata decisiva sia per i rapporti tra Washington e Teheran sia per il progressivo invecchiamento dell’arsenale iraniano.
La guerra durò otto anni, anche se è doveroso precisare che ci furono intervalli anche piuttosto lunghi in cui le due parti si preparavano a nuove offensive. Una durata così lunga fu possibile essenzialmente perché sia l’Iran che l’Iraq potevano contare sui finanziamenti provenienti dall’industria petrolifera. Di più: erano due economie che si reggevano quasi esclusivamente sull’export di petrolio. Nello specifico, l’Iraq ottenne prestiti enormi proprio utilizzando la futura produzione di petrolio come garanzia. E per questo arrivò alla fine del conflitto indebitato in modo pauroso. Nessuno dei due poteva permettersi di perdere la propria industria petrolifera. Per questo motivo si creò di fatto uno stallo: perché spingendo oltre, rischiando il tutto per tutto, non c’era solo il pericolo di perdere il conflitto, ma di suicidarsi come regime.
Il Paese che fu da subito partner dei propositi di Saddam Hussein è la Francia. L’Unione Sovietica era sì un alleato militare di Baghdad, ma non aveva accesso diretto alle basi irachene. I francesi erano gli unici a poter fornire all’Iraq tutto ciò di cui aveva bisogno: stretta cooperazione nel settore petrolifero, assistenza su larga scala per l’energia nucleare civile e armi moderni. Per tutta la durata del conflitto, la Francia sarà sempre molto vicina a Saddam Hussein e questo comporterà diversi momenti di crisi con Teheran.
L’Iraq contava sull’effetto sorpresa e indubbiamente la prima fase della guerra fu a suo netto vantaggio. Bani Sadr si calò nel ruolo di comandante delle forze armate, trascorrendo molto tempo al fronte, anche per allontanarsi dalle polemiche e dagli intrighi di potere di Teheran. A fine novembre l’Iran aveva disposto sul fronte sud-occidentale circa duecentomila soldati delle forze regolari e altri centomila volontari. L’obiettivo era colpire le basi petrolifere irachene della penisola di Faw. La controffensiva iraniana scattò nel gennaio del 1981 con la battaglia di Susangerd. Gli iraniani scatenarono un attacco su vasta scala ma gli iracheni, dopo un’iniziale ritirata tattica, contennero l’avanzata dei nemici infliggendo loro perdite molto pesanti. Dopo questa battaglia, il conflitto si cristallizzò in una lunga e sanguinosa guerra di posizione simile, in alcune dinamiche, alla prima guerra mondiale combattuta in Europa settant’anni prima. Gli iraniani, per sbloccare lo stallo, ricorrevano alle “ondate umane” di volontari che si precipitavano all’assalto delle trincee nemiche, finendo per essere uccisi dalle mine o dall’artiglieria. Non mancarono azioni militari molto efficaci, come il blitz con cui, il 4 aprile 1981, otto F-4 Phantom iraniani piombarono a sorpresa sulla base di Al Walid, vicino alla frontiera irachena con la Giordania, e distrussero almeno una trentina di aerei, tra cui due Mirage appena arrivati dalla Francia. Saddam Hussein, furibondo per lo smacco subìto, fece fucilare sei alti ufficiali dell’aeronautica.
Ripercussioni interne della guerra
Lo stallo della guerra venne comunque addossato da Khomeini e dalla sua fazione a Bani Sadr, che divenne presto anche molto impopolare tra gli iraniani. Il presidente venne accusato di essere “un altro Bazargan con una faccia diversa”, troppo morbido sulla questione degli ostaggi e incapace come comandante militare. Messo costantemente sotto tiro dal partito di Khomeini, Bani Sadr finì per avvicinarsi sempre più ai Mojaheddin-e Khalq, ancora tollerati sebbene in rotta col potere clericale.
Nel gennaio del 1981 si arrivò finalmente a una soluzione della crisi degli ostaggi Usa. Il 19 gennaio venne siglato un accordo ad Algeri, raggiunto grazie alla mediazione del governo algerino. L’intesa prevedeva la liberazione degli ostaggi, lo scongelamento dei fondi iraniani depositati presso banche americane e bloccati all’indomani dello scoppio della crisi e la riaffermazione del principio di non ingerenza da parte Usa nella politica interna iraniana. In realtà, gli Stati Uniti scongelarono soltanto 2,3 miliardi di dollari, trattenendone altri 7,7 miliardi. Esiste in merito la cosiddetta teoria della “sorpresa di ottobre”: il 4 novembre 1980 si votava per le presidenziali Usa e il presidente uscente, il democratico Carter, era sfidato dal repubblicano Ronald Reagan. Voci mai confermate sostennero che membri dello staff di Reagan intervennero nella trattativa con l’Iran, per fare in modo che gli ostaggi venissero rilasciati soltanto dopo le elezioni, in modo da non favorire Carter, che proprio sulla crisi degli ostaggi aveva perso molta della sua popolarità. In cambio, gli americani si sarebbero impegnati, una volta che Reagan avesse vinto le elezioni, a rifornire l’Iran delle armi di cui aveva bisogno nella guerra da poco scoppiata con l’Iraq. Le elezioni le vinse Reagan alla grande. Khomeini, che voleva umiliare Carter, fece liberare gli ostaggi soltanto il 20 gennaio, proprio mentre a Washington era in corso la cerimonia di insediamento del nuovo presidente.
Il 5 marzo 1981, anniversario della morte di Mossadeq, Bani Sadr tenne un discorso all’Università di Teheran a cui parteciparono centomila persone. Gruppi armati di sostenitori di Khomeini intervennero per disturbare la manifestazione e arrivarono allo scontro fisico con militanti del Fronte nazionale e dei Mojaheddin-e Khalq provocando la morte di quattro persone e il ferimento di un centinaio. In quell’occasione Ali Khamenei, riferendosi al golpe del Cile del 1973, disse: «L’America non si illuda. Noi non siamo liberali, come Allende, disposti a essere fatti fuori dalla Cia». Fu l’inizio della fine per il primo presidente della Repubblica islamica. Il parlamento si opponeva a qualsiasi sua decisione, di fatto impedendogli di governare. Di base, la sua interpretazione del nuovo ordine islamico era ritenuta troppo liberale e tollerante. Bani Sadr avanzò l’idea di un referendum che facesse scegliere al popolo tra lui e il majles. Il 6 giugno il ministero degli Interni ordinò la chiusura degli uffici del presidente, che venne for...