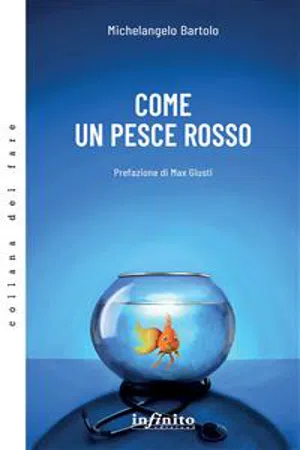Al
mattino chiamo Maria Pia, il direttore del Pronto Soccorso; espongo
con termini medici eruditi la mia situazione clinica e concordiamo
sul da farsi. Il problema, però, è come andare in ospedale. Essendo
positivo e sintomatico io non potrei uscire di casa e per andare in
ospedale dovrei chiamare un’ambulanza. Ma se chiamassi l’ambulanza,
poi non mi porterebbero di certo all’ospedale dove lavoro.
Ovviamente, per rispettare il distanziamento, nessuno dei miei
familiari mi può accompagnare. Decido quindi di andare in macchina;
mi “tachipirizzo”, mi sento meglio e ce la faccio a guidare.
“Mi raccomando – aggiunge il direttore del Pronto Soccorso –,
se ti fermano, non dire per nessun motivo che sei positivo, sennò
ti arrestano”.
“Se è per quello, ho anche la patente scaduta da tre giorni”,
aggiungo per sdrammatizzare.
D’altra parte, andare in macchina è l’unico modo per avere
accesso al Pronto Soccorso in tempi rapidi. Sono i giorni di
massima presa d’assalto degli ospedali. Tutto il presidio di
accettazione dell’emergenza, mi ha detto Maria Pia, è strapieno e
ci sono già una cinquantina di pazienti Covid che non sanno più
dove collocare. Stare in macchina mi avrebbe garantito un luogo
isolato e sicuro dove poter attendere.
Al semaforo, quello eterno di viale Trastevere, si avvicina
Nando, chiede l’elemosina da anni e ormai ci conosciamo. Mi
riconosce e mi viene incontro sorridendo; attende che io gli dia
qualcosa, ma non lo degno neanche di uno sguardo. È stupito della
mia inusuale indifferenza, bussa sul finestrino e fa roteare la
mano a pugno come se dovessi girare la manovella per aprire il
vetro. Gli faccio cenno che non ho niente da dargli, ma lui
insiste. Senza proferire parola, con un gesto deciso della mano,
gli faccio capire che deve andarsene. Lui rimane ancora qualche
secondo a guardarmi poi, biascicando parole incomprensibili, se ne
va. Mi spiace essere così brusco, proprio con Nando, ma come
spiegargli la mia situazione in pochi secondi? Non posso certo
dargli dei soldi toccati da me, la prudenza non è mai troppa. Ho
letto su uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità che il
Coronavirus resiste sulle monete per più di un’ora e sulle
banconote anche fino a due giorni.
Arrivo al parcheggio del Pronto Soccorso e avviso Maria Pia
della mia presenza.
Faccio l’accettazione inviando i miei dati all’infermiera del
triage tramite WhatsApp, alla faccia del garante della privacy che
vieta di usare questo applicativo per inviare dati sanitari. Voglio
vedere se si trovasse lui nella mia situazione, come chiuderebbe un
occhio sulla normativa. Poco dopo, faccio i prelievi tipo
drive in con il braccio fuori dal finestrino, mi
posizionano un’ago cannula in vena e dal suo collettore, attraverso
una campana, riempiono una manciata di provette. Segue poi il
prelievo più doloroso, quello dall’arteria radiale per l’emogas
analisi, l’esame che più di tutti restituisce informazioni sul
grado di insufficienza respiratoria. Il prelievo, lo so bene, è
particolarmente doloroso; si fa pungendo un’arteria e quindi non si
usa il laccio emostatico. L’ago deve entrare nell’arteria che viene
localizzata sentendo le sue pulsazioni al tatto. Non sempre la si
trova al primo tentativo e in questi casi non bisogna uscire e
ritentare un altro buco ma, come diciamo in gergo, bisogna
“smucinare”. E l’infermiera “smucìna”, eccome se “smucìna”: a
destra, a sinistra, più in alto, più in basso finché, finalmente,
lo zampillo di sangue rosso vivo appare nella siringa. Garza,
cerotto e mi riapproprio del mio braccio dolorante. Chiudo il
finestrino e riaccendo l’autoradio:
Il ruggito del coniglio, su
Radio 2 Rai, riesce sempre, nonostante tutto, a mettermi
di buon umore.
Verso le tredici, arriva un collega che sosteneva di conoscermi
e io, ovviamente, fingo altrettanto. A me il suo nome non dice
nulla e non posso nemmeno confidare sul riconoscimento della sua
fisionomia occultata dai presìdi di protezione sanitaria: tuta
bianca, cappuccio, mascherina FFP2 e copri occhiali.
Mi fa cenno di aprire uno spiraglio del finestrino e mi
consegna copia degli esami appena sfornati: “Guardateli, torno tra
poco”.
Esamino subito i risultati dell’emogas analisi. Cazzo!
L’ossigeno è basso: 63 mmHg. Imposto la calcolatrice sul
telefonino, incrocio una serie di altri parametri e la diagnosi
impietosa è un numero che mi colloca a metà tra l’insufficienza
respiratoria media e grave. Fantastico. È chiaro che ho una
polmonite. Gli altri esami non sono tremendi: la PCR è elevata ma
mi sembra il minimo, l’emocromo non è male e non ho leucocitosi, il
D-Dimero è nella norma, segno che non ho microtrombosi polmonare
che talvolta si associa al Covid-19. Anche gli elettroliti sono
quasi tutti nella norma, a eccezione del sodio, che è
particolarmente basso; forse è per questo che stanotte ho avuto
quella pseudo allucinazione, sempre che sia stata tale.
Si riavvicina il collega.
“Che vogliamo fare?”.
“Direi che una TAC me la merito, tu che dici?”, rispondo al
collega sconosciuto che però mi conosce.
“Ok, ti richiedo una TAC del torace. Ma la vuoi fare con mezzo
di contrasto?”, aggiunge con la stessa intonazione di voce di un
cameriere che ti chiede se sulla cicoria gradisci un po’ di
peperoncino.
Rimango perplesso.
“Ma per vedere una polmonite serve il mezzo di contrasto?”,
chiedo dubbioso.
“No, ma visto che sei un collega…”.
“Grazie del pensiero, ma trattami come un normale
paziente”.
“Ok, allora facciamo una TAC… liscia”, mi replica sghignazzando
per la battuta.
“Unico problema – aggiunge – è che non ho ancora nessun posto
dove farti stare. Te la senti di aspettare ancora in
macchina?”.
“Sì certo, va benissimo, ma per favore portatemi un
pappagallo”.
Il collega gira i tacchi e mi assicura che mi avrebbe fatto
recapitare un pitale da lì a poco.
Ma se escono liquidi, dovrei anche farli rientrare e realizzo
in questo momento che non mi sono portato nulla da bere.
Chiamo gli infermieri del mio reparto di Telemedicina e chiedo
loro di portarmi una bottiglietta di acqua e, visto che ci siamo,
anche un panino. La richiesta dà la stura a una serie di
interminabili scambi WhatsApp, che questa volta si possono fare
senza violare le direttive del Garante della Privacy, forse. “Acqua
frizzante? Liscia? Leggermente frizzante? Vuoi anche il caffè?
Panino con formaggio? O preferisci mozzarella e pomodoro,
oppure…”.
Rispondo a stento e in maniera didascalica. Capisco la premura
dei miei infermieri, li ringrazio e delego loro, per questa volta,
la più ampia autonomia. Poco dopo si materializza davanti al
cruscotto Manuela, esperta di Home Monitoring, che dopo qualche
convenevole mi lancia il malloppo dal finestrino posteriore.
Inizia a imbrunire e ancora nessuno mi chiama per la TAC. So
bene che in radiologia aspettano che si raggiungano almeno
cinque-sei pazienti Covid positivi per far fare loro l’esame
radiologico uno dietro l’altro, in modo da dover sanificare una
sola volta la macchina.
In ogni Pronto Soccorso ci sono tempi tecnici che più di tanto
non si possono accorciare. È qualcosa che talvolta il paziente
medio fa fatica a comprendere. Nel mio caso, sarebbero stati
portati a pensare che si fossero dimenticati di loro, e magari
avrebbero cominciato a chiedere il perché di tanta attesa.
Verso le sei della sera, in pieno buio, mi chiamano. Ricevo la
precisa indicazione di seguire un infermiere vestito da astronauta
che, facendo cenno alle persone di spostarsi e non avvicinarsi, mi
traghetta in radiologia. Mi ricorda quanto è scritto nel libro del
Levitico, dove per cercare di limitare l’epidemia da lebbra, chi ne
era colpito doveva girare gridando: “Immondo! Immondo!”. Oggi
diremmo: “Distanziamento! Distanziamento!”.
In fondo, il Coronavirus si trasmette in modo non tanto
dissimile dal Mycobacterium Leprae, solo che quest’ultimo è
curabile e il Covid, oltre a essere decisamente molto più
contagioso, non ha terapia.
Dopo l’esame radiologico rientro in macchina e poco dopo un
altro referto mi viene consegnato attraverso il finestrino, quasi
fosse una multa dei carabinieri.
Apro il foglio A4 e leggo il responso con molta più apprensione
di un verbale delle forze dell’ordine: “Polmonite bilaterale con
interessamento del 45 per cento del parenchima. Non versamento
pleurico, né pericardico”.
Poteva andare meglio, ma anche molto peggio, penso.
Alle sette della sera mi trovano un posto nel container
dedicato ai pazienti Covid. Parcheggio alla meno peggio la macchina
e mi faccio barellare verso l’area dei pazienti in isolamento.
Inizio subito cortisone endovena a dosi piene, un antibiotico e
ossigeno.
Dal container mando notizie a familiari e amici della mia
situazione. Mi accorgo plasticamente che faccio fatica a parlare al
telefono; la chiamata per tranquillizzare mia moglie ha l’effetto
opposto.
Arriva Maurizio, il medico del reparto Pneumo Covid 2, quello
che nei giorni precedenti mi aveva quasi fatto da badante e mi
aveva insegnato moltissime cose.
“Guarda che cazzo ti sei inventato per non venire a lavorare!”,
è il suo incipit.
Gli rispondo con una smorfia di sorriso.
“E ora concentrati, ti faccio vedere la TAC”, incalza.
Si mette al pc, gira il monitor verso la finestra chiusa della
mia postazione di isolamento e inizia a far scorrere le immagini
dei miei polmoni.
“Guarda, qui tutto bene, ma dal lobo medio in giù,
bilateralmente, sei pieno, vedi? Ehi, non ti distrarre, guarda
bene!”, mi apostrofa accorgendosi che avevo virato l’occhio verso
il telefonino.
“In trasversale – riprende – si vede chiaramente che dietro non
ventili; sei stato troppo a letto e ti sei fottuto la parte
posteriore dei polmoni. La cosa buona è che non hai versamento
pleurico, strano… Certo che con te il virus si è divertito…”.
“E quindi…?”, chiedo al collega, che aveva ormai dismesso le
vesti di maestro.
“Senti, noi ora siamo pieni – mi risponde – ma credo che entro
stanotte o al massimo domani mattina un posticino si liberi, a meno
che non preferisci essere ricoverato in un altro reparto”.
“Fantastico” è l’unica cosa che riesco a dire.
So bene che vuol dire che si sta liberando un posto; ci deve
essere qualche paziente in insufficienza respiratoria acuta, forse
intubato, che non risponde più alle cure e che probabilmente non ce
la farà.
“Sì, va bene, il nostro, anzi il vostro reparto va benissimo”,
gli rispondo sottolineando così che io sono un medico della
Telemedicina prestato “temporaneamente” al reparto Pneumo Covid
2.
“Ma, per favore, non mi mettere in sub intensiva”,
aggiungo.
“Tranquillo, ci penso io. Quando si libera quel posticino,
faccio spostare un altro paziente in sub intensiva e tu vai in una
stanza di degenza normale. Intanto ti stampo le tue ultime analisi,
così ti studi qualcosa”.
Mi prendo la nuova stampata delle analisi; faccio rapidi
calcoli. L’ossigeno mi fa stare molto meglio ma… rispetto a
stamattina sto peggiorando.
Mi riaccuccio sulla barella a pancia in giù, per favorire, come
mi ha ricordato il mio collega Maurizio, la ventilazione.
“Devi far finta di essere una frittella in padella e girarti di
continuo”, mi aveva detto. E io obbedisco. Mi giro, rigiro e
attendo che il posto si “liberi”.
Rimango nel box del container. Non si sta mica male, ho anche
un mini bagno tutto per me e c’è perfino l’acqua calda. Poco dopo,
altri milligrammi di cortisone sparati in vena mi fanno scomparire
la febbre.
Provo un po’ a riposarmi sulla lettiga e la mente inizia a
spaziare in libertà.
Soltanto una settimana fa, vedendo TAC simili di pazienti
ricoverati, commentavamo che il quadro non era roseo e che
bisognava solo capire se la polmonite era in fase di consolidamento
o di accrescimento. Leggendo il referto e rielaborando mentalmente
le immagini dei miei polmoni non mi è dato di capire in quale fase
mi trovi. Mi rendo conto che questo sapere tutto, ma proprio tutto,
è soltanto fonte di ulteriore preoccupazione.
Quanto vorrei, adesso, essere trattato come un normale malato
che si affida alle scarne parole del medico che magari, anche se ti
sentenzia una polmonite, ti incoraggia dicendoti che si può curare
e che è più prudente fare qualche giorno di ricovero.
E invece no. Il dito del collega spaziava sul monitor
evidenziando ogni zona più chiara del polmone, che in gergo
definiamo a “vetro smerigliato”, dove gli alveoli hanno smesso di
funzionare e commentando le immagini con eruditi vocaboli che a
tratti non capivo o non volevo capire.
A mezzanotte, puntuale come Cenerentola, ho il semaforo verde
per andare nel reparto. Ci arrivo camminando scortato da un altro
infermiere che questa volta, con i corridoi deserti, non deve far
allontanare nessuno.
Fuori dal reparto staziona la lettiga mortuaria che
probabilmente contiene colui che mi ha gentilmente ceduto il posto.
Ringrazio sentitamente, come quando al ristorante occupi un tavolo
appena liberato, ed entro nel reparto Pneumo Covid 2 per la prima
volta senza indossare i presìdi di protezione: nessun guanto,
visiera, copri scarpe, tuta, nulla. Percorro il reparto, nella
parte sporca, senza più bisogno di fare attenzione a cosa toccare.
Posso muovermi liberamente. Sono soddisfazioni.
La stanza a me destinata ha quattro posti; accanto a me, un
ragazzo del Bangladesh. Ha la maschera NIV
che è praticamente l’ultima spiaggia
prima dell’intubazione ma lui, per fortuna, non lo sa. Ovviamente
non può parlare e a giudicare dalla maschera quasi appannata deve
vederci anche pochino. Istintivamente, anche se da paziente non
dovrei farlo, do un’occhiata al display del ventilatore. Non va per
niente bene.
Mi rendo conto che, anche se è stata un’azione automatica,
spontanea, non dovrei andare a sbirciare i monitors degli altri
pazienti suscitando, tra l’altro, preoccupazione nell’infermiera
che mi accompagnava.
“Attenzione al nuovo malato – avrà detto alle sue colleghe,
raccontando loro l’accaduto –, non dev’essere un tipo normale”.
Ora sono un paziente, non più un medico, e devo fare soltanto
il malato. Ma scindere le due personalità, fortunatamente o
malauguratamente, è impossibile.
Mi impossesso del mio letto, il numero 25, e provo, coccolato
dall’ossigeno che avvolge bocca a narici, a prender sonno.