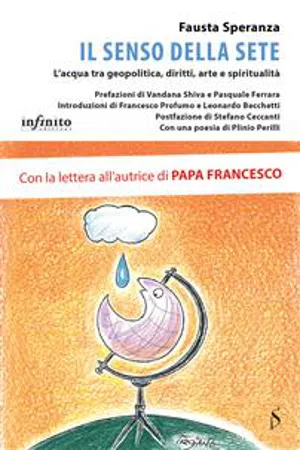“ Le malvagità degli uomini vivono nel bronzo, le loro virtù le scriviamo sull’acqua ”
(Shakespeare)
L’acqua è semplice e chiara nella sua costituzione fluida, tradizionalmente legata a un significato di rigenerazione spirituale, così come nella realtà fisica vi sono fonti che hanno proprietà terapeutiche per il corpo. Ma la sua grande massa consente una penetrabilità di luce solo parziale e suggerisce una forza incontrollabile. Mitologicamente è patria di ninfe, sirene e altre bellissime creature femminili, ed è fonte di vita, sensualità, femminilità e giovinezza. Quando si trasforma in tempesta, diventa presagio di oscurità e di negatività. La potenza del mare in burrasca o del fiume che straripa dagli argini diventa metafora delle forze dell’inconscio che minacciano l’equilibrio della dimensione profonda dell’io. L’acqua, come in una perfetta circolarità, può rappresentare tutto e il contrario di tutto: vita e morte, serenità e follia.
Lo scrittore contemporaneo statunitense Arthur Golden scrive: “L’acqua non aspetta mai. Cambia forma e scorre attorno alle cose, trovando sentieri segreti a cui nessun altro ha pensato: un pertugio nel tetto o un piccolo buco in fondo a una scatola. Senza alcun dubbio è il più versatile dei cinque elementi. Può dilavare la terra, spegnere il fuoco, far arrugginire un pezzo di metallo e consumarlo. Persino il legno, che è il suo complemento naturale, non può sopravvivere se non viene nutrito dall’acqua”.
Omero e l’archetipo di Ulisse
“ Cambiano cielo, non animo, coloro che corrono al di là del mare”
Tra i miti più fortunati di tutti i tempi c’è quello di Odisseo, che in virtù del suo girovagare per mare racconta qualcosa del viaggio della vita di ciascuno di noi. Originario di Itaca, detta la terra del sole, è uno degli eroi achei descritti e narrati da Omero nell’ Iliade e nell’ Odissea , che da lui prende il nome. Ulisse è l’epiteto – il cui significato è “ferito a un’anca” – datogli dai Romani, reso celebre da Livio Andronico. Ed è l’appellativo rimasto più celebre. Dunque, Ulisse/Odisseo vorrebbe ritornare agli affetti familiari e alla nativa Itaca dopo dieci anni passati a Troia a causa della guerra – suo è l’espediente del cavallo di legno che permette di sbloccare la situazione –, ma l’odio di un dio avverso, Poseidone, glielo impedisce. Costretto da continui incidenti e incredibili peripezie, dopo altri dieci anni, grazie anche all’aiuto della dea Atena, riuscirà a portare a compimento il rientro a casa. Si alternano tappe in cui l’insidia è manifesta, tra mostruosità, aggressione, morte, a tappe in cui l’insidia è latente, come un’ospitalità che nasconde un pericolo, un divieto da non infrangere. Il dio Poseidone, adirato con lui, gli scatena contro venti furiosi, provocando continui naufragi.
Il mito, eternato da Omero, è stato rivisitato e rinnovato nei secoli fino alla versione in chiave moderna di Joyce. È interessante la rilettura fatta dalla poetessa, scrittrice e ambientalista canadese Margaret Eleanor Atwood perché, nel suo romanzo intitolato Il canto di Penelope. Il mito del ritorno di Odisseo, lascia parlare proprio la moglie dell’eroe navigatore. Sappiamo che Penelope piangeva e pregava per il ritorno del marito, che seguiva il figlio adolescente, che si ingegnava per respingere le proposte dei Proci e conservare il regno, ma nel racconto di Omero non c’è traccia dei suoi pensieri. Atwood le dà voce quando, morta e nell’Ade, Penelope non teme più la vendetta degli dèi e desidera raccontare la verità, anche per mettere a tacere voci spiacevoli sul suo conto. La sua versione della vicenda è ricca di colpi di scena. Tra antichi dubbi e nuovi interrogativi, mette in luce la sua natura tormentata, in contrasto con la sua abituale immagine di equilibrio e pacatezza. Quel che è più interessante di quest’opera letteraria nell’ambito di questo nostro excursus è una sua descrizione dell’acqua: “L’acqua non oppone resistenza. L’acqua scorre. Quando immergi una mano nell’acqua senti solo una carezza. L’acqua non è un muro, non può fermarti. Va dove vuole andare e niente le si può opporre. L’acqua è paziente. L’acqua che gocciola consuma una pietra. Ricordatelo, bambina mia. Ricordati che per metà tu sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno. Come fa l’acqua”.
Le metamorfosi in acqua di Ovidio
“ Il naufrago teme anche il mare tranquillo”
I Classici richiederebbero mille riferimenti affascinanti. Scegliamo due storie di passioni che nel racconto di Publio Ovidio Nasone, poeta romano tra i principali esponenti della letteratura latina e della poesia elegiaca, si “sciolgono” in acqua. Sullo sfondo c’è la filosofia pitagorica della metempsicosi collegata al fluire dell’acqua, in base al presupposto che tutto si trasforma, nulla perisce.
Ciane, la ninfa amica di Proserpina, cerca di fermare Plutone, non vi riesce e si strugge in lacrime: le membra si ammorbidiscono, i capelli diventano azzurri, cerulei, il sangue vivo di vene già in disfacimento si scolora e la ninfa si trasforma in acqua. La sua vita si eterna nella fonte che prende il suo nome, Fonte Ciane, nella provincia di Siracusa.
E così Aretusa, ninfa cacciatrice, si trasforma in acqua per sfuggire alla violenta passione di Alfeo, ma si fonde per sempre con lui nell’elemento liquido che li contraddistingue. Di ritorno dalla foresta di Stinfalo, stanca e oppressa dall’afa, la ninfa si ferma presso un fiume immobile, trasparente, “tanto che a stento avresti creduto che scorresse”. Il luogo si presentava incorniciato da alberi lugubri, “pallidi salici e pioppi nutriti dall’acqua”, che davano alle rive naturale riparo dell’ombra. In una delle tante immagini pittoriche che Ovidio ci offre, la vediamo appendere a un ramo di salice i veli che la ricoprono e si immerge nuda nelle acque. Lì il fiume Alfeo la vede; la ninfa esce nuda dall’acqua e comincia la fuga e la corsa, inseguita da Alfeo che ha assunto sembianze umane, come quella delle colombe messe in fuga dallo sparviero. Con l’aiuto di Diana Dictinna, Aretusa si nasconde nel vapore di una nuvola, ma Alfeo la aspetta e la sorprende. Allora ecco che, come sempre accade nel momento estremo dell’inseguimento e della passione non corrisposta, avviene la metamorfosi che trasfigura tutto in bellezza: come sudore stillano gocce azzurrine e dai capelli cola rugiada. Aretusa si scioglie in acqua e invita a una speciale agnizione, che prelude alla fusione dei due: il fiume Alfeo riconosce nell’acqua l’amata e, lasciato l’aspetto umano che aveva assunto per tentare la seduzione, torna a essere fiume per unirsi a lei per sempre.
Non si può non ricordare la celebre frase di Ovidio che ha ispirato uomini di tutti i tempi: “Gutta cavat lapidem”, la goccia scava la pietra.
Dante Alighieri
“ … Quel mare al qual tutto si move”
Dante, nella sua magnifica avventura creativa, ci pone a contatto con la Visione dell’Origine prima di tutte le cose viventi. Il mondo che percorre nel suo fantastico viaggio è al di là delle cose terrene eppure rappresenta i significanti e i significati di quanto si trova nell’animo umano. In questo senso, è un libro tremendamente attuale, è lo specchio che riflette in poesia la nostra radice culturale e identitaria, come in passato hanno fatto l’ Iliade e l’ Odissea , per i Greci, e l’ Eneide , per i Latini. È inarrivabile per il valore simbolico ed emblematico delle sue indicazioni tese a far ritrovare la Strada, a impedire di perdersi tra dolore, paure, frustrazioni, rancori, smarrimento. In tutto questo, l’acqua è un elemento chiave.
Nel racconto di Dante, arriva per Adamo ed Eva la cacciata dall’Eden, mentre dal cielo, in contemporanea, cade a precipizio Lucifero. Ed ecco, a questo punto, la terra fuggire dal luogo a lei naturale e coprirsi del velo delle acque oceaniche, come leggiamo nel Canto XXXIV dell’Inferno:
“Da questa parte cadde giù dal cielo;
e la terra, che pria di qua si sporse,
per paura di lui fé del mar velo,
e venne a l’emisperio nostro”
Secondo Aristotele, il mondo fisico è come il corpo di un uomo, Atlante cosmico: con gli arti divaricati dentro il quadrato della materia, sotto la volta del cerchio dei cieli. Quest’uomo è perfettamente orientato secondo il senso dei moti di tutte le costellazioni, un moto che volge sempre da destra verso sinistra ed ha il suo “alto” che corrisponde all’emisfero meridionale, mentre il settentrione del nostro globo è quello spazio toccato dai suoi due piedi, nel “basso”. Dante ci dice che Lucifero, simbolo del nostro orgoglio, si conficcò in una trappola, proprio nel centro del globo della materia. Lucifero, “vermo reo che il mondo fora” , è dominatore del vuoto, così simile al vuoto di senso che cerca di divorare la coscienza dell’uomo. Dante spiega che interiormente noi, come la massa caotica del globo terraqueo, ritroviamo le parti fondamentali del nostro spazio interiore.
Il punto è che l’acqua di vita, da cui in origine si è generata la terra emersa dai flutti, è ora sotto di noi, in un drammatico e innaturale ribaltamento. Non vediamo quell’acqua di vita dal nostro emisfero segnato dal signore dell’ombra e del freddo. Ed è un gran mare di lacrime che i vari fiumi infernali, dove scorrono le nostre sbagliate passioni interiori, riversano. L’acqua è salata come le lacrime di drammi, conflitti, frustrazioni.
La condizione di questo primo livello interiore è raccontata da Dante attraverso le antiche raffigurazioni dell’oltretomba e sono un richiamo al mondo di Virgilio i n...