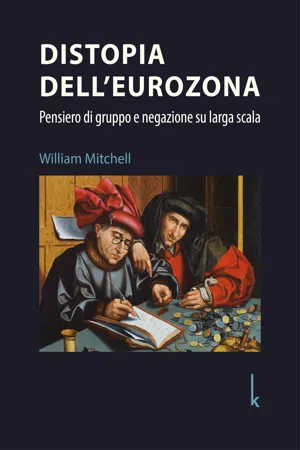
eBook - ePub
Distopia dell'eurozona
Pensiero di gruppo e negazione su larga scala
- 546 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
About this book
Al momento, l'Europa è intrappolata in un pensiero di gruppo neoliberale distruttivo che si manifesta come una negazione su larga scala. Per ripristinare la prosperità e la speranza è necessario evadere da questa prigione.Questo libro esamina criticamente le opzioni che le nazioni dell'eurozona hanno a disposizione per affrontare la crisi sociale ed economica che le ha tormentate dal 2008.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Distopia dell'eurozona by William Mitchell, R. Gaudioso in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Economía & Teoría económica. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1
INTRODUZIONE
“GROUPTHINK” (PENSIERO DI GRUPPO)
…un modello di pensiero caratterizzato dall’autoinganno, dalla fabbricazione forzata del consenso e dalla conformità ai valori e all’etica del gruppo. (dizionario online della Merriam Webster)
We bouwen op drijfzand [Stiamo costruendo sulle sabbie mobili]. (André Szász, ex direttore della Banca dei Paesi Bassi, 1999)
Questo libro esamina criticamente le opzioni che le nazioni dell’eurozona hanno a disposizione per affrontare la crisi sociale ed economica che le ha tormentate dal 2008. Il libro chiarisce queste opzioni all’interno di una comprensione storica del percorso intrapreso per creare l’Unione economica e monetaria (UEM). L’esperienza storica mette in evidenza le difficoltà che affrontano nazioni con strutture economiche molto diverse e una mancanza di solidarietà culturale quando cercano di fissare i tassi di cambio e di adottare una moneta comune. Ci permette anche di capire come il crescente predominio dell’economia neoliberale negli anni 80 si sia intersecato con la rivalità franco-tedesca del secondo dopoguerra per creare un pensiero di gruppo distruttivo che, sulla base di motivi ideologici, mina la prosperità, nega la realtà e rifiuta di applicare soluzioni possibili contro la crisi.
Ci sono opzioni migliori dell’austerità, anche all’interno della moneta comune. Ma se si vuole raggiungere una prosperità sostenibile, allora la zona euro dovrebbe essere smantellata in modo ordinato e le valute nazionali dovrebbero essere ripristinate. Se un tale sviluppo non può essere negoziato tra gli Stati membri, allora l’opzione migliore per nazioni come Italia, Grecia, Spagna e così via è quella di uscire unilateralmente dall’UEM e ripristinare la propria sovranità.
I grandi visionari europei nell’immediato dopoguerra non volevano costringere le economie europee in una camicia di forza di austerità e stenti. Essi miravano piuttosto a raggiungere la prosperità in tempo di pace. I leader politici europei concepirono il “progetto europeo” come un piano ambizioso per l’integrazione europea, per garantire che non ci fossero più conflitti militari su larga scala combattuti sul suolo europeo. Il progetto è iniziato in un periodo in cui nelle nazioni avanzate c’era un ampio consenso nei confronti della politica economica keynesiana e i relativi governi erano impegnati a sostenere la piena occupazione.
L’era keynesiana è emersa dalla “Grande Depressione”, la grande crisi che ha insegnato ai politici che senza un grande intervento del governo il capitalismo è intrinsecamente instabile e soggetto a lunghi periodi di disoccupazione. La piena occupazione arrivò solo con l’inizio della Seconda guerra mondiale, quando i governi hanno utilizzato la spesa per il deficit con lo scopo di perseguire lo sforzo bellico. L’era keynesiana della politica macroeconomica che ne è seguita è stata quindi segnata da deficit governativi che integravano la spesa privata per garantire che tutti coloro che volevano lavorare potessero trovare un impiego. L’ampio consenso politico ed economico emerso dopo la guerra portò a livelli molto bassi di disoccupazione nella maggior parte delle nazioni occidentali; questa situazione persistette fino alla metà degli anni 70, anche se in alcune nazioni europee si verificò un aumento sostenuto della disoccupazione come conseguenza della necessità di difendere le loro valute più deboli.
All’interno di questo ampio consenso politico, le discussioni sull’integrazione sono state condizionate dalla rivalità franco-tedesca. La Francia era determinata a creare strutture istituzionali che impedissero alla Germania di invaderla di nuovo. Vedeva nell’Europa integrata un modo per consolidare un ruolo dominante negli affari europei, ma era determinata a raggiungere questo obiettivo cedendo la minor quota possibile di sovranità nazionale. La Francia era inoltre risentita dell’influenza che gli Stati Uniti stavano esercitando in Europa, in particolare attraverso il piano Marshall che legava intrinsecamente la Germania occidentale agli Stati Uniti.
I tedeschi, soffrendo di una profonda vergogna per il loro passato militarismo e le azioni a esso associate, hanno potuto contare solo sul loro successo economico, compresa la “disciplina” della Bundesbank, per generare un orgoglio nazionale. Oltre alla necessità di espandere i propri mercati di esportazione, la Germania voleva far parte del “progetto europeo” per dimostrare di aver rifiutato voltato pagina rispetto al suo brutto passato. Tuttavia il timore ossessivo dell’inflazione ha fatto sì che questa partecipazione dovesse avvenire alle condizioni tedesche, il che significava che la nuova Europa avrebbe dovuto accettare la cultura della Bundesbank. Ciò diede vita a un processo logorante. All’interno del contesto di “stabilità” tedesco, sembrava che si trascurasse il fatto che la prosperità tedesca, in realtà, si basava su una robusta crescita delle importazioni da altre nazioni europee. Il fatto che non tutte le nazioni in un “contesto di stabilità” incentrato sulla Bundesbank potessero avere un surplus della bilancia commerciale è stato ignorato.
Dopo la Seconda guerra mondiale, le nazioni avanzate hanno anche accettato di fissare i loro tassi di cambio rispetto al dollaro USA, che a sua volta era legato al prezzo dell’oro, perché credevano che ciò avrebbe portato stabilità economica. Ma il cosiddetto sistema di Bretton Woods, istituito nel luglio 1944, fu sotto pressione fin dall’inizio perché i paesi con deficit commerciali dovevano sempre affrontare una pressione al ribasso sulle loro valute. Per mantenere i loro tassi di cambio dovevano: acquistare le proprie valute sui mercati dei cambi utilizzando le proprie riserve di valuta estera, spingere al rialzo i tassi di interesse interni per attirare l’afflusso di capitali e costringere la spesa pubblica a contenere le importazioni. Le nazioni con le valute più deboli si trovavano quindi spesso a dover affrontare tassi di crescita recessivi, l’aumento della disoccupazione e l’esaurimento delle riserve di valuta estera, e questo creava instabilità politica. Per essere efficace il sistema richiedeva che le nazioni avessero una forza commerciale più o meno simile, il che era ovviamente impossibile e alla fine questa impossibilità si è rivelata la causa del fallimento.
La rivalità franco-tedesca ha strutturato una serie di compromessi poco efficaci sulla via dell’unione monetaria. Il Trattato di Roma del 1957 fu fortemente condizionato a favore della Francia occupata a scapito degli aggressori, Germania e Italia. Ma la crescente forza industriale e di esportazione della Germania divenne una minaccia sempre più significativa per l’economia francese. L’ambizione industriale tedesca richiese alla Francia di scendere a compromessi con la propria feroce resistenza a cedere qualsiasi sovranità nazionale in favore di un’entità di livello europeo. La prima esperienza con la Politica Agricola Comune (PAC), introdotta nel 1962 come prima grande iniziativa della neonata CEE, avrebbe dovuto insegnare alle nazioni europee che entrare in un’unione monetaria sarebbe stato un esercizio arduo. La Francia voleva proteggere gli agricoltori francesi e la Germania voleva espandere il proprio mercato delle esportazioni industriali. Per raggiungere i loro obiettivi, i tedeschi hanno accettato di fornire sussidi ai contadini francesi attraverso la PAC: una tensione tutt’oggi logorante. Tuttavia la fattibilità amministrativa della PAC avrebbe richiesto un contesto di tassi di cambio molto stabile, perché tutta la Comunità avrebbe dovuto sostenere una miriade di costi legati all’agricoltura. Una volta che gli Stati membri si sono bloccati nella PAC, sono stati intrappolati anche dal compito impossibile di mantenere i tassi di cambio fissi. La crescita della forza delle esportazioni tedesche negli anni 60 fece del marco la valuta europea più forte, ciò mise Francia e Italia sotto costante pressione di svalutazione e di stagnazione interna, minando la stessa PAC. I vari accordi per il mantenimento di parità fisse tra le valute europee sono tutti falliti a causa della diversa forza di esportazione degli Stati membri. Ma invece di prendere la sensata decisione di rinunciare ai tassi di cambio fissi, quando nel 1971 il sistema di Bretton Woods è crollato i leader politici europei hanno accelerato il passaggio a una moneta comune. Il fiasco di Bretton Woods avrebbe dovuto insegnare qualcosa.
Il Rapporto Werner del 1970 delineava un calendario dettagliato per la creazione di un’unione economica e monetaria completa entro la fine del decennio. Era chiaro che il Comitato voleva che la politica monetaria e fiscale fosse centralizzata con il “centro delle decisioni di politica economica… [affinché]… sia politicamente responsabile nei confronti di un Parlamento europeo” (Rapporto Werner, 1970: 13). Nel 1975 un successivo studio del Comitato MacDougall sottolineava inoltre che un’unione economica e monetaria efficace avrebbe richiesto una forte presenza fiscale a livello federale. Essi valutarono che “è molto improbabile che per i prossimi anni a venire la Comunità sia così pienamente integrata nel campo della finanza pubblica quanto le attuali unioni economiche che abbiamo studiato” (Rapporto MacDougall, 1977: 11).
Ci sono molte spiegazioni contrastanti sul perché il piano di Werner non si sia concretizzato, ma la ragione di fondo è che in un’epoca di crescente instabilità monetaria la paura francese del dominio tedesco e la loro riluttanza a cedere il potere alle istituzioni sovranazionali, unite all’ossessione tedesca per l’inflazione, hanno ostacolato questo processo. Le due nazioni potevano chiaramente trovare il modo di cooperare a livello politico, ma cercare di formare un’unione economica e monetaria era difficile. Nel 1972 il governatore della Banca centrale danese disse: “Comincerò a credere nell’unione economica e monetaria europea quando qualcuno spiegherà come si controllano nove cavalli che corrono tutti a velocità diverse con la stessa bardatura” (McAllister, 2009: 58).
Nel 1972 lo psicologo sociale Irving Janis ha delineato un comportamento di gruppo che ha definito “groupthink” (pensiero di gruppo), che è un “modo di pensare in cui le persone si impegnano quando sono profondamente coinvolte in un gruppo coeso, quando i membri che si sforzano di raggiungere l’unanimità prevalgono sulla loro motivazione a valutare realisticamente le possibilità di azioni alternative” (Janis, 1982: 9). Questo “richiede che ogni membro eviti di sollevare questioni controverse” (Janis, 1982: 12). Il pensiero di gruppo comporta una sorta di “regola mafiosa” che mantiene la disciplina all’interno del gruppo o della comunità dei decisori. Queste comunità sviluppano una cultura dominante che infonde nei suoi membri un senso di appartenenza e uno scopo comune, ma li rende anche ignari e ostili a modi di pensare nuovi e migliori. Il pensiero di gruppo diventa evidente al mondo esterno quando c’è una crisi o, per dirla con le parole di Janis, un “fiasco”, come la crisi finanziaria globale (CFG).
Ciò che alla fine ha permesso di mettere insieme i “nove cavalli” non è stata una diminuzione della rivalità nazionale e culturale franco-tedesca, ma una crescente omogeneizzazione del dibattito economico. L’impennata del pensiero monetarista in seno alla macroeconomia negli anni 70, prima all’interno dell’accademia, poi nel campo della politica e delle banche centrali, si trasformò rapidamente in un pensiero di gruppo insulare, che intrappolò i responsabili politici nel mito dell’autoregolamentazione e del libero mercato. La “conferma condizionata” che ne è derivata, ovvero “la tendenza delle persone a notare solo informazioni coerenti con le proprie aspettative e a ignorare informazioni che non sono coerenti con esse” (IEO, 2011: 17), ha travolto il dibattito sull’integrazione monetaria. L’introduzione nel 1976, durante la presidenza di Valéry Giscard d’Estaing, del Piano Barre d’ispirazione monetarista, da parte del Primo ministro francese Raymond Barre, ha mostrato quanto i francesi si fossero allontanati dai loro giorni “keynesiani” gollisti. In tutta Europa la disoccupazione divenne uno strumento politico volto a mantenere la stabilità dei prezzi e la sua riduzione smise di essere un obiettivo politico, come lo era stato durante l’era keynesiana fino alla metà degli anni 70. La disoccupazione aumentò notevolmente quando i governi nazionali, infestati dal pensiero monetarista, iniziarono la loro lunga storia d’amore con l’austerità.
Il Rapporto Delors (1989), che caratterizzò la conferenza di Maastricht, ignorava le conclusioni dei Rapporti Werner e MacDougall sulla necessità di una forte funzione fiscale federale perché rappresentavano un pensiero keynesiano “vecchio stile”, non più tollerabile all’interno del pensiero di gruppo monetarista che aveva preso il sopravvento sul dibattito europeo. La nuova stirpe di élite finanziarie, che avrebbe guadagnato molto dalla deregolamentazione da loro richiesta, promosse il riemergere dell’ideologia del libero mercato che era stata screditata durante la Grande Depressione. Il passaggio da una visione collettiva keynesiana della piena occupazione e dell’equità a questa nuova regola mafiosa e individualistica era guidato da una prepotenza ideologica e da interessi settoriali ristretti anziché da intuizioni basate sull’autorità dei fatti e da una preoccupazione per la prosperità della società.
Il disprezzo monetarista (neoliberista) per l’intervento del governo ha fatto sì che l’UEM sopprimesse la capacità della politica fiscale, e nessun argomento o prova che indicasse che una tale scelta avrebbe portato alla crisi avrebbe distratto Delors e la sua squadra da questo obiettivo. Delors sapeva che avrebbe potuto placare l’esigenza politica francese di evitare di consegnare a Bruxelles il potere decisionale dissimulando questo obiettivo dietro la necessità di mantenere la responsabilità nazionale in materia di politica economica. Sapeva anche che le dure regole fiscali da lui proposte, che limitavano la libertà di manovra dei governi nazionali, avrebbero soddisfatto i tedeschi. Il monetarismo aveva fatto da ponte tra i due campi.
All’epoca l’intero processo era ammantato da un’atmosfera surreale.
Per apprezzare appieno le opzioni disponibili per l’eurozona, la discussione deve essere inquadrata in un quadro economico valido. Mentre la scarsa motivazione politica non può essere ignorata, una parte importante del problema che attualmente affligge le nazioni dell’eurozona deriva dall’applicazione di un quadro macroeconomico imperfetto che è stato utilizzato dai funzionari e dai loro padroni politici fin dagli anni 80.
L’eurozona è ora bloccata in una camicia di forza di austerità economica, guidata da un’ideologia economica cieca all’evidenza del proprio fallimento. Le politiche neoliberali di deregolamentazione e la demonizzazione dell’uso dei deficit fiscali discrezionali (spesa pubblica superiore al gettito fiscale) hanno creato inizialmente la crisi, e ora lo stesso tipo di politica la sta prolungando. L’attuale approccio politico ha istituzionalizzato la stagnazione economica, i diffusi tagli alla spesa, il deterioramento delle condizioni di lavoro e delle pensioni. Milioni di lavoratori europei sono ora disoccupati, i tassi di disoccupazione giovanile si aggirano intorno al 60% in alcune nazioni avanzate, i tassi di disuguaglianza e di povertà sono in aumento, e si assiste a massicce perdite giornaliere di reddito nazionale. I tassi di disoccupazione giovanile, drammaticamente elevati, garantiranno che i danni si estenderanno a tutte le generazioni e mineranno la prosperità futura quando una coorte di giovani disoccupati entrerà nell’età adulta senza esperienza lavorativa e con un crescente senso di estraneità rispetto alle norme sociali tradizionali.
Le élite politiche dell’eurozona sostengono che non c’è alternativa (“There Is No Alternative”, TINA) se non quella di imporre una maggiore austerità riducendo i deficit fiscali e imponendo ingenti tagli ai sistemi di welfare sociale. I principali partiti politici della maggior parte delle nazioni, al governo come all’opposizione, hanno accettato senza porre resistenza il dominio dell’ideologia neoliberale, che non solo ha uniformato il dibattito politico, ma ha anche oscurato le uniche strade credibili per la ripresa. Una corretta valutazione dello stato attuale indica che i deficit fiscali devono aumentare. L’austerità è esattamente l’opposto della risposta politica necessaria. Una ripresa sostenuta nell’eurozona e altrove richiede un rifiuto categorico della teoria e della pratica macroeconomica tradizionale e una riorganizzazione delle strutture istituzionali per consentire l’aumento del deficit. La valutazione è che questo può essere fatto solo se l’unione viene smantellata.
Questo libro rifiuta il mantra TINA che è stato un potente quadro organizzativo usato dai conservatori per promuovere il mito secondo cui la disciplina fiscale e la diffusa deregolamentazione permettano un libero mercato in grado di massimizzare la ricchezza per tutti. La posizione sostenuta in questo libro è abbastanza semplice, anche se i concetti su cui si basa non lo sono. Il quadro economico neoliberale promosso con vigore da molti economisti, dalle agenzie multinazionali come il Fondo monetario internazionale (FMI) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), oltre che da politici conservatori tra cui l’establishment dell’eurozona a Bruxelles e Francoforte, acceca gli occhi dell’opinione pubblica su alternative realistiche, limitando i confini del dibattito pubblico attraverso l’uso di priorità selettive, causalità indebite e scandalose rappresentazioni fuorvianti della realtà. Per questo, prima di poter apprezzare veramente le alternative è necessario riformulare la visione economica di fondo. Le alternative reali e migliori dell’attuale austerità fiscale sono troppo facilmente liquidate come ingenue, irrealistiche o semplicemente folli, se sono viste e valutate attraverso la lente economica neoliberale.
La principale ipotesi di questo libro è che le élite politiche europee – i politici, le burocrazie di supporto, le banche centrali e i consulenti esperti – rimangano intrappolate nel pensiero di gruppo neoliberale che ha creato il mostro dell’euro. È una dinamica di gruppo che resiste al cambiamento e spiega l’evidente disinteresse per percorsi politici alternativi che potrebbero ripristinare la crescita.
Il biologo americano Joseph Altman si è specializzato in neurobiologia e ha scoperto la neurogenesi degli adulti negli anni 60. Egli dimostrò che i cervelli adulti potevano creare nuovi neuroni, ma l’idea fu ferocemente negata dai suoi contemporanei. Solo quando il fenomeno fu “riscoperto” da un’altra scienziata (Elizabeth Gould nel 1999) l’ipotesi diventò di moda. Oggi la neurogenesi è una delle aree più significative delle neuroscienze. Perché le scoperte di Altman sono state ignorate per quasi 30 anni? Charles Gross scrisse nel 2008 che “il dogma di ‘nessun nuovo neurone’ era universalmente sostenuto e vigorosamente difeso dal più potente e principale anatomista dello sviluppo dei primati del suo tempo” (Gross, 2008: 331).
L’esempio di Altman ci aiuta a comprendere il perdurare della crisi all’interno dell’UEM. In primo luogo, le discipline accademiche (come la neurobiologia, l’economia e così via) lavorano all’interno di “paradigmi” organizzati che il filosofo Thomas Kuhn ha identificato come “conquiste scientifiche universalmente riconosciute che per un certo periodo forniscono problemi e soluzioni modello per una comunità di professionisti” (Kuhn, 1996: X). In genere, il corpus di conoscenze che definisce il paradigma è “raccontato… da libri di testo scientifici, elementari e avanzati” (Kuhn, 1996: 10). Kuhn ha messo in discussione l’idea secondo cui l’attività “scientifica” è un processo lineare, in cui gli studiosi aggiungono alla base della conoscenza nuovi fatti supportati empiricamente che sostituiscono le nozioni precedentemente accettate. Anzi, Ku...
Table of contents
- Cover
- Titel
- Impressum
- INDICE
- Prefazione
- 1 Introduzione
- PARTE I I PRIMI ANNI
- PARTE II IL PERCORSO VERSO LA CRISI
- PARTE III LE OPZIONI PER L’EUROPA
- Bibliografia