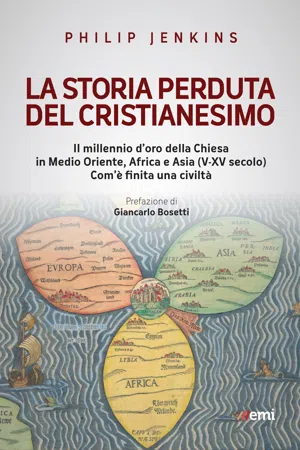![]()
1. LA FINE DEL CRISTIANESIMO GLOBALE
Le religioni muoiono quando
la loro verità è dimostrata.
La scienza è il registro
delle religioni defunte.
Oscar Wilde
Le religioni muoiono. Nel corso della storia, alcune religioni svaniscono del tutto, altre si riducono da grandi religioni mondiali a una manciata di seguaci. Il manicheismo, una religione che un tempo attirava adepti dalla Francia alla Cina, non esiste più in alcuna forma organizzata o funzionale; né esistono più le fedi che, mezzo millennio fa, dominavano il Messico e l’America Centrale. In alcuni casi le religioni possono sopravvivere in qualche parte del mondo, ma si estinguono nei territori che un tempo erano considerati le loro patrie naturali. Per mille anni l’India è stata prevalentemente buddhista, fede che ora risulta marginale in quella terra. Una volta la Persia era zoroastriana, la maggior parte della Spagna musulmana. Non è difficile trovare paesi o addirittura continenti che un tempo furono visti come le terre natali di una determinata fede, in cui tale credo è oggi estinto; e queste catastrofi non riguardano solo credenze primordiali o «primitive». I sistemi che noi consideriamo grandi religioni mondiali sono vulnerabili alla distruzione quanto la fede degli aztechi o dei maya nelle loro particolari divinità.1
In diverse occasioni anche il cristianesimo è stato distrutto in regioni dove un tempo aveva prosperato. Nella maggior parte dei casi, l’eliminazione è stata tanto meticolosa da cancellare ogni memoria dei cristiani sul territorio, al punto che oggi qualsiasi presenza cristiana da quelle parti è guardata come una sorta di specie invasiva arrivata dall’Occidente. Questa osservazione sulla distruzione delle chiese, però, appare in contrasto con la visione che molti popoli hanno della storia del cristianesimo.
Di solito, tale storia viene presentata come il racconto di una costante espansione, dal Medio Oriente all’Europa e infine sulla scena mondiale. Il cristianesimo sembra essersi diffuso liberamente e inesorabilmente, tanto che di rado si ricordano grandi sconfitte e battute d’arresto. I disastri e le persecuzioni sono rammentati, di solito, come il preludio ad ancora maggiori progressi, come opportunità per offrire una resistenza eroica all’oppressione. I protestanti sanno che la loro fede è sopravvissuta a tutte le persecuzioni e stragi delle guerre di religione; i cattolici ricordano che le peggiori atrocità loro inflitte da regimi protestanti e atei non sono riuscite a far tacere la vera fede. Osservatori più recenti testimoniano la sopravvivenza delle chiese sotto il comunismo, e il trionfo finale simboleggiato da papa Giovanni Paolo II. Come insegna l’inno, la verità durerà, nonostante la prigione, il fuoco e la spada.2
Chi si interessa alla storia del cristianesimo conosce la fondazione, la crescita e lo sviluppo delle chiese, ma quanti hanno letto i racconti del declino o dell’estinzione di comunità e istituzioni cristiane? Sembra che la maggior parte dei cristiani trovi inquietante la sola idea. Eppure tali eventi si sono sicuramente verificati, e molto più spesso di quanto non si pensi. Nel tardo Medioevo, defezioni di massa e persecuzioni in tutta l’Asia e il Medio Oriente sradicarono alcune comunità cristiane che erano tra le maggiori del mondo di allora: chiese che avevano un legame diretto, in termini di discendenza e di cultura, con il primo movimento di Gesù in Siria e in Palestina. Nel XVII secolo il Giappone eliminò una presenza cristiana che era sul punto di acquisire un reale potere all’interno del paese, e forse di ottenere la conversione dell’intera nazione. Più volte, nel corso della sua storia, l’albero della Chiesa è stato potato e tagliato, spesso selvaggiamente.3
Questi episodi di espulsione o distruzione di massa hanno plasmato in profondità il carattere della fede cristiana. Oggi siamo abituati a pensare al cristianesimo come a una fede tradizionalmente ambientata in Europa e nel Nord America, e solo gradualmente apprendiamo lo strano concetto che quella religione si propaga su scala globale, poiché il numero dei cristiani sta aumentando velocemente in Africa, in Asia e in America Latina. Il cristianesimo è talmente radicato nel patrimonio culturale dell’Occidente da far sembrare quasi rivoluzionaria una simile globalizzazione, con tutte le influenze che essa può esercitare sulla teologia, l’arte e la liturgia. Una fede associata principalmente con l’Europa deve in qualche modo adattarsi a questo mondo più vasto, ridimensionando molte delle proprie premesse, legate alla cultura europea. Alcuni si chiedono addirittura se questo nuovo cristianesimo globale o mondiale rimarrà pienamente autentico, come se le norme europee rappresentassero una sorta di gold standard.4
Queste domande, tuttavia, non hanno più senso quando ci si rende conto di quanto sia artificiosa l’accentuazione del carattere euroamericano nel contesto più ampio della storia cristiana. La particolare forma di cristianesimo a noi familiare costituisce una svolta radicale rispetto a quella che è stata per oltre un millennio la norma storica: una volta esisteva un altro e più antico cristianesimo. Per la maggior parte della sua storia, il cristianesimo è stato una religione tricontinentale, con potenti rappresentanze in Europa, Africa e Asia, e tale è rimasto fino al XIV secolo inoltrato. In seguito è diventato prevalentemente europeo non perché questo continente abbia affinità evidenti con la fede cristiana, ma per un fatto automatico, perché l’Europa era l’unico continente dove non era stato distrutto. Gli eventi avrebbero potuto avere uno sviluppo ben diverso.
Offrendo questa descrizione della caduta delle chiese non europee, non intendo lamentare la fine di un’egemonia cristiana mondiale che non è mai esistita, né tantomeno il fallimento di una resistenza a religioni rivali come l’islam. Ciò che si deve rimpiangere, piuttosto, è la distruzione di una cultura un tempo fiorente, così come ci si rammarica per la scomparsa della Spagna musulmana, dell’India buddhista o dei mondi ebraici dell’Europa orientale. Con la possibile eccezione di alcuni credi particolarmente sanguinosi o violenti, la distruzione di qualunque significativa tradizione di fede è una perdita insostituibile per l’esperienza umana e per la cultura. Inoltre, l’esperienza cristiana offre lezioni che si possono applicare più in generale alla sorte di altre religioni che hanno subito persecuzioni o sono state eliminate. Se una fede vigorosa e pervasiva come quella del cristianesimo mediorientale o asiatico è potuta cadere nell’oblio totale, nessuna religione può sentirsi al sicuro. E le modalità con cui si è verificata una simile caduta sono di grande interesse per chiunque pensi al futuro di qualsiasi credo o confessione religiosa.
Soprattutto, la riscoperta dei mondi cristiani perduti dell’Africa e dell’Asia pone domande che fanno riflettere sulla natura della memoria storica. Come abbiamo fatto a dimenticare una storia così importante? Per quanto riguarda la storia del cristianesimo, che di solito viene strettamente associata alla formazione dell’«Occidente», molto di ciò che crediamo di sapere è impreciso; mi riferisco ai luoghi e ai momenti in cui gli eventi sono accaduti e a come si sono verificati i cambiamenti in ambito religioso. Inoltre, molti aspetti del cristianesimo che oggi consideriamo tipicamente moderni rappresentavano, in realtà, la norma in un lontano passato: la globalizzazione, l’incontro con altre fedi e i dilemmi della vita sotto regimi ostili. Come è possibile che le nostre mappe mentali del passato si siano così radicalmente distorte?
Un terzo mondo cristiano
Gran parte di quello che oggi chiamiamo il mondo islamico era una volta cristiano. La fede cristiana è nata e ha preso forma in Siria-Palestina e in Egitto, e in queste aree ha continuato ad avere comunità importanti per molto tempo dopo le conquiste arabe. In pieno secolo XI almeno un terzo dei cristiani di tutto il mondo dimorava in Asia, mentre forse un decimo viveva in Africa; una cifra che quest’ultimo continente non avrebbe più raggiunto fino al 1960. Ancora nel 1250 si poteva pensare a un mondo cristiano che si estendeva a est da Costantinopoli a (almeno) Samarcanda, e a sud da Alessandria al deserto dell’Ogadèn, quasi all’equatore.5
Volgendo lo sguardo lontano dall’Europa, tutto ciò che crediamo di sapere del cristianesimo diventa l’immagine di un caleidoscopio, in maniera un poco allarmante. Prendiamo a esempio un punto di svolta leggendario nella storia del cristianesimo occidentale. Nell’anno 800 il re franco Carlo (Carlo Magno) aveva riunito la maggior parte dell’Europa occidentale sotto un unico governo cristiano. Il giorno di Natale dello stesso anno, a Roma, il papa lo incoronò imperatore, consacrando la duratura collaborazione tra Chiesa e Impero nell’Occidente medievale. Per molti osservatori moderni, tale incoronazione rappresenta un insieme di aspetti sgradevoli del cristianesimo storico: la sua alleanza con il potere statale, la sua natura completamente europea, il suo isolamento arrogante da altre fedi e culture. Per molte persone, oggi, la parola cristianità significa un regime teocratico che impone per legge un rigido codice morale e dottrinale, escludendo gli ebrei e altri soggetti differenti, o sottoponendoli a violenze e ingiurie. Fin troppo spesso, gli stati cristiani vennero associati all’ignoranza, in un mondo che ricordava solo frammentariamente la cultura e la scienza classica. Anche se Carlo Magno presiedeva a una sorta di «rinascimento», si trattava di una fioritura modesta a confronto con il mondo antico, per non parlare del vero Rinascimento del XV secolo.
Gli storici possono discutere sulle realtà della cristianità di Carlo Magno, ma questa rappresentava solo una parte di una storia cristiana molto più grande, immensamente più varia e interessante di quanto lo stereotipo comune non ammetta. Quando si parla della Chiesa medievale, di solito ci si riferisce alle condizioni dell’Europa occidentale, non al mondo orientale, che aveva per centro Costantinopoli ed era molto più ricco e sofisticato. Ma esisteva, inoltre, un terzo mondo cristiano, un vasto e complesso regno che si estendeva all’interno dell’Asia.
Per apprezzare la diversità di questo perduto cristianesimo orientale, consideriamo uno dei suoi protagonisti, un uomo contemporaneo di Carlo Magno. All’incirca nel 780, il vescovo Timoteo divenne catholicos, ovvero patriarca della Chiesa d’Oriente, la cui sede si trovava allora presso l’antica città mesopotamica di Seleucia. Aveva cinquantadue anni, ben oltre l’aspettativa media di vita delle persone dell’epoca. Tuttavia, egli superò i novant’anni, morendo nell’823. Durante la sua lunga vita, Timoteo si dedicò alle conquiste spirituali con lo stesso entusiasmo con cui Carlo Magno edificò il proprio impero temporale. Ogni tappa della carriera di Timoteo smentisce tutto quello che pensiamo di sapere sulla storia del cristianesimo, la sua diffusione geografica, il suo rapporto con il potere politico statale, i suoi orizzonti culturali e la sua interazione con altre religioni. Riguardo al prestigio e all’estensione geografica dell’autorità di Timoteo, probabilmente egli era il più significativo leader spirituale cristiano del suo tempo, molto più influente del papa di Roma, e alla pari con il patriarca ortodosso di Costantinopoli. Forse un quarto dei cristiani di tutto il mondo considerava Timoteo il loro capo spirituale e politico. Non meno del papa occidentale, il catholicos di Seleucia poteva rivendicare di essere a capo della Chiesa di origine apostolica.6
La maggior parte degli occidentali di oggi concepisce la storia cristiana prendendo a riferimento solo il libro degli Atti degli apostoli, che si concentra sull’espansione della Chiesa a occidente, attraverso la Grecia e il mondo mediterraneo, fino a Roma. Indubbiamente alcuni dei primi cristiani partirono verso l’ovest, ma nello stesso tempo molti altri credenti – probabilmente in numero maggiore – si spostarono a est lungo le vie di terra, attraverso gli attuali Iraq e Iran, dove fondarono chiese grandi e durature. A causa della sua posizione – vicina alla frontiera romana, ma abbastanza lontana da evitare interferenze di rilievo – la Mesopotamia o Iraq mantenne una forte cultura cristiana almeno fino al XIII secolo. Per il numero e lo splendore delle chiese e dei monasteri, il grande sviluppo degli studi e l’affascinante spiritualità, l’Iraq fu nel tardo Medioevo un centro culturale e spirituale del cristianesimo non inferiore alla Francia, alla Germania o addirittura all’Irlanda.
Iraq e Siria furono le basi di due grandi chiese transnazionali, ritenute eretiche dalla comunità cattolica e da quella ortodossa, cioè i nestoriani e i giacobiti. Durante il Medioevo, tra i capisaldi cristiani del Medio Oriente vi erano le città irachene oggi frequentemente citate nei telegiornali: Bassora, Mosul e Kirkuk. Tikrit, la città natale di Saddam...