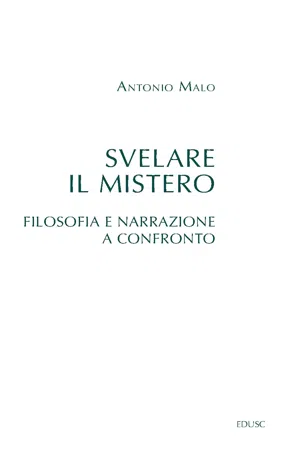![]()
Capitolo 8
Origine e fine della finzione
Avere un’origine e una fine è ciò che caratterizza non solo la vita personale, ma anche le opere di finzione. E ciò appare con più chiarezza nel modo in cui incominciano le fiabe e le storie: C’era una volta.
1. C’era una volta: il mito delle origini e la sua scomparsa
Ogni racconto inaugura un nuovo mondo che si riallaccia a un mondo più antico antecedente alla storia umana: il mito delle origini. La forma verbale all’imperfetto — c’era — non indica qui un tempo passato o trascorso, anche se incompiuto, ma il tempo delle origini, preterito perché esiste da sempre, prima di qualsiasi altro passato e, ciò nonostante, non è passato ma sempre presente.
In principio era il Verbo, ma il Verbo continua ad essere in ogni verbo umano, e in ogni racconto. Ognuno di essi si colloca in quell’origine, così remota da essere al di fuori del tempo stesso, e così attuale da costituire la pura atemporalità in cui si situa il racconto. Quindi, il C’era una volta delle fiabe è la pura esistenza di un verbo umano che racconta, ma nel raccontare non rimanda solo a sé raccontandosi, ma a un Verbo eterno, fuori dal tempo, dal quale dipendono la vita umana e le sue rappresentazioni narrative.
Un’idea simile si trova in Aristotele quando parla del mito come cuore della tragedia. Infatti, la trama poetica che unisce una molteplicità di eventi, personaggi e azioni è possibile perché contiene come nucleo un mito, un principio interno. Solo che per Aristotele il principio del mito non è un Verbo eterno trascendente, ma un principio immanente. In effetti, come accade con gli esseri viventi, soprattutto le persone, la tragedia ha anche un’anima: il mito. In quanto principio vitale, il mito è capace di dare unità al molteplice e collegare le restanti cause attraverso il fine. Altrimenti l’unità del racconto o della tragedia non sarebbe più vitale, come accade negli artifici o anche in un’opera di finzione inverosimile, perché manca l’unità che proviene dal mito. Senza mito o principio interno, l’unità dell’opera sarà esterna, prodotta dalla volontà dispotica dell’autore, dal moralismo o più in generale dall’ideologia.
Il mito della tragedia e, per estensione del racconto, consiste, invece, nella mimesis praxeos o imitazione del vivere umano o delle sue azioni o mimesis prattontas. Come accade nella vita umana, anche la tragedia e, in generale, il racconto, tendono alla loro forma perfetta o fine. Come si spiega allora che i personaggi buoni e virtuosi siano puniti e, a volte, i cattivi vengano premiati?
Secondo Marta Nussbaum la causa è nel fatto che la finalità della poetica è un’esperienza estetica, quindi non è retorica, né storica e nemmeno etica. Questa esperienza consiste in un riconoscimento, quindi, qualcosa di già conosciuto ma non tematizzato, o perlomeno non approfondito; in particolare, si tratta di «una comprensione più profonda del mondo, degli ostacoli incontrati dalla bontà e della necessità dell’aiuto degli altri». In questo senso si potrebbe parlare di universali, non tanto riguardo ai personaggi o alle situazioni, quanto a ciò che può accadere e che molto spesso accade ad ognuno; ma, poiché siamo immersi in questa situazione vitale, non riusciamo a prendere le distanze e a rendercene conto.
Penso, però, che la perfezione di cui parla Aristotele non sia tanto quella della rappresentazione di ciò che potrebbe essere, o è ma non lo scopriamo abitualmente e, perciò, sia accattivante riconoscerla, bensì della felicità o infelicità dei personaggi come finalità del mythos.
La vita umana e la sua rappresentazione letteraria appaiono come conflitto interno ed esterno, come cambiamento e fine: felicità e infelicità. Il nodo o conflitto, come accade con le crisi nella vita delle persone, è necessario per continuare a crescere. E, come abbiamo visto, sono proprio la tentazione e la colpa o hamartia a causare il conflitto. Il conflitto cambia il passato, ma anche il presente: il modo di affrontarlo e, quindi, lo stesso futuro.
Il c’era una volta, con cui incominciano le fiabe, appare così non solo come principio o archê, ma anche come senso della vita umana, che deve affrontare il suo destino, con i cambiamenti, cadute e rinascite, per poter giungere alla meta: la felicità. In un certo senso, come abbiamo visto nell’analisi del Signore degli anelli, le storie permettono di prepararci al destino, di affrontarlo con eroicità e di dargli un senso mediante l’amore. Perciò, come sostiene D’Avenia, ogni storia è una storia di amore e, potremmo aggiungere, fedele o tradito.
Così, raccontare è sia scoprire il senso di ciò che ci è stato dato e trasmesso, sia prepararsi ad affrontare la tentazione e il male, e a vincerli. Il pubblico e il lettore, in quanto amici, accompagnano i personaggi — da cui possiamo sempre imparare — in questo viaggio la cui meta è il ritorno alle origini, e che nell’opera di finzione è indicato dall’Happy end, o finale felice. L’identificazione con i personaggi, oltre a fare vivere una gamma di emozioni agli spettatori e ai lettori, permette d’imparare ad affrontare il proprio destino. E, in questo modo, a tirare fuori delle risorse che ci rendono più noi stessi, in quanto diventiamo ciò con cui ci identifichiamo e ci identifichiamo con ciò che desideriamo essere.
Se nelle fiabe la presenza dell’origine costituisce l’archê o anima del mito, in molte opere moderne di finzione non c’è più, almeno apparentemente, nessun rimando all’origine, anzi molte volte esso viene negato e di conseguenza scompare la stessa struttura narrativa, della quale si mantiene solo il nodo o conflitto. Ma un conflitto che non ha origine e a cui manca un finale, finisce per non avere alcun senso, per cui l’identificazione del pubblico o del lettore con l’opera di finzione risulta difficile, tranne per quel pubblico o lettore che ha perso qualsiasi idea di fine del proprio vivere, ad eccezione di quello fattuale della morte.
Da dove deriva questa perdita dell’origine? Penso dalla morte di Dio annunciata da Nietzsche, la quale, come indica Foucault, porta con sé necessariamente la morte dell’uomo, della sua immagine e somiglianza, e di conseguenza di quella che rappresenta la paternità e la filiazione umane nelle opere di finzione. La perdita dell’origine viene mostrata attraverso dei simboli e delle metafore. Ma dal punto di vista dei personaggi essa appare soprattutto come una mancanza: la scomparsa della figura del padre; mentre dal punto di vista del mondo di finzione dà luogo alla distopia o inferno umano, come in 1984 di Orwell. Come vedremo, tanto l’una come l’altra (scomparsa del padre e distopia) hanno luogo in un mondo in cui la persona e le sue relazioni gratuite scompaiono e sono sostituite da relazioni non solo di piacere o utilitaristiche, come in Brave New World, ma anche di perversione e violenza, come nel film Joker.
2. Tre modi di affrontare il destino: utopia, distopia e tragicommedia
Se Aristotele parlava di tre tipi di mimesi quando si riferiva ai tre modi di rappresentare — migliore di come gli uomini sono (epica), peggiore di come sono (commedia) e uguale a come sono (tragedia) — noi possiamo anche parlare di tre modi di affrontare il destino dell’uomo: migliore di quello che è realmente (utopia), peggiore (distopia), uguale (mondo personale con aspetti tragicomici).
I mondi possibili sono al di sopra o al di sotto del mondo reale. I primi sono quelli utopici, mentre i secondi sono distopici. Tuttavia, come si vedrà, molte volte l’utopia finisce per diventare distopia.
Utopico è un aggettivo derivato da utopia, neologismo creato da San Tommaso Moro con il suo libro che reca lo stesso titolo. In questo saggio, l’umanista inglese, profondo conoscitore della lingua greca, gioca con il doppio significato che la parola utopia può avere a partire dai due etimi possibili:
1) Eutopeia, composta dal prefisso greco eu (‘buono’) e topos (‘luogo’), cioè luogo buono o luogo ideale. Moro sembra prendere come modello della sua opera la Repubblica di Platone, poiché nell’isola di Utopia c’è un governo perfetto, costituito da Ademo e il suo senato, che sono giusti e giudicano ogni tipo di situazione d’accordo con le leggi umane non corrotte e sempre con epicheia, ossia tenendo conto delle situazioni e circostanze personali; ad esempio, anche se l’adulterio è punito con l’espulsione dell’adultero, se l’altro coniuge lo perdona, sebbene in teoria dovrebbe accompagnare il colpevole nell’espatrio, il senato spesso s’impietosisce e permette loro di restare. D’altra parte, in Utopia tutti hanno ciò di cui hanno bisogno, non ci sono guerre di religione poiché tutte le religioni sono ammesse e, infine, anche se esiste la pena di morte, essa è l’estrema ratio poiché si tenta di fare fronte ai crimini con altre pene. Certamente tutto ciò è possibile perché si tratta di una Repubblica tollerante e cristiana, che così fa vedere meglio i difetti delle monarchie dell’epoca, in particolare di quella inglese.
2) Outopeia, che procede dalla negazione greca ou contratta in u (‘non’) e topos (‘luogo’), ossia un non-luogo, come a indicare che tale repubblica non esiste da nessuna parte, ed è solo immaginaria. Infatti, molti dei nomi usati da Moro fanno riferimento a un mondo di finzione; così, Ademo, nome del governatore, significa ‘senza popolo’ (a-demos), e il fiume, l’Anidro, significa ‘senza acqua’ (an-hidros). Tuttavia, dove l’aspetto fantastico di Utopia appare con più chiarezza è nella visione idilliaca della vita degli utopensi. In questa repubblica, non solo non esiste la proprietà privata e ognuno ha il diritto di prendere da un grande magazzino ciò che gli occorre, ma tutti lavorano sei ore al giorno e il resto del tempo lo dedicano all’istruzione: lettura, studio delle diverse scienze, come la geometria, l’astronomia. Per cui si potrebbe dire che i due valori fondamentali sono la pace e la cultura, che include in sé la religione.
Lungo la storia, l’Utopia di Moro ha avuto una grande influenza anche se non sempre si è mantenuto l’equilibrio fra questi due significati che contiene il termine. In alcune occasioni è prevalso il carattere morale (positivo o negativo) dell’utopia, in altre quello fantastico. Ma forse ciò che si è mantenuto quasi sempre è l’ironia, nata dal paragone di questi mondi con la realtà.
2.1. Utopia o distopia? Brave New World
Nel 1942, Aldous Huxley pubblica un romanzo fantascientifico intitolato Brave New World (Il mondo nuovo). Il titolo è ripreso da un passo della Tempesta di Shakespeare, quando Miranda, figlia del mago Prospero, nel vedere la diversità del mondo degli uomini, esclama estasiata: «Oh meraviglia! Quante creature vedo qui di grazioso aspetto. Come è bella la razza dell’uomo! O nobile, ignoto Mondo (Brave New World) che brulica di simili esseri!”».
In questo senso, il romanzo appare sin dall’inizio terribilmente ironico, poiché ciò che desta meraviglia n...