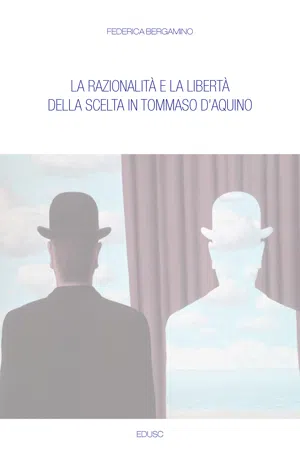
- 226 pages
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
La razionalità e la libertà della scelta in Tommaso d'Aquino
About this book
La libertà della scelta nella filosofia contemporanea sembra costituire ancora un problema teoretico. Le analisi che si susseguono nel corso della storia della filosofia tendono a fornire due letture interpretative fondamentali che si interrogano sul principio che è all'origine dell'atto: a seconda che questi venga identificato con l'intelletto o con la volontà si avrà la tendenza intellettualista o quella volontarista. Una certa fenomenologia descrive invece la scelta come un atto in cui si rivela la compresenza di due elementi uno intellettuale e uno volitivo. Detta compresenza in una descrizione meramente fenomenologica sembra però dar luogo a un paradosso: il paradosso della derivazione dell'atto da qualcosa di precedente – l'elemento razionale – il motivo, e al contempo dell'insorgere di una novità – l'elemento volitivo – che sembra emergere senza ammettere precedenti. Detto paradosso pone la domanda circa la relazione esistente tra razionalità e libertà: sono i due termini conflittuali? Di contro all'impostazione della filosofia contemporanea si staglia la posizione di Tommaso d'Aquino per il quale la questione appare capovolta: non solo non rileva la presenza di un conflitto, ma ne esprime molto chiaramente la relazione in termini di causalità; per l'Aquinate la razionalità è la causa della libertà.È la tesi dell'Aquinate meramente ingenua, o ci sono i presupposti e la metafisica per una dimostrazione di tali asserzioni? Questo ciò che vuole mostrare l'Autrice: esaminare la posizione dell'Aquinate per vedere se nell'antropologia metafisica di Tommaso, attraverso l'analisi dei suoi testi e in confronto con la letteratura tomista più recente sul tema, si dia una dimostrazione di detta relazione causale e una risposta soddisfacente al filosofo contemporaneo.Il lavoro consiste in un'analitica della scelta in chiave metafisica. La messa a fuoco della nozione di causa in Tommaso e il confronto tra le cause fisiche e quelle intellettuali, risultano centrali nell'opera per intendere la concezione della libertà in Tommaso e il ruolo essenziale dell'intelletto. La disamina sulla genesi dell'atto, la riconsiderazione dei diversi elementi che vi convergono, sulla base dei testi dell'Aquinate, e l'apporto specifico che da esso ne risulta, mostra al lettore che Tommaso ha ancora qualcosa da dire al mondo intellettuale contemporaneo, e che forse una via maestra per scoprirlo è attingere direttamente ai suoi scrittiL'iniziativa di editare questo testo in formato digitale nasce dalle molteplici richieste di esso che ci sono pervenute. Dopo quasi vent'anni questo libro propone una lettura e interpretazione analitica dei testi dell'Aquinate sempre valida e interessante. In particolare l'approfondimento della causalità non deterministica dell'intelletto in Tommaso risulta di speciale rilievo e originalità nel contesto delle ermenutiche tommasiane.Federica Bergamino è professore di Antropologia e Letteratura alla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce (Roma). Ha pubblicato principalmente su Tommaso d'Aquino, antropologia filosofica e il rapporto tra l'antropologia filosofica e la narrazione. Nella stessa casa editrice ha pubblicato La struttura dell'essere umano (2007), Dostoevskij. Abitare il mistero (2017).
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
Capitolo 5
La radice della libertà della scelta
La causalità contingente dell'intelletto
di Garrigou-Lagrange
Table of contents
- Introduzione
- Citazioni
- I. I presupposti della scelta
- II. La natura della scelta
- III. La libertà della scelta
- IV. La libertà della scelta nel tomismo del XX secolo
- V. La radice della libertà della scelta - La causalità contingente dell'intelletto
- Conclusioni
- Bibliografia