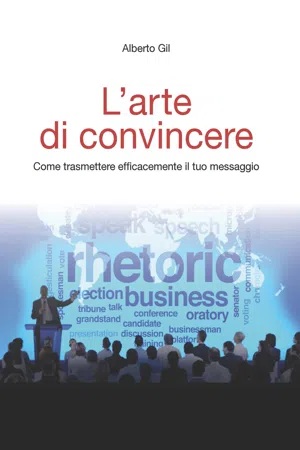![]()
V. STRUTTURAZIONE DEL DISCORSO
La tecnica dell’efficacia retorica
Negli scorsi capitoli abbiamo cercato di mettere in rilievo la stretta relazione esistente tra una retorica efficace e l’intenzionalità del parlante. In questo capitolo vedremo come quelle disposizioni interiori si traducono nell’azione comunicativa. Dunque le pagine che seguono si preoccuperanno di stabilire un vincolo tra le tecniche del discorso e la capacità persuasiva degli interlocutori (il loro ethos), delineando così i tratti fondamentali di una retorica dei valori. Si cercherà inoltre di mostrare l’effetto retorico delle altre risorse persuasive (logos e pathos), nonché di ribadire l’importanza del sentimento di comunione quando si tratta tecnicamente di concepire e di realizzare un discorso. È possibile affermare, in modo piuttosto generico, ma non per questo meno esatto, che un oratore è efficace anzitutto per ciò che è come persona, in secondo luogo per ciò che fa e in terzo luogo per il suo modo di parlare. La pertinenza di questi tre livelli viene messa in rilievo nel commento del giornalista tedesco Werner Siebeck, il quale in un recente saggio sui nuovi mezzi di comunicazione (2012:404) mostra come un buon effetto mediatico dipenda soprattutto dal carisma che irradia chi parla: la sua simpatia, la sua professionalità e, soprattutto, la sua autenticità.
E tuttavia la tecnica è necessaria. L’ideale sta nel trovare un equilibrio tra un atteggiamento interiore sano rispetto al contenuto e agli ascoltatori del discorso, e l’applicazione di strumenti retorici efficaci. Su questo sfondo si possono distinguere, seguendo le orme della retorica classica, due elementi fondamentali di una tecnica retorica efficace:
- • elementi costitutivi di ogni discorso (5.1)
- • fasi della concezione e realizzazione di un discorso (5.2)
5.1 Elementi costitutivi di ogni discorso
In vista della preparazione di un discorso e della formazione dell’oratore vanno considerati i seguenti principi:
- • Di che genere di discorso si tratta? Ogni genere ha i propri connotati comunicativi (5.1.1)
- • Che obiettivi ci si propone col discorso? Un discorso raffinato ma inefficace causerebbe irritazione (5.1.2)
- • Quale preparazione tecnica serve a un buon oratore per essere più convincente? (5.1.3)
5.1.1 Generi del discorso. Non si può fare una conferenza o un discorso in generale. Quella conferenza apparterrà pur sempre a un genere concreto. Tradizionalmente si distinguono tre tipi di discorso:
a) giudiziale (genus iudiciale)
b) deliberativo (genus deliberativum)
c) celebrativo (genus demonstrativum)
a) Discorso giudiziale (genus iudiciale). È il genere originario dell’arte retorica. Col discorso giudiziale, agli inizi della democrazia greca (V secolo a.C.) si cercava di convincere il giudice. Tuttora all’avvocato, nel discutere le prove acquisite, si consiglia di impressionare i partecipanti a una causa pronunciando un discorso non soltanto giuridicamente corretto, ma anche commovente, soprattutto se si tratta di casi rilevanti dal punto di vista politico e sociale.
Quali elementi vanno considerati in un discorso giudiziale? Anzitutto l’avvocato deve godere di una buona fama. Già Cicerone (De oratore, II 182 s.) faceva notare che il cuore dei giudici si conquista soprattutto con la dignità e la buona reputazione dell’avvocato e del suo cliente (dignitate hominis, rebus gestis, existimatione vitae). Quelle qualità saranno molto più efficaci se esistono realmente. Possono fingerle soltanto i bravi attori, e non per molto tempo. Per dirla con Cicerone (ibidem): la dignità e la buona reputazione esalteranno meglio il discorso se appartengono davvero a chi parla e non c’è bisogno di simularle (quae facilius ornari possunt, si modo sunt, quam fingi, si nulla sunt). Quando quella buona reputazione esiste, la sua forza persuasiva è di per sé tanto grande che una voce dolce, la modestia nella mimica e nelle stesse parole (lenitas vocis, voltum pudoris significatio, verborum comitas) sono uno strumento retorico più efficace del suo contrario: presenza dominante, intonazione insistente e via dicendo. Più ancora, quel comportamento può risultare minaccioso, sicché l’altro cercherà di proteggersi da un interlocutore così incombente. In questo modo, per Cicerone (ibidem, 183) la modestia, la benevolenza e la generosità sono più convincenti della violenza, dell’aggressività e della durezza. L’attualità perdurante delle affermazioni del retore romano viene confermata dagli stessi giudici, che per esperienza diffidano di certi avvocati, mentre con altri professionisti, sulla cui onestà e professionalità possono contare, non hanno bisogno di prendere quelle precauzioni.
Ma qual è la caratteristica fondamentale del discorso giudiziale? Che cosa si aspettano di vedere e sentire i giudici? Quel che serve sono prove. Sono queste a determinare il genere giudiziale. Per quanto riguarda la retorica delle prove, va rilevato che non si tratta di argomentazioni complicate, soprattutto nel discorso orale, dove, diversamente da quello scritto, non si può riandare a quando si è ascoltato di preciso, ma è necessario comprendere direttamente il messaggio. L’arte retorica, in questo caso, consiste nel far sì che il contenuto «entri dagli occhi», in un modo diretto, vale a dire con le parole giuste e con un’esposizione precisa delle prove (niente di più, ma anche niente di meno). In altri termini, saranno le prove stesse a illustrare la tesi.
Possiamo pensare a quanto già menzionato nel capitolo 1.1.2 quando abbiamo parlato della riflessività. Il riflesso retorico starà nel fatto che le parole escano con maggiore gravità, soppesando quanto viene detto (tecniche più concrete verranno specificate nel capitolo 5.2). Ricordiamolo: si convince più efficacemente quando ciò che viene detto è avallato dalla riflessione e dalla convinzione interiore. E questo serve anche nei giudizi.
b) Discorso deliberativo (genus deliberativum). È il genere tipico dei contesti politici e professionali. Si può trattare di un discorso in parlamento, della presentazione di un progetto in un’impresa o davanti a possibili clienti, oppure di una conferenza scientifica, di una lezione o di un’omelia. La forza persuasiva di questo genere aumenta nella misura in cui l’oratore non vuole imporre la sua opinione con la forza o con fallacie retoriche (cfr capitolo 6.2.2), ma pondera sinceramente i pro e i contro dei suoi argomenti, mettendo le carte in tavola, alla vista di tutti.
La caratteristica centrale del discorso deliberativo è la chiarezza della sua argomentazione. Anche qui nel discorso orale vanno evitati ragionamenti complicati che l’ascoltatore riesce a stento a seguire. Sono preferibili argomenti brevi e semplici che toccano il cuore del problema. Torna qui in evidenza l’importanza della relazione tra retorica e umiltà (cfr capitolo 3.2.4): quanto meno l’oratore cerca di brillare per perspicacia logica o per l’ampiezza delle conoscenze, tanto maggiori saranno l’oggettività, la semplicità e la comprensibilità del suo argomentare.
c) Discorso celebrativo (genus demonstrativum). I discorsi celebrativi comprendono principalmente le cosiddette laudationes, che trovano posto nella vita sociale, sia privata sia professionale. Si tengono in occasione del compleanno o dell’onomastico di un familiare o di un amico, del congedo di uno stimato collega che va in pensione, quando si inaugura o si chiude un evento, quando si pronuncia un discorso funebre e così via.
È Aristotele (Retorica,1418a) a chiamare questo genere «discorso epidittico», cioè con cui si mostra qualcosa, come i fatti positivi ed esemplari del festeggiato ch...