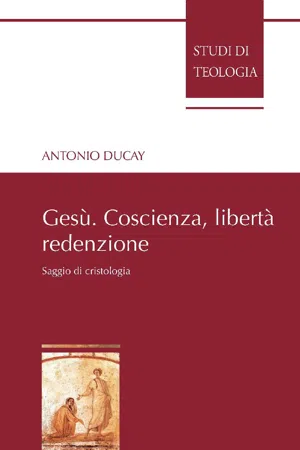![]()
Sezione 1
La conoscenza umana di Cristo
1.1 Il fondamento
l. 71Sin dai tempi della condanna dell’apollinarismo da parte della Chiesa (362), divenne dogma l’esistenza in Cristo di un intelletto e di una conoscenza umani1. La teoria apollinarista che negava l’intelletto umano di Gesù e lo “sostituiva” con il Logos divino, implicava, come conseguenza diretta, che l’uomo Gesù sapeva quanto il Logos, perché conosceva con lo stesso intelletto del Logos. La tesi fu rifiutata dalla Chiesa del tempo. Nel secolo successivo il concilio di Calcedonia ribadì l’integrità dell’umanità di Cristo, vero Dio e vero uomo e, quindi, dotato di intelletto umano, e affermò l’esistenza in Gesù di due diverse facoltà intellettuali, di due diversi modi di conoscenza, l’uno divino e l’altro umano, che, per ciò stesso, non si identificavano. Gesù, dunque, in quanto Dio fattosi uomo, conosceva la realtà in modo divino e in modo umano. Da allora la dottrina della Chiesa è rimasta invariata: due intelletti, due modi di conoscenza. Il progredire della riflessione su Gesù portò san Tommaso ad affermare che, se Cristo non avesse avuto altro modo di conoscere che quello divino (la scienza presente nell’intelletto divino), la sua anima umana, da se stessa, non avrebbe conosciuto nulla ed Egli non avrebbe esercitato il suo intelletto2.
L’affermazione tomista ci offre un buon punto di partenza per introdurre il tema della conoscenza umana di Cristo. Con il suo intelletto divino Gesù conosceva ogni cosa come la conoscono il Padre e lo Spirito Santo, perché era con loro un solo Dio onnisciente. Ciò, però, non implica che Egli avesse un sapere umano equivalente a quello divino. Non poteva conoscere con l’intelletto umano tutto ciò che conosceva con quello divino, perché l’intelletto umano ha dei limiti che sono inerenti alla finitezza della creatura umana3. Esistono necessariamente idee eccelse che sono accessibili soltanto all’intelletto divino, perché quello umano non è in grado di raggiungere tali vertici. È vero che Dio può comunicare contenuti di verità irraggiungibili per l’uomo (come accade nel caso dei profeti), e far sì che questi sappia cose che soltanto Lui può sapere, ma per farlo deve adeguare tali contenuti alle capacità e ai limiti naturali dell’uomo, il che implica già di per sé una riduzione, un “abbassamento” pressoché infinito del sapere divino. Affermare il contrario, sostenere, cioè, una sorta di equivalenza conoscitiva tra Dio e l’uomo, significherebbe sminuire le differenze tra le due nature (divina e umana), il che sarebbe assurdo e inaudito4.
Vi era dunque un ambito di realtà (indeterminato a priori) che Gesù conosceva ab aeterno con il Padre nell’unità dello Spirito, e che, invece, non conosceva come uomo, sia perché esso trascendeva assolutamente ciò che un essere umano può conoscere, sia perché Egli stesso, nella sua provvidenza, aveva stabilito di non comunicare tali realtà al suo intelletto umano. Nel suo cammino terreno, quindi, Gesù non le conosceva, mancava di informazioni su di esse. La citata concezione tommasiana della conoscenza umana di Gesù porta a concludere che su quelle realtà l’anima di Cristo non aveva scienza.
Ciò che Gesù conosceva come uomo, dunque, non può essere stabilito aprioristicamente, ma è qualcosa da indagare sulla base della Scrittura e mediante la riflessione teologica. In termini generali occorre innanzitutto osservare che la verità dell’incarnazione richiede che il Verbo si assoggetti realmente ai condizionamenti dell’umanità assunta. Ciò, in linea di massima, comporta una reale rinuncia da parte di Gesù a trascendere ordinariamente le leggi della natura creata e delle sue condizioni di esistenza. Se fosse venuto nel mondo senza assoggettarsi alle leggi del creato e ai condizionamenti che limitano la conoscenza umana del reale, la sua incarnazione sarebbe stata una finzione, una sorta di travestimento.
Ciò, naturalmente, non significa che Gesù, nella sua conoscenza e nella sua attività, non potesse mai superare i limiti propri dell’ordine e della natura umana, che, nel suo caso, erano funzionali alla sua missione di salvezza. In determinate circostanze, anzi, proprio l’adempimento della missione rendeva opportuno che, nel suo operare, Egli oltrepassasse i limiti naturali imposti dall’umanità assunta. Gli esempi di eventi e di situazioni in cui Gesù ha trasceso le leggi della natura e ha manifestato la sapienza o la potenza divina non mancano nel vangelo: nei miracoli la potenza divina di Cristo, pur dispiegandosi attraverso la sua umanità, andava ben oltre ciò che è possibile alla natura creata. Qualcosa di simile accadeva nell’ambito della conoscenza, quando elementi della sua scienza divina, inaccessibili di per sé all’esperienza dei comuni mortali, erano comunicati al suo intelletto umano affinché Egli se ne servisse per il compimento della sua missione. I vangeli, infatti, attestano che Gesù aveva spesso conoscenze di natura soprannaturale, come, ad esempio, la percezione dei pensieri reconditi di alcune persone. In questo contesto va rilevata soprattutto la sua conoscenza di Dio e della sua propria missione.
Il principio teologico di incarnazione e il principio di missione, uniti agli esempi cui abbiamo accennato, attestano che la vita di Gesù aveva una somiglianza reale e vera con la nostra, ma aveva anche una singolarità, un’unicità propria e specifica della sua persona. La sua somiglianza con noi, la sua condizione umana comportavano limiti e restrizioni che si estendevano all’ambito della conoscenza5, ma la sua singolarità gli consentiva di accedere al mistero di Dio e del suo disegno (benché gli esperti non concordino sul modo in cui ciò potesse avvenire). Ne consegue che Gesù “sapeva”, ma “in una certa misura”: conosceva quanto era necessario per svolgere il suo ministero tra gli uomini, avvertiva in Sé il mistero di Dio e del regno che avrebbe instaurato nel mondo, ma riguardo a tutto il resto spesso doveva informarsi e imparare secondo la normale condizione umana. È logico che conoscesse il mistero di Dio, perché veniva dal Padre, ma altrettanto logico è che, data l’impossibilità dell’onniscienza umana, Egli si informasse per conoscere la realtà e apprendesse. Il suo essere vero Dio e vero uomo si rifletteva, dunque, sulla sua conoscenza terrena.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che ciò che Gesù faceva sulla terra (la missione di salvezza) era mediato dalla sua conoscenza umana, perché,...