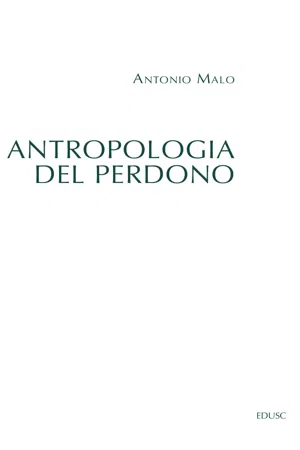![]()
Capitolo 3
I limiti del perdono
l. 3Dopo l’analisi della natura del perdono come bene relazionale che crea nuovi spazi di libertà nella vittima e nell’offensore, possiamo tornare ad esaminare le obiezioni che sono state fatte nei confronti della stessa possibilità di perdonare. Queste sono principalmente di due generi: quelle riguardanti le sue condizioni di possibilità, che corrispondono a ciò che qui chiamerò i limiti formali, ossia quei limiti che si riferiscono all’essenza o forma del perdono; e quelle riguardanti la relazione fra gli agenti, la vittima e l’offensore, che corrispondono a ciò che qui chiamerò i limiti relazionali, ossia quei limiti che dipendono da un cattiva relazione.
Come cercherò di mostrare, queste obiezioni, oltre a non intaccare il perdono né formalmente né esistenzialmente, possono essere superate grazie all’idea del terzo, come origine e destino del perdono.
3.1 I limiti formali
l. 8Derrida ha presentato la critica più demolitrice sulla possibilità del perdono. Egli infatti sostiene che il dono, di cui il perdono è la perfezione, nella sua purezza diventa impossibile, perché le sue condizioni di possibilità (lo spazio, il tempo, e l’intenzionalità) lo annullano nel mondo fenomenico, cioè lo rendono impossibile. Ciò nonostante, Derrida sostiene la necessità di pensare il dono in tutta la sua purezza, perché altrimenti non si potrebbe neppure usare questo termine nel linguaggio ordinario. Cercheremo di dimostrare come la sua tesi di un dono puro che può essere solo pensato – ma non vissuto – come orizzonte dell’impossibile, ponga una grande ipoteca sulla realtà del dono e, quindi, del perdono. Per cui, sarà questa tesi la prima ad essere analizzata , con l’aiuto della critica ad essa fatta da Marion .
3.1.1 Imperdonabile come riconoscibile
l. 12Con Derrida, come sopra esposto, il dono diventa l’evento impossibile, che rompe il ciclo economico, di debito e credito, di colpa e di punizione. Per quale motivo il dono è impossibile?
Secondo Marion, ciò è dovuto al fatto che Derrida considera il dono dal punto di vista del principio di ragione sufficiente, ossia della causalità efficiente. Ecco, perché Derrida, nel riferirsi al dono fenomenico, parlerebbe di identità e delle «quattro fasi della causalità che l’economia segue nel suo regime metafisico»1. Egli ritiene che l’identità del dono dipenda dalle quattro cause classiche: efficiente (il donatore), materiale e formale (il dono stesso come realtà) e finale (l’intenzione del donatore)2. Perciò, se una di esse viene meno, il dono perde l’identità e, di conseguenza, la possibilità di essere pensato. Ma se il dono mantiene la sua identità, lo si fa rientrare nel ciclo economico, in quanto viene riconosciuto come qualcosa e, quindi, trasformato in oggetto di scambio. Ed ecco, il paradosso: il dono reale, cioè causato, diventa impossibile.
A parere di Marion, questo paradosso non corrisponde alla realtà del dono. Esso sarebbe dovuto al tentativo derridiano di razionalizzare il dono mediante la ricerca di una causa della sua esistenza, il che lo renderebbe qualcosa d’impossibile, giacché – e, in ciò, Derrida avrebbe ragione – il dono non ha nessuna causa. Infatti, se fosse causato, non sarebbe dono, perché sarebbe necessario, ma il dono non è necessario, perché è gratuito, libero; e, quindi, non esiste alcuna necessità (obbligo o dovere) né di donarlo né di riceverlo. Il principio di ragione sufficiente, quindi, non può spiegare la realtà del dono. Ciò, però, non significa che il dono manchi di ragione e, di conseguenza, di condizione di possibilità, ma piuttosto che la sua ragione di essere non va cercata nella causalità, nello scambio: dare qualcosa per riceverne un’altra. La ragione del dono è la sua gratuità.
Perciò, continua Marion, il dono non può avere identità né essere riconosciuto dal donatore né dal ricevente, perché riconoscerlo equivale ad identificarlo come dono e, quindi, ad una specie di ritorno – anche se solo dal punto di vista della coscienza –, che lo annulla, perché lo reintroduce nel ciclo economico dello scambio. Qualcosa di simile accade con la restituzione del dono al donatore da parte del ricevente. Restituire il dono, infatti, significa il dare, il ricevere e il ritornare qualcosa con un’identità precisa. Il dono, però, supera qualsiasi identità, identificazione e riconoscimento perché si trova al di là dell’intenzionalità della coscienza del donatore e del ricevente, come si osserva nel dono a un ricevente anonimo – per esempio, ad un’organizzazione caritatevole – o con una destinazione universale (comunità, terra, famiglia, generazione futura). In tutti questi casi, il ricevente rimane invisibile, senza avere alcun volto e, quindi, al di là dell’intenzione del donatore. Un caso particolare di non riconoscimento del dono è quello che si dà nell’inimicizia, quando il ricevente non è in grado di restituire e neanche di accettare il dono, perché è un nemico, cioè una persona che rende male per bene. Per questo motivo, Marion chiama il nemico l’alleato del dono, e l’amico il suo avversario.
Anzi, egli va oltre: non solo afferma che il dono – per essere tale – non dovrebbe essere restituito, ma anche che lo stesso ricevente dovrebbe essere sospeso fenomenologicamente, poiché può essere assente, anche come nemico. Ciò accade quando il dono è perso, abbandonato o non accettato dal destinatario, come quando si dà ad un ricevente ingrato che, oltre a rifiutare di pagare il debito generato dal dono, non accetta nemmeno il fatto di quel debito. Ma anche in questa situazione il dono resta dato, perché soddisfa l’unica condizione che Marion accetta da Derrida, quella del non riconoscimento.
Orbene, potrebbe sembrare che secondo Marion solo un dono rifiutato sarebbe un vero dono e, dunque, che l’accettazione sarebbe contraria all’essenza del dono3. Ma egli nega questo concetto, poiché un dono accettato può essere anche un dono reale. Tuttavia, in questo caso è necessaria una condizione: la sospensione del ricevente perché assente, come nell’anonimità, nell’inimicizia o nell’ingratitudine, o la sua sospensione perché si tratta di un ricevente escatologico, come il Giudice supremo o Cristo, che appare come l’unico ricevente delle buone azioni, o si tratta di un ricevente universale (come la patria, la società, l’umanità). In tutti questi casi, il dono, anche se accettato, è libero da ogni singolo ricevente. Così si realizza la perfetta figura del dono, quella cioè di un dono che non fa alcuna distinzione di persone, è completamente indifferente al merito e al demerito del ricevente e si dà in piena ignoranza di un’eventuale reciprocità4.
Nella sospensione universale del ricevente, d’altro canto, Marion individua due funzioni: la prima, quella di permettere al ricevente di sostenere l’eccesso che si dà sempre nel dono, in modo da poter accettarlo; la seconda, quella di evitare qualsiasi dipendenza dal donatore da parte del ricevente. Invece, quando non si da questa sospensione, il destinatario precede il dono; lo stesso agirà come causa e, quindi, il dono sarà annullato. Così il destinatario che si aspetta di ricevere un dono o lo chiede, diventa la sua causa efficiente. Ecco perché l’aspettativa e la richiesta (supplica, minaccia, ecc.) sono disposizioni contrarie all’essenza del dono. Il ricevente potrebbe anche agire come causa finale, quando il dono è giustamente meritato da lui per le sue buone opere o è stato fatto per misericordia nei suoi confronti. Ma anche davanti ad un ricevente umiliato o commosso, il donatore vede scomparire il suo dono, perché egli può ricevere il riconoscimento come benefattore o come persona di buoni sentimenti. E, in entrambi i casi, si dà un ritorno del dono al donatore, una specie di pagamento in termini di prestigio o virtù riconosciuta. Per evitarlo, Marion pensa che il ricevente non dovrebbe mai cercare il dono. Anzi, il ricevente dovrebbe scomparire, giacché la semplice presenza del ricevente rende possibile attribuirlo ad una causa e inserirlo nel ciclo economico (scambio, reciprocità, gratitudine).
Tuttavia, il marchio del dono è l’abbandono di questo da parte dal donatore. Questo abbandono totale del dono non causa nulla, ma manifesta solamente lo spogliamento del donatore di qualsiasi pretesa di proprietà (es-propriazione). Insomma, se si vuole veramente dare qualcosa, si deve perdere completamente il dono. A suo giudizio, ci sono tre figure di donazione che implicano l’abbandono del dono da parte dal donatore. La prima è rappresentata dall’eredità. In essa, il donatore aveva l’intenzione di alienare i suoi beni, cioè l’intenzione che i suoi beni fossero posseduti dal suo erede senza alcun ritorno a sé; perciò, seguendo l’ultima volontà del donatore, l’erede riceve come dono ciò che non è suo, ma è venuto a lui5. La seconda è rappresentata dal donatore anonimo, perché è sconosciuto o perché è morto: nel caso del donatore anonimo, il dono è perfetto perché lo stesso scompare completamente; nel caso del donatore morto, questi riproduce ancora di più la mancanza di intenzionalità del donatore, cioè l’incoscienza. Il donatore perfetto deve dare senza essere consapevole di se stesso come donatore. Ciò significa che il vero donatore non è mai conscio dell’effetto che il dono produce sui possibili destinatari6; per esempio, la gioia del ricevente (sportiva, estetica, erotica). Marion pensa che se il donatore avesse una minima coscienza di sé come donatore, il dono verrebbe annullato, perché ritornerebbe a lui sotto forma di riflessione del suo dare. La terza figura è collegata al ricevente di questi due tipi di donazione (eredità e donatore anonimo). Siccome in essi non vi è alcun donatore, il dono trasforma il ricevent...