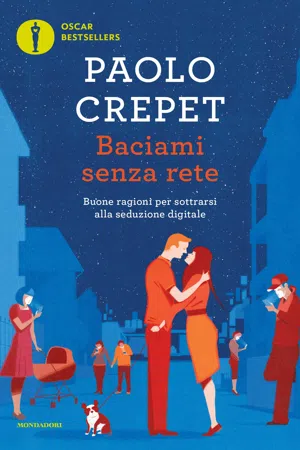Quando, nel luglio 2008, uscì su «The Atlantic» l’articolo di Nicholas Carr Is Google Making Us Stupid?, si aprì anche in Italia un dibattito nuovo e per nulla scontato.
Carr è un giornalista americano molto noto – proprio per questo articolo e per il saggio scritto l’anno successivo, Internet ci rende stupidi?, è stato candidato al premio Pulitzer –, che ha affrontato con passione e libertà il tema delle strategie legate alle tecnologie dell’informazione.
Il suo punto di vista è stato amato e osteggiato da molti scienziati e intellettuali, ma nessuno l’ha potuto ignorare. La sua tesi è semplice e anticonformista: ogni invenzione che riguarda la tecnologia della comunicazione comporta il rischio, spesso invisibile, di una diminuzione di alcune capacità cognitive dell’uomo.
Uno degli esempi citati riguarda le mappe geografiche. Prima che fossero inventate – nella Grecia antica, Tolomeo fu il primo cartografo –, l’unica possibilità che l’uomo aveva per conoscere la terra che lo circondava era basata sulle scoperte individuali e sull’esperienza, quindi sull’uso estremo degli organi di senso. Una carta geografica rappresenta un’astrazione delle conoscenze che l’uomo, precedentemente a essa, aveva accumulato attraverso la sua esperienza sensoriale. Quindi l’esistenza e la diffusione delle mappe ha inevitabilmente comportato una minore necessità di utilizzare il nostro patrimonio naturale cognitivo e sensoriale.
Lo stesso cambiamento è avvenuto – altro esempio amato da Carr – con l’invenzione della stampa. Quando Johannes Gutenberg la realizzò, intorno alla metà del Quattrocento, non furono poche le persone che videro in quella scoperta una minaccia anziché il principio di una straordinaria epoca. Hieronimo Squarciafico, coetaneo di Gutenberg, umanista veneziano e tipografo anch’egli, ritenne che la grande diffusione dei libri e il loro minor costo consentiti da quell’invenzione sarebbero stati causa di «pigrizia» intellettuale, comportando una grave «fragilità della mente» di intellettuali e studiosi.
Ogni scoperta tecnologica, potremmo dire seguendo il pensiero di Carr, ha comportato un’eterna, per certi versi inevitabile, contraddizione tra avanzamento e regressione, allontanando l’uomo dalle sue naturali capacità cognitive proprio mentre ne acuiva o ne rivelava nuove potenzialità. Un progresso, quello permesso dalle invenzioni tecniche, che non dovrebbe essere interpretato soltanto come una forza esponenziale e coerente, capace di spingere inesorabilmente l’umanità verso orizzonti insperati: il risultato finale è sempre dato dal confronto tra il nuovo che viene promesso e ciò che viene sottratto alla natura umana.
Alcuni scienziati hanno chiamato questo fenomeno disruptive innovation: non si tratta necessariamente di un concetto negativo, ma del prendere coscienza del fatto che vi sono delle fasi dell’innovazione – specialmente quella legata alla tecnologia – che implicano la distruzione di ciò che era stato fino ad allora acquisito. Tipico è l’esempio del cellulare che ha soppiantato il telefono fisso.
Eppure, come ho già rimarcato, nulla può essere confrontabile con ciò che è accaduto all’avvento delle tecnologie digitali. Perché la radio o la televisione hanno facilitato la nostra comunicazione, mentre Internet e i social network l’hanno stravolta.
Parlare di preoccupanti effetti collaterali della dipendenza dalla tecnologia digitale secondo molti significa soltanto creare inutili e pericolosi allarmismi. D’altronde, non sono mai stato innamorato della teoria di un complotto «pro tecnologie», che immagina un esercito di psicologi e scienziati sociali che si scagliano contro certi inutili segnali di pericolo perché ricevono chissà quali elargizioni dalle grandi case di produzione tecnologiche. Apple, Google o Samsung non hanno certo bisogno di questo per convincere milioni di cittadini del mondo a rimanere sempre connessi: è una sfida che, in buona parte, hanno già vinto.
Per fortuna, però, c’è una schiera sempre più nutrita di scienziati e di intellettuali che non sono disposti a rimanere in silenzio solo per non essere considerati degli antiquati nostalgici dei bei tempi andati (e io mi schiero di buon grado tra questi).
Qualche autore – tra i quali vorrei citare lo psichiatra tedesco Manfred Spitzer, cui si deve un libro molto interessante, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi – ha cercato, senza curarsi degli attacchi che gli sono stati sferrati anche da parte del mondo scientifico, di spiegare con competenza il pericolo che i nostri figli corrono cedendo a questa nuova forma di dipendenza.
Dal mio punto di vista vorrei aggiungere qualche notazione al dibattito in corso, senza la pretesa di essere esaustivo riguardo a questioni molto complesse. Il mio obiettivo, qui, è contribuire all’informazione che genitori e insegnanti dovrebbero avere sulle conseguenze dell’uso prolungato nel tempo di queste nuove tecnologie sulla mente umana. Effetti che suddividerei in due grandi gruppi: il primo riguarda la sfera cognitiva e comportamentale, il secondo (vedi capitolo successivo) quella emotiva e relazionale.
Il cervello funziona, per certi versi, come un muscolo: se non viene costantemente allenato, tende ad atrofizzarsi. Steven Pinker, psicologo dell’università di Harvard, sostiene che la nostra mente assomiglia, nel suo funzionamento, alla plastilina: viene modellata dalle esperienze. Quindi, meno esperienze si accumulano e più la mente fatica a funzionare, perciò s’indebolisce. Al contrario, più il cervello è allenato, più si rafforza. Questo dato è, quanto meno indirettamente, confermato anche da una recente ricerca effettuata su pazienti che hanno avuto un episodio di ictus cerebrale. Uno studio, compiuto da ricercatori dell’università di Edimburgo e pubblicato sulla rivista «Stroke», ha messo in evidenza che chi parla correttamente due o più lingue ha una probabilità doppia di recuperare la propria capacità cognitiva rispetto a chi invece non ha un cervello altrettanto allenato. Da un altro studio condotto dalla Società Britannica per l’Alzheimer emerge la conferma a questa ipotesi: la conoscenza di più lingue funziona come «fattore protettivo» allontanando, in media di cinque anni, l’insorgenza della demenza cerebrale, ha affermato Clive Ballard, coordinatore della ricerca.
Quando ero al liceo e un professore ci chiedeva di studiare, per esempio, gli etruschi, ognuno di noi, tornato a casa, doveva mettere in atto una propria strategia. C’era chi poteva rivolgersi a qualcuno in famiglia esperto della materia (nel mio caso, nessuno), oppure tuffarsi sull’enciclopedia Treccani di papà, cercare il tomo con la lettera E, leggere tutto quello che c’era scritto a proposito degli etruschi e trarne un riassunto sufficiente per superare l’eventuale interrogazione (all’epoca non esistevano nemmeno le fotocopiatrici). Senza accorgermene, mettevo in atto una serie di competenze cognitive fondamentali: attenzione strategica, analisi del testo, memoria (compresa quella visiva: così ho preparato molti degli esami di medicina, ricordandomi esattamente dove, tra migliaia di pagine, avevo visto citare quel dato concetto), capacità di sintesi.
Se oggi un ragazzo deve affrontare lo stesso compito, non è costretto a fare tutta quella fatica: torna a casa, accende il pc, va su un motore di ricerca, digita la parola «etruschi», apre, cerca di evitare il primo o il secondo link che esce (magari la pizzeria «Etruschi» che ha pagato un banner pubblicitario), copia tutto quello che ci trova scritto (che solitamente è già sotto forma di riassunto) e lo salva in formato Word, pronto per la successiva interrogazione. Tutti passaggi a basso impegno cognitivo. Ai miei tempi il cervello era obbligatoriamente in modalità «on», mentre oggi può funzionare al minimo: ciò conduce molti giovani a un’evidente «lentezza» cognitiva e comportamentale.
Credo sia capitato a molti di prendere un taxi e di accorgersi, dopo pochi minuti, che chi lo conduce non conosce affatto la zona della città dove si vorrebbe andare. L’autista digiterà il nome della via sul suo computer di bordo e inizierà ad attraversare la città: continuerà a esercitare la sua professione senza conoscere la rete di vie e di piazze che costituiscono la città ove opera e non accumulerà esperienza (che si forma più sugli errori che sulle scelte positive). Ricordo di aver visto, qualche anno fa, un’inchiesta televisiva in cui si parlava del traffico nelle metropoli. Una parte dell’inchiesta riguardava il fenomeno «leggendario» dei taxisti londinesi e di come venivano formati. In pratica, l’esame per diventare un taximan consisteva nel dover percorrere mentalmente un tragitto scelto a caso dalla commissione esaminatrice, con tanto di sensi unici, viabilità preferenziale, alternative al traffico delle ore di punta. Tutto a memoria, attraverso una sorta di mappa mentale che il candidato doveva aver immagazzinato. Quel tassista poteva certamente affermare di conoscere la sua città, ma aveva anche inconsciamente cucito con essa un rapporto emotivo, forse anche affettivo. L’avvento delle tecnologie legate alla guida (computer di bordo, navigatore) contribuisce alla perdita della memoria visiva dei luoghi e, al contempo, di ciò che di sentimentale è a questi connesso.
Quando eravamo giovani, per andare a trovare un amico o una ragazza dovevamo memorizzare una sequenza di strade: molti di quei luoghi sono rimasti dentro di noi e quando, anche a distanza di molti anni, capita di ripercorrerli, riemerge una sensazione piacevolmente affettiva, quasi amorosa.
Alcuni insegnanti mi dicono che a scuola s’imparano sempre meno frequentemente le poesie a memoria e non si usa nemmeno più fare i riassunti: quindi possiamo temere che la scuola non riesca a fronteggiare i problemi creati dall’uso delle tecnologie digitali. Il risultato è una perdita secca di competenze cognitive, ma anche emotive.
049-32518: ancora me lo ricordo come se avessi composto quel numero un’ora fa. È il telefono di mia mamma, che non c’è più da oltre trent’anni: oggi non credo di ricordare il numero di telefono di nessuno, ci pensa l’agenda del mio cellulare a farlo per me. Ho meno memoria, ma anche meno occasioni per commuovermi con i ricordi.
Ai tempi della mia giovinezza anche cercare una ragazza era un compito complicato: bisognava frequentare le feste o le balere, andare con gli amici al mare nella speranza che una sera o l’altra potesse capitare il grande incontro, quello da raccontare per tutto l’inverno successivo. Bisognava imparare a essere spigliati, avere una bella parlantina e interessanti argomenti di conversazione, saper ballare, vestirsi con qualche capo alla moda. Oggi per un ragazzo o una ragazza, di qualsiasi orientamento sessuale, la faccenda è molto facilitata: basta scaricare una delle tantissime app – come per esempio Tinder – e il gioco lo si può fare anche senza uscire di casa: il cellulare si trasformerà in una sorta di radar in grado di segnalare tutti i potenziali «incontri» nel raggio che si è prescelto. Anche un timido può, anche chi non ha esplicitato le proprie preferenze sessuali.
Negli anni Sessanta, ho frequentato molto le sale biliardo, ricordo quelle a Soho, Londra, luoghi non raccomandabili per le ragazze «per bene» ma molto educativi per noi giovani di allora. Imparavi a conoscere le tipologie umane molto più in quelle sale piene di fumo che in un’aula universitaria. Oggi si può giocare a biliardo scaricando l’ultima app sull’iPad: non fai cattivi incontri, non respiri aria malsana, ma non impari nemmeno a conoscere il mondo. Anche in questo caso, la tecnologia digitale promette e toglie, aggiunge e sottrae.
Chi pensa di non possedere naturalmente alcuno skill psicologico dovrà forzatamente accentuare la propria dipendenza da ciò che gli semplifica il compito, ovvero la tecnologia.
Si viene così a formare una sorta di cortocircuito dal quale è molto complicato trovare una via di fuga. Le tecnologie digitali «impoveriscono» alcune delle nostre facoltà (pur arricchendone altre) e modificano i nostri comportamenti reattivi, che necessitano sempre di più di ciò che ci impoverisce.
È una delle modalità attraverso le quali Manfred Spitzer spiega come si sta diffondendo la «demenza digitale», ma è anche un argomento utilizzato da Nicholas Carr sia nel libro già citato, Internet ci rende stupidi?, sia nel successivo La gabbia di vetro.
A tutto questo, qualcuno potrebbe rispondere che la tecnologia digitale permette, dal punto di vista cognitivo, cose di cui la «generazione prefotocopiatrici e precomputer» non poteva godere: per esempio, il multitasking, ovvero la possibilità/capacità di eseguire più compiti simultaneamente.
È vero, un ragazzo dei miei tempi poteva solo leggere una pagina dell’enciclopedia alla volta, e poi successivamente approdare a un altro testo. Oggi si possono fare più cose insieme, ma a quale prezzo?
Ho parlato in alcuni miei scritti precedenti di un fenomeno che ho chiamato «surfing mentale». Mi spiego con un esempio. Quando un signore degli anni Sessanta o Settanta voleva ascoltare Mozart a casa propria, doveva mettere sul giradischi il long-playing prescelto e disporsi all’ascolto del brano per tutta la sua durata: avrebbe potuto sollevare la puntina e passare a un brano successivo, rischiando però di rovinare il solco registrato. Qualche lustro dopo è arrivato sul mercato il cd, con il quale era più facile interrompere un brano e passare a un altro. L’iPod ha reso questa fruizione ancora più frammentabile e nevrotica. Il risultato è che una melodia può essere costantemente interrotta, quindi l’ascolto diviene, inevitabilmente, superficiale. Per conoscere Mozart occorre averlo ascoltato interamente, per averne una vaga idea basta ascoltarne dei brevi brani.
Lo stesso vale per la lettura di un libro. Il mio amico Sebastiano Bagnara, tra i massimi psicologi italiani ed esperto dei meccanismi cognitivi che sovrintendono all’attenzione, mi ha recentemente confidato che se dovesse indicare ai suoi attuali studenti il testo d’esame che consigliava all’inizio della sua carriera universitaria (più di trent’anni fa), questi ragazzi e queste ragazze avrebbero serie difficoltà. La ragione è semplice: è diventato difficile affrontare un volume di oltre 800 pagine.
Non credo sia un caso che un corso di studi come medicina sia oggi organizzato in modo così diverso da quello che ho seguito io quarant’anni fa. Una volta gli esami non si potevano spezzare in tre o quattro parti. Clinica medica era un unico esame che comportava lo studio di 3000-4000 pagine, quindi occorreva acquisire una particolare forma mentis, dotata di una memoria prodigiosa e di una superba capacità d’attenzione. In realtà, queste non erano caratteristiche del cervello di un genio, ma più semplicemente di quello forgiato da anni di studio basato su tali qualità: l’esercizio dell’ultimo momento non avrebbe mai potuto condurre agli stessi risultati.
Per la stessa ragione credo che ben pochi giovani potrebbero affrontare Guerra e pace di Tolstoj. I tempi del romanzo, infatti, non si addicono a una mente formata non per sedimentare conoscenza specifica, ma per altro, per fare il «surfing mentale», per accumulare il più velocemente possibile informazioni di ogni tipo.
Il surfista scorre veloce sull’onda, non nell’onda. Il surf è metafora di efficienza, non di efficacia, di superficialità e non di approfondimento. Oggi la formazione stessa di un’intera generazione è basata sul multitasking, ovvero sul cercare di sapere «non tutto, ma di tutto», come recitava una vecchia pubblicità di un’enciclopedia.
Basterebbe osservare un adolescente mentre sta studiando. Ha davanti a sé sulla scrivania un libro, con accanto uno smartphone e forse anche un tablet e un pc acceso. La sua capacità di attenzione è continuamente distratta, frammentata e frustrata da ciò che i suoi device trasmettono: messaggi, foto, chiamate, mail. Il tempo di formazione e di apprendimento è incessantemente interrotto, non ci può essere continuità, quindi quel ragazzo sarà portato a parcellizzare le sue nozioni e le relazioni con esse. Il suo sarà un silenzio intermittente, compreso fra un trillo e un’emoticon, esattamente come risulterà la sua base formativa.
La teoria dell’appiattimento cognitivo come diretta conseguenza dell’uso eccessivo dei social – in particolare di Facebook e Snapchat – è stata recentemente riproposta da un articolo, apparso a firma di Elsa Vulliamy su «The Independent» nel marzo 2016, in cui si fa riferimento soprattutto alla velocità della comunicazione che non permette di «digerire» i suoi contenuti. È come se in una tempesta di grandine qualcuno volesse contare i chicchi che cadono. Famosa, a questo proposito, una battuta di Albert Einstein al Collège de France. Con lui era stato invitato un astronomo. Alla fine della conferenza del suo collega, Einstein gli chiese: «Capisco che lei si sia innamorato delle stelle, ma non capisco perché si ostini a contarle…».
Vulliamy sostiene che «l’ipotesi dell’appiattimento» predice un futuro inquietante per le future generazioni: «L’accesso continuo a Internet, i mezzi sempre disponibili per rimanere connessi e i social media che ci tengono costantemente in contatto con gli altri porteranno a un calo drammatico del pensiero riflessivo». Il problema non riguarda soltanto i più giovani: a mano a mano che utilizziamo la comunicazione veloce, ci abituiamo allo stesso tempo a un pensiero analogamente breve e veloce. Ciò causerà, continua la giornalista, un declino della riflessione, che a sua volta contribuirà a diminuire l’importanza della moralità e ad aumentare la rilevanza dell’edonismo e della cultura dell’immagine.
Per suffragare questa ipotesi, la Vulliamy cita uno studio p...