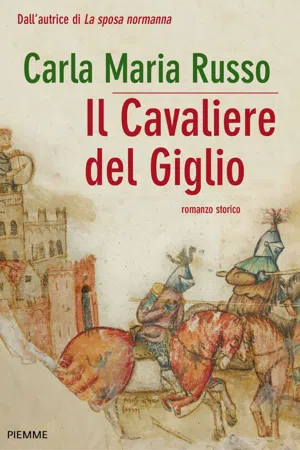Solo Poggibonsi e Siena ebbero il coraggio di sfidare l’ira di Firenze e accogliere gli esuli fiorentini.
Dall’estate del 1258 ben nove maschi della famiglia Uberti – Farinata con i quattro figli maggiori, Neri con il figlio Azzolino e due cugini, Tolosatto e Neri Boccalata – furono ospitati dal potente Provenzano Salvani, il vero padrone di Siena, amato e appoggiato dal popolo per la sua audacia, ricchezza e prestigio.
In realtà Provenzano covava verso i fiorentini un odio profondo e un acuto desiderio di distruggerli, ma ammirava a tal punto le virtù militari di Farinata da adoperarsi con tutte le forze per guadagnare alla sua città un combattente di quella tempra.
La decisione senese di aprire le porte agli esuli suscitò a Firenze furore e rabbia. Oltre alla recente, tassativa diffida promulgata dal Consiglio degli Anziani nei confronti di tutti i Comuni toscani, esisteva con Siena anche uno speciale trattato stipulato nel luglio del 1255, che obbligava entrambe a respingere i rispettivi fuorusciti. Bruciava ai fiorentini che proprio a Siena si fossero rifugiati Farinata e Neri degli Uberti: un vantaggio inestimabile per il nemico di sempre, se si fosse giunti alla guerra.
Per questo il Comune fece fuoco e fiamme. Gridò, minacciò, inviò a Siena due esperti giuristi, Alberto Trinciavegli e Jacopo Gherardi, per consegnare alle autorità senesi un elenco di nomi dei quali, in forza dell’accordo vigente, si pretendeva l’immediata estradizione a Firenze: i nove Uberti.
Le autorità senesi li lasciarono strillare. Poi, con malcelata ironia, replicarono che, a loro modo di vedere, i motivi dell’espulsione degli Uberti da Firenze «non rientravano fra quelli contemplati nel trattato, pertanto non si consideravano obbligati a ottemperare».
Gli ambasciatori allora, persa la pazienza, «avevano preso a chiamarli fedifraghi e mentitori», a urlare che Firenze avrebbe mostrato come venivano puniti i traditori e che, questa volta, neanche l’Onnipotente li avrebbe salvati dalla vendetta dei fiorentini.
Quando l’insolente risposta senese fu riferita al Consiglio degli Anziani, l’indignazione fu anche maggiore. Tanta infamia andava punita, a qualsiasi costo. Siena aveva firmato la propria condanna a morte. E la spada di Farinata degli Uberti non sarebbe stata sufficiente a salvarla.
Fomentati dalle proteste degli Anziani, ira e sdegno montarono a gran velocità in una città già molto imbaldanzita dal seguito di folgoranti vittorie raccolte negli ultimi anni.
«A Siena! A Siena! Andiamo! Andiamo!»
Per le vie di Firenze non risuonava altro grido. Nelle assemblee, il popolo riunito lo innalzava fino al cielo. Solo poche voci si levavano a rimprovero, ricordando che i trionfi dell’esercito fiorentino negli ultimi cinque anni erano da ascrivere tutti al capitano Farinata degli Uberti, che ora combatteva sul fronte opposto. Ma nessuno prestava loro ascolto.
Le ostilità vennero presto dichiarate. Ognuna delle due città cominciò ad armarsi. Firenze inviò ambasciatori in qualunque stato italiano o europeo in cui sperasse di trovare alleati. Furono intavolate trattative persino con Corradino, il bimbo di sei anni nipote di Federico II, legittimo erede al titolo imperiale dopo l’improvvisa, prematura scomparsa del padre Corrado, nel maggio del 1254.
Anche Siena e i fuorusciti ghibellini si impegnarono a cercare alleanze. Nell’unica direzione possibile: Manfredi di Svevia, figlio illegittimo di Federico II, impossessatosi dell’Italia del Sud nonostante le recriminazioni papali e le proteste del nipote Corradino, e deciso a ricostituire sotto il proprio scettro l’antico e glorioso Regno Normanno della nonna Costanza: una monarchia indipendente tanto dall’Impero, quanto dalla Chiesa, primo nucleo di uno stato nazionale italiano.
Nel maggio del 1259, un’ambasceria guidata da Farinata si recò al suo cospetto per convincerlo a fornire appoggio agli alleati ghibellini, la cui sopravvivenza restava indispensabile anche per le ambizioni del sovrano. Manfredi non sapeva se fidarsi di Farinata. Conosceva bene i pruriti legalitari degli Uberti, gente tutta d’un pezzo, da sempre fedele all’imperatore. Lui, a ben vedere, sedeva su un trono che sarebbe spettato a quell’imbelle del nipote. Chi gli garantiva che, dopo avergli strappato aiuti, in futuro non si schierassero per l’erede legittimo e l’abbandonassero al suo destino? E quali aiuti, poi? Le risorse erano talmente ridotte che non poteva sperperarne la più modesta quantità. Fece attendere la delegazione per diversi giorni, prima di ammetterla alla sua presenza.
Farinata incontrava il figlio di Federico II per la prima volta. Lo dicevano un giovane molto coraggioso, somigliante al padre soprattutto nel carattere. Fisicamente era persino più bello, avendo fuso in sé i tratti normanni ereditati dagli Altavilla con l’incantevole bellezza della madre, Bianca Lancia.
Re Manfredi ascoltò le parole di Farinata, poi gli comunicò la propria decisione.
«Una schiera di cento mercenari tedeschi. Non uno di più. Prendere o lasciare.»
Farinata e i suoi rimasero esterrefatti: cento cavalieri? A cosa serviva un aiuto così esiguo? I guelfi stavano mettendo assieme un esercito di proporzioni strabilianti e il sovrano offriva… cento cavalieri!
«È un insulto! Un’elemosina che offende il nostro orgoglio senza offrirci alcun sostegno. È più dignitoso rifiutare» protestarono tutti. «Vergogna! Noi siamo pronti a mettere in gioco le sostanze e la vita stessa, per difendere l’Impero e gli Svevi. E Manfredi ci offre cento cavalieri! Andiamo via. Costui è un cieco, incapace di valutare il grave pericolo che sovrasta anche lui.»
«Avete ragione» li calmò Farinata. «Sarei tentato anch’io di respingere con sdegno l’offerta. Ma cosa ne caveremmo? In questo momento non dobbiamo curarci dell’offesa che subiamo ma dell’obiettivo che vogliamo raggiungere. In guerra è importante essere numerosi, ma ancor di più scaltri. Noi siamo obbligati a usare l’astuzia, visto che non possiamo contare sulla forza. Accettiamo di buon grado l’offerta del sovrano. Vedrete che escogiteremo una strada per indurlo a concederci un aiuto più sostanzioso. L’esperienza mi ha insegnato che gli uomini importanti spesso sono mossi più da un’offesa al loro orgoglio che da un grave pericolo.»
Così i cento cavalieri partirono, dietro l’insegna del re.
I fiorentini intanto si sentivano a tal punto sicuri e fiduciosi della propria forza che, nell’aprile del 1260, senza neppure attendere che giungessero tutti i rinforzi promessi, annunciarono l’inizio della campagna militare contro Siena. Il diciannove di quello stesso mese, l’esercito mosse alla volta di Colle Val d’Elsa.
A Siena la sorpresa fu grande e il panico anche. Nessuno si aspettava che le ostilità venissero aperte con tanto anticipo e la città era molto lontana dall’essere pronta a parare il colpo.
L’esercito fiorentino, senza forzare le tappe, giunse a destinazione alla metà di maggio e si accampò sulle alture di Vico Alto e Vico Bello. Era guidato dal podestà di quell’anno, Jacopo Rangoni da Modena, e da una parte dei componenti il Consiglio degli Anziani. Ostentavano tutti un grande ottimismo, fiduciosi di poter ripetere l’impresa di ventinove anni prima, quando le armate fiorentine, accampate su quelle stesse colline, avevano violato le mura nemiche.
Anche i senesi più anziani, alla vista dell’esercito del Giglio collocato di nuovo così a ridosso della città, ripensarono con ansia al giorno terribile in cui Porta Camollia fu espugnata e Siena si salvò solo grazie al generoso appoggio del comandante fiorentino. Vero era che l’artefice dell’esaltante vittoria combatteva ora nelle file senesi, ma questo costituiva l’unico punto a favore: per il resto, la sproporzione fra le forze in campo era impressionante.
All’alba del 18 di maggio, le truppe fiorentine, in assetto di guerra, iniziarono la marcia di avvicinamento alle mura nemiche. Avevano fatto poca strada quando, all’altezza del monastero di Santa Petronilla, si verificò un evento del tutto inatteso. All’improvviso, una schiera di cavalieri, all’incirca un centinaio, agitando l’insegna dell’usurpatore Manfredi, lanciando grida raccapriccianti, brandendo asce, spade, lance e quant’altro, si abbatté sulle prime file dei soldati in marcia con la furia devastante di un fiume in piena: in pochi istanti ne venne falcidiato un numero così impressionante che gli altri rincularono, sbandarono e, atterriti da tanta cieca ferocia, si diedero a una fuga precipitosa sotto gli occhi allibiti dei propri comandanti, ai quali fu necessario parecchio tempo e molta energia per costringerli a fermarsi e affrontare il nemico. Si stavano coprendo di vergogna: possibile che un pugno di cavalieri fosse in grado di sbaragliare da solo l’invincibile esercito del Giglio? Alla fine, il manipolo di tedeschi fu circondato da ogni parte e massacrato fino all’ultimo uomo, mentre i soldati sfogarono la rabbia per l’umiliazione patita infierendo sui cadaveri e sull’insegna di re Manfredi, trascinata nella polvere, insozzata e fatta a brandelli.
Farinata assistette al massacro senza battere ciglio. Quindi indirizzò una missiva a Sua Maestà, cercando di dosare in modo opportuno severità ed enfasi.
«Sire, con il cuore straziato mi accingo a infliggervi un grande dolore. I cento cavalieri offerti a sostegno delle forze ghibelline, sono stati attratti in un’imboscata e massacrati fino all’ultimo uomo. Hanno preferito la morte sul campo di battaglia a una fuga che disonorasse la Maestà Vostra. Pur nella disfatta, hanno inflitto perdite così ingenti alle soverchianti forze avversarie che, se il loro numero fosse stato un poco più consistente, oggi saremmo forse a gioire di una strepitosa vittoria sui Comuni nemici.
Purtroppo, sire, questa non è l’unica e neppure la più dolorosa notizia di cui sono l’infausto latore. I guelfi hanno catturato la vostra insegna e l’hanno resa oggetto dei più turpi, volgari, offensivi oltraggi che una soldataglia imbaldanzita dalla vittoria possa concepire, coinvolgendo nell’ingiuria anche il vostro nome e maestà di sovrano.»
Come Farinata sospettava, la lettera, giunta a destinazione, suscitò nel re un tale sdegno che, seduta stante, deliberò l’invio di un nuovo e ben più sostanzioso contingente militare, con l’ordine di reclutarlo tra i più feroci combattenti di cui disponesse la milizia. Per esempio, tra i saraceni di stanza a Lucera di Puglia. Anzi no, meglio tra gli stessi mercenari tedeschi: di sicuro avrebbero accolto con tale indignazione la notizia della sorte toccata ai compagni che sarebbero stati ben lieti di vendicarli.
Proprio quanto a Farinata premeva di ottenere.
A detta di alcune malelingue, non vi era dubbio che i mercenari di Manfredi fossero caduti in una trappola: ordita tuttavia non dai guelfi, bensì da Farinata in persona, cui alcuni abili e fidati collaboratori, il fratello Neri in testa, avevano tenuto mano con grande maestria. Il capitano aveva allestito uno sfarzoso banchetto protrattosi per tutta la notte e innaffiato da vino a volontà. Poco prima dell’alba, quando i cavalieri tedeschi erano ormai rimpinzati di cibo e soprattutto ottenebrati dalle inesauribili libagioni, nella sala erano state introdotte bellissime e procaci prostitute con l’ordine di eccitarli fino ad averli in completa balìa, senza tuttavia concedere alcuna soddisfazione alle loro voglie se prima non avessero fornito una prova inoppugnabile di virilità. E quale occasione migliore, avevano insinuato quelle con malizia, che uscire dalle mura e sfidare l’esercito guelfo in marcia? I convitati senesi e fiorentini avevano accolto la proposta con ululati di stupore, attestazioni di incredulità, battute di sfida, scommesse audaci e promesse di incredibili ricompense, se davvero avessero mostrato un tale coraggio, aggiungendo ulteriori stimoli a quelli già offerti dalle avvenenti madonne. I mercenari avevano abboccato all’amo e si erano precipitati a sfidare da soli l’armata nemica al gran completo.
Qualunque fosse la verità, l’episodio destò grandissimo scalpore e produsse una conseguenza persino più stupefacente del nuovo, sostanzioso aiuto accordato da re Manfredi: il poderoso esercito fiorentino, recuperati armi e bagagli, per il momento levò il campo e se ne tornò a Firenze con le pive nel sacco. Lo scontro con quel pugno di tedeschi aveva reso palese ai condottieri che forse esso non era né così pronto, né così invincibile come si sperava.
La mancanza di un comandante della tempra di Farinata degli Uberti apparve subito evidente a tutti. Privi di quella mano sicura, i soldati sembravano titubanti, incerti, paralizzati dalla confusione e dalla paura. I primi ad ammetterlo furono proprio alcuni fra i più valorosi e consapevoli combattenti di parte guelfa, come Tegghiaio Aldobrandi degli Adimari, il quale aveva militato per molti anni agli ordini di Farinata e, pur appartenendo a un diverso schieramento, ne riconosceva e apprezzava le grandi doti di uomo, soldato e stratega. Per questo era ben consapevole di quanto quella perdita fosse grave per Firenze e vantaggiosa per il nemico. Sfidando l’impopolarità, aveva già più d’una volta manifestato la propria disapprovazione per la leggerezza con cui venivano condotte le operazioni militari e la superficialità che dimostravano coloro cui era affidata la guida della città. Dunque non si rammaricò affatto quando furono costretti a una pausa di riflessione.
Durante l’estate del 1260, mentre a Firenze si lavorava con alacrità per allestire un esercito ancora più forte e agguerrito, a Siena Farinata accendeva l’animo degli esuli fiorentini incitandoli alla lotta, della quale si sforzava di mettere bene in chiaro gli obiettivi.
«Non combattiamo contro Firenze ma contro i guelfi e la loro idea di Stato, sottomesso alla tutela del papa. L’esito di questo scontro condizionerà non solo il destino di noi ghibellini ma la storia e il futuro dell’Italia intera. Chi vincerà, imporrà agli altri il mondo in cui vivremo domani. Se saranno i guelfi, il cammino per affrancare lo Stato dalla sottomissione alla Chiesa si rallenterà di secoli. Per questo mi batterò fino alla morte per sbarrare loro il passo.»
Con il passare delle settimane, però, l’impresa di trionfare sulla parte avversa appariva sempre più disperata. Per tutto il mese di giugno e luglio, le spie senesi inviarono rapporti sconfortanti. Firenze era riuscita a rinforzare ancora di più un esercito già considerato imbattibile.
Siena inviò messaggeri ovunque per sollecitare aiuti, ma invano: gli altri Comuni toscani non nutrivano alcuna fiducia nelle possibilità di successo dei senesi e preferirono sottomettersi alle ingiunzioni di Firenze o addirittura allearsi a essa. Fece eccezione solo la fedele Poggibonsi, il cui piccolo contingente si sommò a quello fornito da Manfredi: ottocento cavalieri tedeschi, armati ed equipaggiati di tutto punto, giunti agli inizi di luglio al comando del conte Giordano Lancia. Questi, tuttavia, pose un’irrinunciabile condizione: gli uomini sarebbero rimasti al servizio di Siena solo fino a quando avessero ricevuto vitto e alloggio adeguati e il soldo regolarmente pagato a spese dei senesi. Non un giorno di più.
La borghesia cittadina più agiata, con grande spirito di sacrificio, si dichiarò subito pronta ad addossarsi i costi e avviò una tassazione forzata al proprio interno. Fatta la conta delle risorse disponibili, si vide che sarebbero bastate a mantenere il contingente per tre mesi.
«Dobbiamo stanare i guelfi e indurli a combattere entro questo arco di tempo» spiegò Farinata ai compagni d’esilio, in tutta segretezza. «Per quanto assurdo possa sembrar...