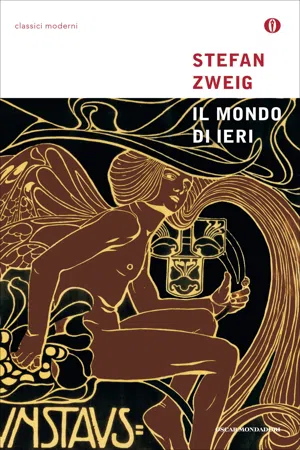
eBook - ePub
Il mondo di ieri
Ricordi di un europeo
Stefan Zweig, Lavinia Mazzucchetti
This is a test
Share book
- 392 pages
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Il mondo di ieri
Ricordi di un europeo
Stefan Zweig, Lavinia Mazzucchetti
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Dalla Vienna ottocentesca e imperiale fino ai primi anni della seconda guerra mondiale, una vibrante e sofferta rievocazione di uno spaccato della storia d'Europa. Una delle opere che diede la fama a Zweig (1881-1942).
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is Il mondo di ieri an online PDF/ePUB?
Yes, you can access Il mondo di ieri by Stefan Zweig, Lavinia Mazzucchetti in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Literature & Literary Biographies. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
L’agonia della pace
Come Sorrento non rappresentava un esilio per Gor’kij così l’Inghilterra non fu per me, nei primi anni, un esilio. L’Austria continuava a sussistere anche dopo la cosiddetta “rivoluzione” e il successivo tentativo dei nazionalsocialisti d’impadronirsi del paese con un colpo di mano e con l’assassinio di Dollfuss. L’agonia della mia patria doveva durare quattr’anni ancora. Io potevo tornare in ogni momento, non ero stato né esiliato né messo al bando. Nella mia casa di Salisburgo stavano ancora intatti i miei libri, io avevo il mio passaporto austriaco, il paese natale mi era ancora patria, io ne ero ancora cittadino con pieni diritti. Non era ancora iniziata quell’orribile condizione dell’essere senza patria, impossibile a spiegarsi a chi non l’abbia provata su sé medesimo, quel senso esasperante di procedere a occhi aperti nel vuoto, sapendo che dovunque si appoggi il piede, a ogni istante si può venir ricacciati indietro. Ero ancora al principio! Comunque, quando alla fine di febbraio del 1934 scesi alla Victoria Station, fu un altro arrivo in confronto al passato: una città in cui si è deciso di vivere assume aspetti diversi da quella dove si giunge solo come ospite. Non sapevo per quanto tempo avrei abitato a Londra, ma una cosa soltanto aveva importanza per me: tornare al mio lavoro, difendere la mia libertà interiore ed esteriore. Ogni possesso significa un legame, per questo non acquistai una casa, ma presi in affitto un appartamentino, che bastasse ad accogliere il mio scrittoio e, in due librerie, i pochi libri ai quali non ero disposto a rinunciare. Con ciò avevo in fondo tutto quello di cui un lavoratore intellettuale ha bisogno. Non rimaneva posto per altri, ma io preferivo abitare nello spazio più ristretto, pur di viaggiare liberamente di tanto in tanto: inconsciamente la mia vita era già orientata verso il provvisorio invece che verso il duraturo.
La prima sera – era già semibuio e le linee delle pareti si perdevano nel crepuscolo – rientrai nell’appartamento ormai pronto, e sussultai spaventato. Mi parve in quell’attimo di aver varcato la soglia di un’altra piccola dimora che mi ero preparato a Vienna quasi trent’anni avanti: le camere altrettanto piccole, e come unico saluto amico le file di libri alla parete e gli occhi allucinati del King John di Blake, che m’accompagnava dovunque. Ebbi davvero bisogno di qualche momento per riprendermi, giacché da anni e anni non ero risalito al ricordo di quella prima mia casa. Era forse un simbolo, che la mia vita – sino ad allora tesa ad ampliarsi – si contraeva sul passato, mentre io divenivo l’ombra di me stesso? Quando trent’anni prima avevo scelto quell’alloggio a Vienna, non ero che all’inizio, non avevo ancora creato nulla, o almeno nulla d’essenziale, nel mio paese il mio nome e i miei libri ancora non erano noti. E ora – con singolare analogia – i miei libri erano tornati a sparire dalla mia lingua, tutto quanto io scrivevo rimaneva sconosciuto in Germania. Gli amici erano lontani, l’antica cerchia spezzata, perduta la casa con le raccolte e i quadri e i libri: proprio come allora mi trovavo fra cose straniere. Tutto quello che nel frattempo avevo tentato, raggiunto, imparato e goduto, sembrava spazzato via; a più di cinquant’anni mi trovavo a un inizio, ero di nuovo lo studente che stava seduto allo scrittoio e che la mattina correva in biblioteca. Soltanto non avevo più così vivi la fede e l’entusiasmo, un riflesso grigio si stendeva sui capelli e una lieve ombra di scoraggiamento sull’anima stanca.
Esito a parlare a lungo degli anni dal 1934 al 1940, trascorsi in Inghilterra, perché con ciò già mi avvicino all’epoca nostra, che tutti abbiamo vissuto allo stesso modo, con la medesima inquietudine alimentata dalla radio e dai giornali, con le stesse speranze e gli stessi timori. Noi tutti oggi ripensiamo con scarso orgoglio all’accecamento politico di quel tempo e con vero orrore a dove esso ci ha portati; spiegare vorrebbe dire accusare, ma chi di noi ne avrebbe il diritto? Non basta: la mia vita in Inghilterra fu tutta riserbo. Sapevo che era sciocco da parte mia non riuscire a superare questo superfluo ostacolo interiore, ma io, in tutti quegli anni di semiesilio o di esilio, rimasi volontariamente escluso da ogni rapporto sociale per l’idea che non potessi, in un paese straniero, interloquire nella discussione sul nostro tempo. Se non ero riuscito a far nulla in Austria contro la stoltezza degli ambienti dirigenti, perché avrei dovuto tentarlo lì, dove mi sentivo ospite di quella brava isola, dove ben sapevo che se, in base alla nostra più chiara e informata esperienza, avessi additato la minaccia portata al mondo da Hitler, la mia idea sarebbe stata ritenuta personale e interessata? Certamente fu duro talvolta serrare le labbra e tacere di fronte agli errori più manifesti. Fu doloroso vedere come appunto di una delle virtù più alte degl’inglesi, la loro lealtà, la loro volontà sincera di prestar fede ad altri sino a prova contraria, seppe abusare una propaganda esemplarmente organizzata. Si fece credere a lungo che Hitler volesse soltanto riunire al Reich i tedeschi delle zone di confine, che con questo sarebbe stato soddisfatto e avrebbe in segno di riconoscenza estirpato il bolscevismo; questa esca ebbe un’ottima efficacia. Bastava che Hitler lanciasse in un discorso la parola “pace” perché i giornali giubilassero, dimenticando tutto quel che aveva fatto e non chiedendosi per quali fini allora la Germania così furiosamente lavorasse al riarmo. Turisti reduci da Berlino, che là erano stati abilmente guidati e lusingati, esaltavano l’ordine e il suo nuovo maestro; a poco a poco in Inghilterra si cominciò sottovoce a ritenere giustificate le aspirazioni a una Grande Germania; nessuno comprese che l’Austria era la pietra angolare dell’Europa e che, non appena la si fosse eliminata, la costruzione sarebbe crollata. Io però assistevo all’ingenuità, alla nobile credulità con cui gli inglesi, e anche i loro dirigenti, si lasciavano ingannare, con gli occhi brucianti di chi aveva veduto a casa, da vicino, i volti dei nazisti e li aveva uditi cantare: «Oggi è nostra la Germania, domani il mondo intero!». Quanto più si accentuava la tensione politica, tanto più io mi escludevo dai discorsi politici e da ogni azione pubblica. L’Inghilterra è il solo paese del vecchio mondo in cui io non abbia pubblicato mai in un giornale un articolo di argomento contemporaneo, non abbia parlato alla radio né partecipato a una discussione pubblica; ho vissuto più anonimo in quel piccolo appartamento londinese che trent’anni prima, da studente, a Vienna. Non ho quindi il diritto di parlare dell’Inghilterra come valido testimone, anche perché dovetti più tardi confessare che prima della guerra non avevo mai riconosciuto la forza più profonda e autentica del paese, rimasta nascosta e rivelatasi solo nell’ora dell’estremo pericolo.
Anche con gli scrittori non ebbi molti contatti. Proprio i due con i quali avevo cominciato a legarmi, John Drinkwater e Hugh Walpole, furono rapiti precocemente dalla morte, e con i più giovani di rado m’incontravo, dacché per quel mio senso di incertezza interiore quale straniero evitavo i club e le occasioni pubbliche. Ebbi però una volta il singolare e davvero indimenticabile godimento di assistere a un duello esteriormente brillante e cavalleresco, malgrado le sotterranee tensioni, fra le due menti più acute d’Inghilterra: Bernard Shaw e H.G. Wells. Fu a un pranzo in casa di Shaw, e io mi trovavo nella situazione in parte gradevole e in parte penosa di chi ignorava la causa della tensione ben sensibile fra i due patriarchi. Già dal modo del loro primo saluto, dalla confidenza lievemente tinta d’ironia, si capì che ci doveva essere stata fra loro una differenza di idee appianata poco prima o che quell’incontro appunto avrebbe dovuto appianare. Le due grandi figure, ciascuna di esse gloria dell’Inghilterra, mezzo secolo prima nel circolo dei fabiani avevano lottato spalla a spalla per il socialismo, anch’esso allora molto giovane. Da quel tempo, conformemente alle loro ben decise personalità, s’erano staccati sempre più l’uno dall’altro, Wells insistendo nel suo attivo idealismo, costruendo instancabile la sua visione di un’umanità futura, Shaw invece considerando tanto il futuro che il presente sempre più con ironico scetticismo, mettendovi alla prova la sua acrobazia di pensiero sicuro e divertito. Anche nell’aspetto fisico con gli anni erano divenuti una sempre più viva antitesi. Shaw, un ottantenne d’inverosimile freschezza, che a tavola mangiucchiava soltanto noci e frutta, alto, magro, sempre teso, con la risata pronta attorno alla bocca verbosa e più che mai innamorato del fuoco d’artificio dei suoi paradossi; Wells, il settantenne amante della vita, più buongustaio e più comodo che mai, piccolo, paffuto, ma inesorabilmente serio anche dietro la superficiale serenità. Shaw era mirabile per aggressività, pronto a mutare rapidissimo il punto d’attacco, l’altro rimaneva sulla difesa tattica, incrollabile però, come sempre chi ha fede e convinzione. Ebbi subito l’impressione che Wells non fosse venuto soltanto per un’amichevole conversazione a tavola, ma per una specie di discussione di principio. Appunto ignorando gli sfondi del conflitto di pensiero, ne sentivo più fortemente l’atmosfera. In ogni gesto, in ogni sguardo, in ogni parola lampeggiava una volontà di accapigliarsi, talvolta solo baldanzosa, ma talvolta piuttosto seria; sembravano due schermidori che, prima di attaccarsi con energia, saggiano la propria agilità con piccoli colpi di prova. Shaw possedeva grandissima rapidità d’intelletto: sotto le sue sopracciglia cespugliose guizzavano lampi quando dava o respingeva una botta; il suo compiacersi dell’arguzia, del gioco di parole da lui in ben sessant’anni perfezionato a virtuosismo senza pari, giungeva a una forma di baldanza. La barbetta bianca vibrava nel suo riso sottilmente crudele, mentre egli, piegando un poco la testa, seguiva con gli sguardi la freccia per vedere se questa raggiungeva il bersaglio. Wells, con le guance rosse e grassocce e gli sguardi pacati e velati, dimostrava maggiore decisione e dirittura; anche la sua intelligenza lavorava con incredibile rapidità, ma egli non menava gran mulinelli, preferendo l’affondo diritto, tirato con una certa leggera naturalezza. Così continuò la partita: colpo e parata, parata e colpo, sempre mantenendo l’apparenza dello scherzo, e lo spettatore non si saziava di ammirare quel gioco di fioretti, quello sprizzare di scintille. Ma dietro il rapido dialogo, mantenuto a grande altezza, vi era una specie di accanimento intellettuale, disciplinato pur sempre, secondo la consuetudine inglese, nelle forme più urbane. C’era della serietà in quello scherzo e dello scherzo nella serietà – questo appunto rendeva la discussione tanto interessante –, era un netto contrasto fra due poli opposti, che solo in apparenza si accendeva per un dato oggetto, ma che in realtà rimaneva immutabile in un fondo e in uno sfondo a me ignoti. Comunque avevo potuto cogliere in uno dei loro momenti migliori i due uomini migliori dell’Inghilterra, e la continuazione della polemica, che si svolse poi nelle settimane seguenti a mezzo stampa, sulla «Nation», non mi procurò nemmeno la centesima parte del piacere provato assistendo a quel vivace dialogo, perché dietro gli argomenti divenuti astratti non era più visibile l’uomo vivo, l’essenza vera. Di rado ho avuto tanto godimento dalla fosforescenza che sorge per la frizione di due spiriti; in nessuna commedia ho veduto mai l’arte del dialogo usata con tanto virtuosismo come in quell’occasione, in cui si sviluppava inavvertitamente, senza teatralità e nelle forme più discrete.
In quegli anni però io vissi in Inghilterra soltanto fisicamente, non con tutta l’anima mia. Fu appunto l’angoscia per l’Europa, la preoccupazione che dolorosamente premeva sui nostri nervi che mi indusse, fra la salita al potere di Hitler e lo scoppio della Seconda guerra mondiale, a compiere molti viaggi e persino ad attraversare due volte l’oceano. Forse mi spingeva il presagio che per tempi più foschi convenisse fare scorta di impressioni e di esperienze, quante ne poteva accogliere il cuore, finché il mondo era ancora aperto e le navi potevano pacificamente segnare la loro scia sugli oceani; forse era anche il desiderio di sapere che, mentre il nostro mondo andava distruggendosi con la discordia e la diffidenza, se ne costruiva un altro; forse era un’intuizione ancora crepuscolare che l’avvenire di noi tutti, e anche il mio personale, stesse fuori d’Europa. Un giro di conferenze attraverso gli Stati Uniti mi offrì la gradevole occasione di vedere questo grandioso paese in tutta la sua molteplicità e insieme nella sua unità, da oriente a occidente, da nord a sud. Forse ancora più forte fu però l’impressione che mi venne dall’America del Sud, dove mi recai per invito del PEN Club internazionale; mai come in quel momento mi parve importante dare forza al pensiero della solidarietà umana di tutti i paesi e di tutti i linguaggi. Le ultime ore trascorse in Europa prima di questo viaggio mi diedero un grave avvertimento da recare con me. In quell’estate 1936 era cominciata la guerra civile in Spagna, che, superficialmente veduta, poté apparire una discordia interna di quel paese tragico e bello, ma che in realtà rappresentava già la manovra preparatoria dei due gruppi di potenze ideologicamente separati e pronti all’urto futuro. Io ero partito da Southampton su una nave inglese e pensavo che questa, per tenersi fuori dalla zona di guerra, avrebbe evitato il primo consueto scalo a Vigo. Con mia sorpresa entrammo invece in quel porto e fu persino concesso ai passeggeri di scendere a terra per qualche ora. Vigo era allora in mano ai partigiani di Franco e ben distante dal vero campo della lotta. Tuttavia durante quelle poche ore vidi cose che ben potevano giustificare tristi presagi. Davanti al municipio, dal quale sventolava la bandiera di Franco, stavano allineati, perlopiù con la guida di sacerdoti, dei ragazzotti in abiti contadini, evidentemente fatti venire dai villaggi vicini. Al primo momento non capii che cosa si volesse da loro. Erano operai radunati per qualche servizio obbligatorio? Erano disoccupati ai quali si dava da mangiare? Ma dopo un quarto d’ora li vidi uscire dal municipio completamente trasformati. Indossavano uniformi nuovissime, avevano fucili e baionette e sotto la sorveglianza di ufficiali vennero caricati su automobili nuove e lucenti che partirono a gran velocità. Mi spaventai. Dove avevo visto le stesse scene? Prima in Italia e poi in Germania. Anche là erano apparse d’un tratto le nuove uniformi, le nuove automobili e le mitragliatrici. E ancora una volta mi chiesi: chi fornisce, chi paga tutto questo, chi organizza quei giovani anemici, chi li aizza contro il potere costituito, contro il Parlamento e contro i rappresentanti del popolo legalmente eletti? Il tesoro di Stato si trovava, come ben sapevo, nelle mani del governo legittimo, e così pure i depositi d’armi. Queste macchine e queste armi erano quindi state fornite dall’estero, ed erano certamente giunte attraverso il vicino confine portoghese. Ma chi le aveva fornite, chi pagate? Era una nuova potenza che aspirava al predominio, era sempre la stessa potenza che operava dovunque, una potenza che amava la violenza e di essa aveva bisogno, per la quale tutte le idee da noi professate di pace, d’umanità e di concordia non erano che antiquati segni di debolezza. Vi erano dei gruppi misteriosi, appiattati nei loro uffici e nelle loro grandi aziende, che abusavano cinicamente per i loro affari e la loro volontà di potenza dell’ingenuo idealismo giovanile. Era la volontà di violenza che mirava con nuova e più sottile tecnica a portare nella nostra sciagurata Europa l’antica barbarie della guerra. Un’impressione visiva e sensibile ha sempre più efficacia sull’anima di cento articoli di giornale. Non ho mai avuto un così nitido presagio di quanto si stava preparando per l’Europa come nell’ora in cui vidi quei ragazzi senza colpa forniti di armi da misteriosi istigatori, perché andassero a combattere altri non meno innocenti ragazzi della loro stessa patria. Quando, dopo alcune ore di sosta, la nave uscì di nuovo dal porto, scesi rapido nella mia cabina. Era troppo doloroso per me guardare ancora quella terra, caduta per colpa altrui in preda alla più orribile devastazione; l’Europa intera mi apparve destinata a morire per la sua stessa follia, l’Europa, nostra sacra terra natale, culla e tempio della civiltà occidentale.
Tanto più rasserenante mi parve poi la vista dell’Argentina. Era ancora la Spagna, la sua antica cultura, protetta e conservata in una terra nuova e più ampia non ancora concimata dal sangue, non ancora avvelenata dall’odio. Lì vi era sovrabbondanza di prodotti, ricchezza sino al superfluo, vi era immensità di spazio e con ciò certezza di produzione futura. Mi sentii pervaso da un’infinita beatitudine, da una specie di nuova fiducia. Le grandi civiltà non erano trasmigrate da millenni da una terra all’altra, non si erano sempre salvati i semi, anche quando i tronchi avevano dovuto cedere alla scure, non avevano sempre dato nuovi fiori e nuovi frutti? Quanto le generazioni passate e presenti avevano creato, non andò mai perduto. Bisognava soltanto imparare a pensare in dimensioni più ampie, a calcolare in periodi di tempo più lunghi. Conviene cominciare, mi dissi, a non pensare da europei, ma al di là dell’Europa; non ci si deve seppellire in un passato morituro, ma partecipare alla sua rinascita. La cordialità con cui l’intera popolazione della nuova grande metropoli si interessò al nostro congresso mi dimostrò che non eravamo stranieri, che la fede nell’unità spirituale, alla quale avevamo dedicato il meglio della nostra vita, non era morta, bensì viveva e agiva, che nel nostro tempo delle grandi velocità l’oceano stesso non bastava a dividerci. Un nuovo compito si presentava al posto di quello antico: costruire quella comunità da noi sognata in una misura più ampia e con le sintesi più ardite. Mentre dopo quell’ultimo sguardo presago della guerra futura avevo dato per perduta l’Europa, lì, sotto la Croce del Sud, ripresi a sperare e a credere.
Un’impressione non meno grandiosa e una promessa non minore fu per me il Brasile, questo paese cui la natura fu infinitamente prodiga e che possiede la più bella città del mondo, questo paese così sconfinato che ancora oggi non lo misurano per intero le ferrovie e le strade, ma appena l’aeroplano. In Brasile il passato era rispettato con più amore che in Europa, non essendo ancora penetrato nei costumi e nello spirito della nazione l’imbarbarimento venuto con la Prima guerra mondiale. Gli uomini vivevano più pacifici e più cortesi; i rapporti anche fra le razze diverse erano meno ostili che da noi. L’uomo non era separato dall’uomo con assurde teorie di sangue, di stirpe o di origine; lì si poteva, lo si sentiva con singolare presentimento, vivere ancora in pace: lo spazio, per i cui miseri lembi in Europa lottavano gli Stati e disputavano gli uomini politici, era lì a disposizione per l’avvenire in copia smisurata. C’era una terra che ancora aspettava l’uomo il quale venisse a utilizzarla e a completarla con la sua presenza. Lì poteva continuare ed evolversi in misura grandiosa con nuove e diverse forme quello che l’Europa aveva creato per la civiltà. Con l’occhio rapito dall’infinita bellezza di quella nuova natura io avevo potuto gettare uno sguardo sul futuro.
Tuttavia viaggiare, sia pure fino ad altre stelle e ad altri mondi, non significava ancora sfuggire all’angoscia per l’Europa. Sembra quasi una perfida vendetta della natura contro l’uomo: tutte le conquiste della tecnica, con le quali egli si è impadronito dei suoi più segreti poteri, servono in pari tempo a turbarne l’anima. La tecnica ha gettato su di noi la più tremenda maledizione, impedendoci di sfuggire al presente anche per un momento solo. Le generazioni passate, in epoche di catastrofi, avevano la possibilità di rifugiarsi nella solitudine; a noi fu riservato invece di dovere apprendere e condividere ogni evento nella stessa ora, nello stesso minuto, dovunque esso si verifichi sulla sfera terrestre. Per quanto m’allontanassi dall’Europa, il suo destino mi seguiva. Giungendo una notte nel Pernambuco, con la Croce del Sud sopra di me, con uomini di colore attorno a me nelle strade, vidi un giornale con la notizia del bombardamento di Barcellona e della fucilazione di un amico spagnolo, con il quale pochi mesi prima avevo trascorso ore felici. Nel Texas, fra Houston e un’altra città del petrolio, mentre passavo rapido nel vagone Pullman, udii d’un tratto una voce inveire e urlare in tedesco: un compagno di viaggio aveva, senza saperlo, captato una stazione radiofonica tedesca e a me toccò subire, attraversando la grande pianura del Texas, una violenta concione di Hitler. Non c’era modo di sottrarsi, né di notte, né di giorno; sempre ero costretto a pensare con torturante angoscia all’Europa e soprattutto all’Austria. Sembrerà forse patriottismo meschino, che la sorte dell’Austria così particolarmente mi turbasse nell’immenso complesso pericolante, che si estendeva dalla Cina sino all’Ebro e al Manzanarre. Ma io ben sapevo che il destino dell’Europa intera era legato al piccolo paese che per caso mi era patria. Se in uno sguardo retrospettivo si tenta di fissare gli errori politici del dopoguerra, apparirà sempre come massimo quello commesso dagli uomini di Stato europei e americani insieme, non applicando, ma deformando e mutilando il limpido e semplice piano di Wilson. La sua idea era conferire libertà e indipendenza alle piccole nazioni, ma egli aveva giustamente riconosciuto come tale libertà e indipendenza non potessero esistere se non nell’ambito di un legame in una unità sovraordinata di tutti gli Stati piccoli e grandi. Non creando questa organizzazione superiore, questa effettiva e totale Società delle Nazioni, ma mettendo in atto solo l’altra parte del suo programma, l’indipendenza dei piccoli Stati, si produsse, invece che pacificazione, nuova tensione. Nulla è infatti più pericoloso della megalomania dei piccoli, e prima cura dei piccoli Stati fu infatti, appena messi al mondo, d’intrigare l’uno contro l’altro e disputarsi piccoli lembi di terra: i polacchi contro i cechi, gli ungheresi contro i romeni, i bulgari contro i serbi, mentre la minuscola Austria rimaneva in queste rivalità il più debole fra tutti al cospetto della strapotente Germania. Il povero paese mutilato e dilaniato, mentre i suoi sovrani avevano un giorno dominato l’Europa, fu proprio, lo debbo ripetere, la pietra angolare. Per me era chiaro ciò che tutti i milioni di cittadini londinesi ignoravano, che insieme all’Austria sarebbe caduta la Cecoslovacchia, e che i Balcani allora sarebbero divenuti facile preda di Hitler; che il nazionalsocialismo prendendo Vienna, in grazia della sua particolare struttura, avrebbe avuto in mano la leva con cui sollevare dai cardini l’Europa intera. Soltanto noi austriaci sapevamo con quale cupidigia nutrita di rancore Hitler aspirava a Vienna, alla città che lo aveva veduto nella più umiliante miseria e dove voleva ritornare da trionfatore. Tutte le volte quindi che rientravo in Austria per una breve visita e poi ne ripassavo il confine, traevo un sospiro: non ancora per questa volta! E mi volgevo indietro a guardare, chiedendomi se sarebbe stata l’ultima volta. Vedevo giungere la catastrofe inevitabilmente; in quegli anni, mentre gli altri prendevano in mano il giornale fiduciosamente, centinaia di volte il mattino ho avuto in cuore il terrore di aprirlo per leggervi il grande titolo: Finis Austriae. Come avevo ingannato me stesso, illudendomi di essermi già da tempo staccato dalla sua sorte! Io condivisi da lontano le sofferenze della sua lenta e febbrile agonia molto più di tanti amici dentro il paese, che ingannavano sé medesimi con le dimostrazioni patriottiche e si andavano ripetendo l’un l’altro ogni giorno: «La Francia e l’Inghilterra non possono lasciarci cadere, e soprattutto non lo permetterà mai Mussolini». Credevano alla Società delle Nazioni, ai trattati di pace, come i malati credono alle medicine dalle belle etichette. Vivevano spensierati e felici, mentre io, più chiaroveggente, mi dilaniavo il cuore.
Anche il mio ultimo viaggio in Austria non fu provocato da altro che da un simile scoppio spontaneo di angoscia interiore che la catastrofe fosse sempre più vicina. Ero stato a Vienna nell’autunno 1937 per rivedere la mia vecchia mamma e per molto tempo non avrei avuto motivo di tornare, nulla di urgente che mi richiamasse laggiù. Ma una volta, poche settimane dopo, a mezzogiorno – credo che fosse alla fine di novembre –, ritornavo a casa passando per Regent Street e comprai l’«Evening Standard». Era il giorno in cui Lord Halifax si recava in volo a Berlino per tentare per la prima volta di trattare a quattr’occhi con Hitler. Quell’edizione dell’«Evening Standard» recava in prima pagina – la vedo ancora come l’avessi davanti, il testo era in grassetto, a destra – l’elenco dei singoli punti per cui si mirava a un accordo con Hitler. Fra questi si trovava anche il paragrafo “Austria” e io lessi fra le righe, o mi parve di leggere, il sacrificio dell’Austria, giacché che cosa poteva sig...