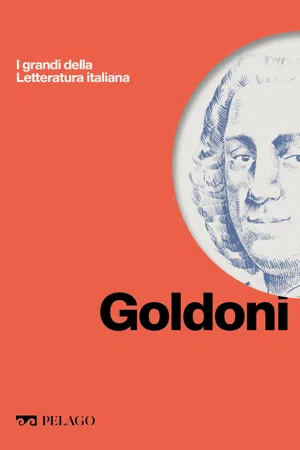![]() FOCUS
FOCUS![]()
IL SUO MONDO E LE SUE IDEE
«La mia vita non è particolarmente interessante; può succedere però che, fra un po’ di tempo, in un angolo di qualche vecchia biblioteca, si ritrovi una collezione delle mie opere. Si sarà curiosi, forse, di sapere chi fosse quell’uomo singolare che ha mirato alla riforma del teatro del suo paese, che ha messo in scena e dato alle stampe centocinquanta commedie, in versi o in prosa, di carattere o di intreccio, e cha ha visto, ancora in vita, ben diciotto edizioni del suo teatro».1
Così Carlo Goldoni apre la prefazione ai suoi Mémoires, scritti in Francia tra la fine del 1783 e i primi mesi del 1787, introducendo non soltanto alla sua vita quanto più al suo teatro, secondo una logica che ha contraddistinto tutta la sua esistenza di “autore” capace di dare attenzione non solo alla scena ma anche ai torchi, non solo allo spettatore ma anche al lettore.
Sistematicamente, Carlo Goldoni offre una interpretazione di sé e delle sue opere attraverso la lettura retrospettiva della propria vita e del proprio teatro: lo fa dall’estero e da ottuagenario, con i Mémoires, pubblicati nel 1787 a Parigi, ma anche in maniera programmatica a sostegno del proprio operato e ai fini della sua affermazione di autore come nelle pagine che vengono definite le Memorie Italiane, secondo la definizione coniata da Giuseppe Ortolani, ossia le prefazioni ai 17 volumi di commedie pubblicati nell’edizione Pasquali tra il 1761 e il 1780; ma non meno lo fa, quasi all’impronta e nel bel mezzo della sua via, registrando persino le emozioni, le polemiche, le contraddizioni del momento, come nelle prefazioni all’Edizione Bettinelli (9 volumi tra il 1750 e il 1757) che vengono poi sovrastate – perché l’edizione diventa spuria e non ottiene più il consenso dell’autore – da quelle dell’Edizione Paperini (10 volumi, 1753-1757).
Prefazioni, introduzioni, avviso ai lettori che accompagnano tutte le sue opere, che si aggiustano e modificano nel tempo, che diventano lo strumento più potente nelle mani dell’autore per indirizzare il lettore, poi lo spettatore e non di meno il critico (a lui contemporaneo ma soprattutto postero) a leggere le sue commedie, come le sue intenzioni, esattamente come il loro autore avrebbe voluto. Del resto lo scopo di Goldoni è esplicito:
“HO INTRAPRESO A SCRIVERE LA MIA VITA, NIENTE PER ALTRO, CHE PER FARE LA STORIA DEL MIO TEATRO.”
La memoria e le memorie, però, sono spesso selettive, retrospettive, omettono, sottolineano o connotano a seconda della volontà del proprio autore, nonostante il “patto autobiografico” che con il lettore vogliono stabilire. Esempio massimo forse ne è il Goldoni librettista, ossia quel Goldoni famoso oltre i confini del proprio Paese già al suo tempo, e anche prima che per le sue commedie, come autore di intermezzi, drammi giocosi, per musica e da Goldoni stesso quasi del tutto omesso nei Mémoires.
Poche le citazioni, più di una trentina le opere da lui scritte, e di grande successo all’epoca, non inserite nel catalogo posto in appendice, eppure basterebbe qualche agile clic tra le pagine del sito “Carlo Goldoni Drammi per musica” Università di Padova e Casa Goldoni (www.carlogoldoni.it), o tra i più divulgativi e numerosi siti dedicati a Goldoni librettista, per rendersi conto che la produzione di intermezzi, drammi giocosi, intrecci da opera buffa ha avuto un ruolo importante nella sua attività teatrale e che, soprattutto, lo ha accompagnato lungo tutto l’arco della sua vita. Dal primo intermezzo del 1735 all’ultimo pubblicato nel 1794, Goldoni non ha mai smesso, neanche nel periodo più “formativo” della propria riforma teatrale, di scrivere parole per musica, anzi sicuramente la sua pratica della scena buffa e musicale gli ha permesso le tante considerazioni consapevoli sul ruolo della musica in commedia descritte nel Teatro Comico e in molti altri luoghi della sua produzione metateatrale. Sicuramente, però, il suo sottacere nei Mémoires tale attività, o per lo meno non darle il rilievo che dà alle commedie, è sintomatico del suo mondo in trasformazione e delle sue idee.
Del resto Goldoni, come sottolinea Paolo Bosisio nella sua Introduzione a le Memorie, «non si peritava, verosimilmente, di discostarsi involontariamente dalle fonti, sfruttate a volte solo in superficie, pur di accrescere l’interesse della narrazione, rendendola a un tempo accattivante e coerente con la “verità” relativa ch’egli intendeva proporre, ossia con il ritratto di sé e della sua opera ch’egli desiderava autenticare, più che con la Verità assoluta della storia».2
Il racconto della vita e dell’opera di Goldoni attraverso la sua visione di sé, o l’immagine che di sé vuole restituire al mondo, rimane però la linea più interessante e curiosa da seguire.
Così faremo, avendo l’accortezza di andare oltre Goldoni ed usare le sue opere, tanto quelle di carattere teorico e descrittivo quanto quelle di chi ha studiato il suo teatro a distanza di secoli, per tracciare il profilo del maggior «reformator de’ teatri», per ricostruire in maniera anche fascinosa o, per parafrasare Laura Riccò (insieme a Pietro Chiari, drammaturgo contemporaneo di Goldoni), “come in un romanzo”, il percorso articolato e non privo di incidenti, ripensamenti, continue rivisitazioni e riscritture.3
Le tappe della riforma, infatti, non coincidono con lo schematismo programmatico: Goldoni compie balzi in avanti, ha momenti d’arresto, istanti di grande innovazione e sconfitte. Ma in questo suo sperimentare, nel suo tentativo di adattarsi agli attori che incontra e che può mettere al servizio della propria azione riformativa, confrontarsi – fino a scontrarsi – con il panorama teatrale a lui contemporaneo, italiano (Chiari e Carlo Gozzi) quanto europeo (Voltaire e Diderot), rimane costante in lui la bilancia che pesa l’armonia della sua produzione artistica, la verità che guida la sua scrittura, meglio ancora i “testi” fonti primarie di tutto il suo lavoro:
«[…] i due libri su’ quali ho più meditato, e di cui non mi pentirò mai d’essermi servito, furono il Mondo, e ’l Teatro. Il primo mi mostra tanti, e poi tanti vari caratteri di persone, me li dipinge così al naturale, che paion fatti apposta per somministrarmi abbondantissimi argomenti di graziose, ed istruttive commedie; mi rappresenta i segni, la forza, gli effetti di tutte le umane passioni; mi provvede di avvenimenti curiosi; m’informa de’ correnti costumi; m’istruisce de’ vizi, e de’ difetti, che son più comuni del nostro secolo, e della nostra nazione, i quali meritano la disapprovazione, o la derisione de’ saggi; e nel tempo stesso mi addita in qualche virtuosa persona i mezzi coi quali la virtù a codeste corruttele resiste, ond’io da questo libro raccolgo, rivolgendolo sempre, e meditandovi, in qualunque circostanza, od azione della vita mi trovi, quanto è assolutamente necessario che si sappia da chi vuole con qualche lode esercitare questa mia professione. Il secondo poi, il libro cioè del Teatro, mentre io lo vo maneggiando, mi fa conoscere con quali colori si debban rappresentar sulle scene i caratteri, le passioni, gli avvenimenti, che nel libro del Mondo si leggono; come si debba ombreggiarli per dar loro un maggiore rilievo, e quali sien quelle tinte, che più li rendon grati agli occhi delicati de’ spettatori. […] Ecco quanto ho io appreso da’ miei due gran libri, Mondo e Teatro. Le mie commedie sono principalmente regolate, o almeno ho creduto di regolarle, coi precetti che in essi due libri ho trovati scritti: libri per altro, che soli certamente furono studiati dagli stessi primi autori di tal genere di poesia, e che daran sempre a chiunque le vere lezioni di quest’arte. La natura è una universale e sicura maestra a chi la osserva».4
L’insegnamento che Goldoni ha tratto da questi due libri è quello che gli ha fornito gli strumenti per indagare e rappresentare il reale, la società a lui contemporanea, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue profonde trasformazioni in atto, ma anche per dialogare con il suo pubblico attraverso un adattamento ai suoi gusti, al mercato, o persino alle culture rionali (si pensi ai passaggi dal San Samuele, al Sant’Angelo e poi al San Luca interno a Venezia), regionali (Lombardia, Romagna, Toscana, Lazio) e nazionali (dalla produzione italiana a quella francese per la Comédie Italienne e la Comédie Française).
È seguendo le lezioni imparate su questi libri che Goldoni si trova a misurare il suo rapporto con la tradizione della Commedia dell’Arte che lo ha preceduto e ad accettare l’imprescindibilità dell’attore per una drammaturgia capace di coniugare l’esigenza della scena con la qualità letteraria del testo, che è spinto all’impresa editoriale al fine di difendere la propria, nuova e ancora tutta da affermare professione di «scrittor di commedie»; che si ritrova a ritrarre i caratteri di una società, in tutte le sue stratificazioni, fino a passare dalla commedia al dramma borghese.
Non si può allora che seguire le coordinate che l’autore stesso suggerisce per orientarci nel suo percorso di uomo e di autore, protagonista del «Mondo e del Teatro» del suo tempo.
Il genio comico che spinse Carlo Goldoni alla riforma della Commedia dell’Arte gli si palesò, da quanto lui stesso racconta nei numerosi luoghi memorialistici, fin da ragazzo, e furono proprio la corruzione del teatro a lui contemporaneo nonché la degenerazione della tradizione della Commedia dell’Arte a costringerlo all’“impresa”:
«Ora fu in me questo genio medesimo, che rendendomi osservator attentissimo delle commedie, che sui vari teatri d’Italia già diciotto vent’anni in qua rappresentavansi, me ne fece conoscere, e compiangere il gusto corrotto, comprendendo nel tempo stesso, che non poco utile mi saria potuto ridondar al pubblico, e non iscarsa lode a chi vi riuscisse, se qualche talento animato dallo spirito comico tentasse di rialzare l’abbattuto teatro italiano. Questa lusinga di gloria finì di determinarmi all’impresa.
Era infatti corrotto a segno da più di un secolo nella nostra Italia il comico teatro, che si era reso abominevole oggetto di disprezzo alle oltramontane nazioni. Non correvano su le pubbliche scene se non se sconce arlecchinate, laidi e scandalosi amoreggiamenti, e motteggi, favole mal inventate, e peggio condotte, senza costume, senz’ordine, le quali anziché correggere il vizio, come pur è il primario antico e più nobile oggetto della commedia, lo fomentavano e riscuotendo le risa dalla ignorante plebe, dalla gioventù scapestrata, e dalle genti più scostumate, noia poi facevano e ira alle persone dotte e dabbene, […]».5
Quando si parla della riforma della Commedia dell’Arte operata da Goldoni per lo più ci si riferisce a un totale rifiuto che il poeta drammatico mostrava per la recitazione all’improvviso, per le maschere, per le oscenità, o meglio tutte le “improprietà” tipiche della Commedia dell’Arte e dei suoi schemi ormai vecchi e ripetitivi, sclerotizzati nell’uso fino alla più ridicola e fastidiosa riconoscibilità.
Sembrerebbe sia lo stesso Goldoni a legittimare una simile interpretazione, ad avallare cioè l’identificazione del suo lavoro di «reformator de’ teatri» con la rivisitazione totale, se non un rifiuto aprioristico, di ciò che era stata la grande tradizione italiana.
In realtà, molto più specifiche, e con precisi obiettivi, sono le critiche mosse da Goldoni alla grande tradizione che lo ha preceduto e sono tali da identificare una ben determinata fenomenologia teatrale, quella di una consuetudine che aveva seguito una parabola degenerativa, vale a dire un’espressione della Commedia dell’Arte che dai primi grandi comici illustri della fine del Cinquecento aveva subìto una vera e propria metamorfosi fino ad arrivare a incarnare quel teatro corrotto che Goldoni voleva abolire.
Seguendo le indicazioni goldoniane, troppo spesso i lettori sono portati a far coincidere la condanna della corruzione del teatro che necessitava di una riforma con le modalità attoriche di rappresentazione delle sciocche favole sceniche della Commedia dell’Arte. Così facendo, però, si rischia una generalizzazione che non è certo in grado di fare luce sul complesso itinerario del “poeta comico” segnato dall’alternarsi di precise scelte drammaturgiche, nonché produttive, capaci di far avvicendare opere parzialmente scritte per esteso (per esempio, Momolo Cortesan, 1738) con opere totalmente scritte per esteso (La donna di garbo, 1743), poi di nuovo con canovacci (Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato, 1746), per arrivare prima alle famose sedici commedie, poi ai grandi capolavori, fino a tornare ai canovacci francesi.
Se non si facesse, dunque, una distinzione più netta tra ciò che Goldoni rifiutava del teatro della Commedia dell’Arte e ciò che ne salvava, consapevolmente o meno, si finirebbe per dover leggere l’itinerario riformatore, che lui stesso delinea in maniera tanto minuziosa da essere quasi ossessiva, come un campo minato di contraddizioni tra la teoria del riformista e la pratica professionale dell’autore drammatico.
In effetti non si arriverebbe a capire alcune scelte di Goldoni, che sembrano per molti versi contraddire le sue dichiarazioni poetiche, se non si comprendesse a fondo quali caratteristiche della tradizione della Commedia dell’Arte Goldoni considerava inammissibili, e in quale misura, nel teatro a lui contemporaneo.
In totale accordo con quanto detto da Siro Ferrone, è necessario dunque abbattere almeno un pregiudizio, quello che fa credere che la riforma goldoniana abbia comportato la fine della Commedia dell’Arte e della recitazione all’improvviso; e offrire allo stesso modo un riconoscimento, ossia quello del grande debito che Goldoni ha verso i comici, che contribuirono attivamente alla realizzazione della riforma e alla costruzione delle opere dell’autore.
La critica maggiore di Goldoni, semmai, è rivolta ai secentisti – anche se «non può negarsi […] non vi sieno stati fra loro de’ preregrini talenti» –, meglio ancora, alla loro continua ricerca del meraviglioso che portò a una vera e propria degenerazione delle scene, se non altro da un punto di vista della rappresentazione del reale, perché finirono con il far prevalere «l’incantesimo alla verità».
Si capisce subito, quindi, che Goldoni affronta distinzioni significative, non propone una condanna definitiva e senza appello di un vecchio modo di fare teatro, tanto meno sentenzia il bando della Commedia dell’Arte dal buon teatro del suo tempo, si limita, ma certo non è poco, a individuarne i difetti e le criticità da superare, facendo salvi solo alcuni aspetti considerati ancora positivi.
Probabilmente la strategia risponde al tentativo di riformare la commedia dall’interno, consapevole che gli ostacoli più grandi gli sarebbero stati posti innanzi proprio dai commedianti.
È in forma di commedia, Il Teatro Comico, una delle sedici commedie del famoso 1750, che si presenta ciò che lo stesso Goldoni considera il momento di svolta della sua riforma ovvero l’espressione massima della sua «poetica posta in azione».
Anche perché la commedia mette in scena tutti i difetti di una tradizione antica ormai desueta e non più adatta alle esigenze del pubblico moderno, e lo fa per voce degli stessi commedianti, i quali, consapevoli del cambiamento che il teatro a loro contemporaneo stava subendo, si fanno promotori, pur partendo dal proprio punto di vista, dei fondamenti ...