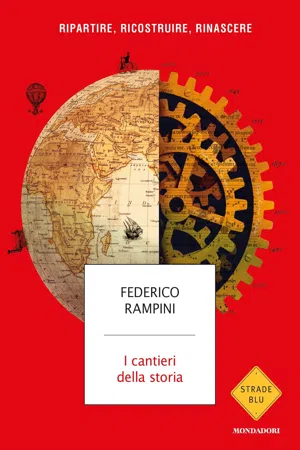«Cominciarono a sparare dieci chilometri prima del centro. Aprirsi un varco nella folla che resisteva era così difficile che si facevano strada uccidendo. Tra la gente di Pechino nessuno poteva credere che sarebbero stati capaci di tanto. Quando si capì che avevano l’ordine di fare una strage, la gente si mise a urlare con orrore: è peggio dell’invasione giapponese! La controreazione fu spontanea: tank assaliti, incendiati, soldati aggrediti. Ma contro l’esercito non avevamo chance. A me hanno ammazzato l’amico più caro, un giovane ricercatore dell’università, morto in ospedale dopo venti giorni di agonia. In seguito per anni la polizia si è accanita sulla sua vedova. Ogni 4 giugno (anniversario del massacro), lei riceveva minacce e avvertimenti pesanti: proibito unirsi agli altri parenti delle vittime. Un giorno è sparita, ha fatto perdere le tracce, ha tagliato tutti i rapporti anche con me, forse non sopportava più il peso di quel ricordo.»
Questa testimonianza la raccolsi molti anni dopo, da uno dei sopravvissuti della carneficina di piazza Tienanmen, avvenuta ai primi di giugno 1989 quando l’esercito cinese schiacciò nel sangue la protesta studentesca per la democrazia. Il racconto me lo fece, quando abitavo a Pechino, Shen Shiyun: un «ex ragazzo dell’89», allora giovane contestatore, che oggi è rientrato nei ranghi come la stragrande maggioranza dei suoi coetanei. Da piccolo imprenditore, proprietario di una rete di negozi di telefonini, nella Cina attuale Shen gode dei tanti benefici dello sviluppo economico. Non ha lo spirito del reduce, non ha contatti con gli ambienti dei dissidenti. Nella sua sfera privata custodisce la memoria di quel maggio-giugno di trent’anni fa, che anche lui passò con i compagni a occupare piazza Tienanmen. Non dimentica, non rimpiange, ha smesso di giudicare un passato così diverso da sembrare quasi irreale. La sua vita ha voltato pagina. Come quella di un miliardo di cinesi.
Sembra lontanissima nel tempo, quella stagione, quando la Cina appare in bilico tra autoritarismo e democratizzazione. Accade solo tre decenni fa e sembra passato un secolo. L’occupazione di piazza Tienanmen coincide con la crisi dei regimi comunisti a Mosca e in tutta l’Europa dell’Est. Per un breve tempo sembra che la Repubblica popolare fondata da Mao Zedong nel 1949 debba subire lo stesso destino che travolgerà l’Unione Sovietica, la Germania Est e altri paesi del «socialismo reale». Il vento della storia nel 1989 soffia in quella direzione. I giovani cinesi che sfidano il potere sono convinti di avere la vittoria a portata di mano, come l’avranno entro la fine dell’anno i loro coetanei di Berlino Est. Poi la vicenda cinese prende una direzione del tutto diversa. La protesta muore in un bagno di sangue, di fatto Pechino è il teatro di un golpe militare, anche se agli ordini di un leader politico che già guidava lo stesso regime, Deng Xiaoping. I carri armati a Pechino imprimono al fatidico anno 1989 un significato molto diverso in Estremo Oriente, rispetto alla liberalizzazione che sta iniziando in Europa. La Cina paga un prezzo elevato. Dopo la repressione militare è condannata dalla comunità internazionale, colpita da sanzioni americane ed europee, entra in una fase di isolamento. La tragedia di piazza Tienanmen sembra spegnere tante speranze: quelle sulle libertà e i diritti umani, ma anche i primi virgulti di un’apertura economica, l’embrione di un nuovo sviluppo, la diffusione di un modesto benessere dopo le privazioni dell’era maoista.
A rileggere le cronache di quegli anni, anche le analisi dei più autorevoli esperti della Cina o degli intellettuali dissidenti, il 1989 è un anno in cui la leadership comunista di Pechino commette un errore irrimediabile, che preclude un futuro migliore; mentre a Mosca il capo del Partito comunista sovietico Michail Gorbaciov è ben più coraggioso, lucido e lungimirante. A distanza di trent’anni, quel giudizio storico si è ribaltato. Oggi pochi osano sostenere che il 1989 abbia segnato l’inizio di un’era meravigliosa per il popolo russo. Invece, poco tempo dopo comincia il vero boom economico della Cina: solleva dalla miseria un miliardo di persone, crea il ceto medio più vasto del pianeta, proietta la Repubblica popolare al rango di superpotenza globale fino a sfidare la leadership degli Stati Uniti.
Il massacro di Tienanmen, per chi lo analizza a caldo nel 1989, sembra soffocare ogni speranza. Se lo guardiamo nel 2020, invece, dobbiamo ammettere che è l’inizio di una ricostruzione, l’antefatto di una rinascita, la vigilia di una ripartenza a cui allora pochi credevano. È una delle sorprese della storia. Riconoscerlo non significa abbracciare la versione ufficiale del regime, la narrazione che da Deng Xiaoping a Xi Jinping criminalizza i giovani manifestanti di piazza Tienanmen come teppisti o anarchici. L’orrore per quella repressione rimane intatto. L’autoritarismo di Xi che nel 2020 schiaccia le proteste a Hong Kong o nello Xinjiang, imparentato (ma meno cruento) con quello di Deng trent’anni prima, deve spaventarci. Però non si può negare che lo sviluppo della Cina, da quel paese poverissimo che era, è il cambiamento in assoluto più importante della nostra epoca. Il mondo intero sarebbe assai diverso – e non migliore – se quel miliardo di esseri umani fosse rimasto intrappolato nella miseria. Immaginiamo se la Repubblica popolare di oggi fosse una gigantesca Corea del Nord: ci sentiremmo più sicuri? E che dire del benessere di chi ci abita? Non occorre nutrire simpatia verso il «modello cinese» per ammettere che qualcosa di molto positivo è accaduto in quella parte del mondo. Quel qualcosa inizia proprio in seguito a un massacro. È uno degli scherzi che ci gioca la grande Storia: le sue sorprese a volte calpestano i nostri principi morali, offendono il nostro senso della giustizia. A voler raccontare la Storia come uno scontro fra il Bene e il Male, con una morale esemplare, un finale edificante, si scivola nella caricatura e non si capisce nulla della realtà umana.
Per comprendere la Cina di oggi bisogna ripartire da lì. La rinascita post-Tienanmen, come e perché è stata possibile? In primo piano c’è un leader, Deng Xiaoping, che a dispetto della sua minuscola statura fisica (tipica della minoranza etnica a cui appartiene, gli Hakka) è uno dei più grandi personaggi del Novecento. È anche un concentrato di contraddizioni. Intelligenza e crudeltà. Un tiranno illuminato. Un uomo che ha sofferto moltissimo, sulla propria pelle e su quella dei suoi familiari, per la persecuzione politica e la violenza fisica degli estremisti; poi non esiterà a usare la violenza contro altri. Un ideologo che non rinuncia al primato del Partito comunista; un pragmatico che sperimenta tutto (come Franklin Roosevelt), copia la ricetta giapponese, studia la Corea del Sud e Singapore, ammira il capitalismo americano, adatta modelli stranieri alla realtà del suo paese. Non è il solo ad affrontare questa sfida, però. La storia non è una galleria di ritratti dei potenti. Il vero protagonista di questa vicenda è il popolo cinese. La tragedia che vive nel 1989 va situata nel contesto di quel che accadde subito prima, e subito dopo.
Nel 1989 sono passati solo quindici anni da un altro trauma, molto peggiore del massacro di piazza Tienanmen: è la Rivoluzione culturale maoista. È impossibile capire il golpe militare di Deng, e l’accettazione di quella svolta autoritaria da parte di tanti cinesi, nonché la sua razionalizzazione a posteriori, se non si risale al precedente che aveva sconvolto il paese. Non a caso, nella Cina di oggi la Rivoluzione culturale e Tienanmen sono avvolte nella stessa nebbia: l’oblio ufficiale ha imposto di parlare poco di quegli eventi, la memoria collettiva è censurata.
Il colpo di partenza che dà inizio alla Rivoluzione culturale avviene il 16 agosto 1966. Quel giorno la cerchia dei fedelissimi di Mao comincia a lanciare appelli pubblici perché gli studenti affluiscano da tutto il paese verso la capitale. Si apre la nuova fase del comunismo cinese. Il Grande Timoniere è in difficoltà, in parte è stato esautorato dal potere di governo, è accerchiato da trame e complotti dei suoi avversari interni, in particolare le fazioni moderate. Mao fa leva sul proprio carisma personale per riprendere in mano il partito che gli sta sfuggendo. È un golpe da parte di chi formalmente è già ai vertici del potere, una tecnica che Deng copierà vent’anni dopo. Mao, però, all’inizio non usa i militari; scatena la rivolta dal basso contro gli apparati burocratici del suo stesso partito, invoca il «bombardamento del quartier generale». La violenza, nel suo linguaggio, non è mai soltanto metaforica. Nel suo cinismo, Mao aizza i regolamenti di conti, lo spargimento di sangue non lo spaventa. Saltando ogni intermediazione, scavalcando la nomenklatura, il popolo deve venire direttamente a contatto con il leader carismatico.
Tra l’agosto e il novembre 1966, a ondate, sulla piazza Tienanmen di Pechino si rovesciano adunate oceaniche per osannare il leader. In dieci manifestazioni successive, che si tengono sempre al tramonto davanti alla Porta della Pace Celeste, Mao accoglie in tutto undici milioni di giovani. Indossano tute militari color cachi con una fascia rossa al braccio e la scritta «Guardie rosse». Ognuno stringe una copia delle Citazioni del presidente, quelle che diventano famose nel mondo intero come il Libretto rosso. Il maoismo entra nella sua stagione più radicale.
C’è un parallelismo tra la Rivoluzione culturale cinese del 1966-1976 e la Rivoluzione francese del 1789-1794. Il pensiero politico di Mao può essere paragonato a quello di Jean-Jacques Rousseau. Il filosofo francese contrapponeva il buon selvaggio all’individuo corrotto dalla civiltà. Mao mette sullo stesso piano «i migliori e i più stupidi, i più ingenui e i più intelligenti», pensa che l’essere umano sia come un libro bianco, su cui bisogna scrivere una storia nuova. Il demiurgo che deve scrivere su quel libro bianco è lui, il popolo cinese è la materia prima su cui si scatena la sua frenesia di purificazione. Ordina ai giovani istruiti di andare nelle campagne per essere rieducati dai contadini. Rousseau pensava che la scienza e l’arte avessero contribuito al declino morale degli uomini. Mao è d’accordo e lo dice a modo suo, nell’era in cui America e Urss si contendono lo spazio: «Quando il satellite è in cielo, la bandiera rossa cade in terra».
Oltre che nell’ideologia politica, le analogie abbondano tra le Guardie rosse e i giacobini, fra gli eventi sanguinosi di Parigi del settembre 1792 e il terrore a Pechino e Shanghai nel 1966. Molte Guardie rosse studiano la Rivoluzione francese. I giacobini ispirano il loro idealismo utopico. L’esempio della violenza rivoluzionaria in Francia è importante: il vecchio ordine costituito si schiaccia solo con la forza. Più gli studenti sono idealisti, più sono disposti a tutto. Il vecchio leader accende la polveriera, lui stesso conia il termine «Grande Rivoluzione culturale» per indicare un movimento che all’inizio appare spontaneo e liberatorio, una sana e democratica ribellione del popolo contro i politici di professione, la rivincita della base contro i vertici. In realtà, Mao sta fomentando una guerra civile, pur di riprendere il pieno controllo del potere non esita a cavalcare la violenza di massa, popolo contro popolo, cinesi contro cinesi. In una lettera scritta alla moglie Jiang Qing, che lo asseconda come una delle istigatrici del movimento, annuncia esultante: «Grande è il caos sotto il cielo». Rileggere oggi i suoi scritti dà le vertigini: per l’uso abietto che fa della violenza, è un criminale che non ha nulla da invidiare a Hitler e Stalin, eppure le sue parole in quegli anni diventano un Vangelo mondiale, la gioventù europea del Maggio Sessantotto, gli intellettuali dei salotti parigini e milanesi se ne innamorano.
In Cina si apre una stagione selvaggia, ogni ordine crolla. Bambini e bambine delle elementari incollano dazebao a scuola per criticare i propri maestri: un ingrediente della Rivoluzione culturale è la rivolta generazionale dei giovani contro gli anziani (donde gli attacchi virulenti a Confucio e alla sua etica «paternalista»). Si vedono contadini salire in cattedra all’università di Pechino per insegnare il pensiero maoista: preludio alla chiusura delle facoltà, alla deportazione dei giovani cittadini nelle campagne, alla paralisi degli studi e della ricerca. Poi arrivano le campagne di «rieducazione socialista». Contadini costretti a umiliarsi nell’autocritica pubblica davanti al villaggio accusandosi di «deviazioni borghesi». Uomini e donne alla gogna con al collo il cartello di «controrivoluzionario». Vecchi costretti a indossare in pubblico magliette con l’elenco delle loro colpe. Processi sommari ai monaci tibetani, che sfilano tra gli insulti con il lungo cappuccio della vergogna. Statue di Buddha coperte di striscioni contro «l’idolo reazionario».
Gli eventi collettivi rischiano di sembrare astratti. Quando ci si imbatte nelle storie individuali, allora si capisce meglio. Tra le vittime delle fiammate di violenza studentesca c’è il caso tristemente celebre della professoressa Bian Zhongyun, cinquantenne madre di quattro figli, linciata con furia selvaggia dalle sue alunne nell’agosto 1966 a Pechino. La storia della signora Bian è una delle più note per lo scenario in cui si svolge: un liceo «perbene» frequentato dai rampolli di alti dirigenti comunisti, tra cui le figlie dello stesso Mao, dell’allora presidente della Repubblica Liu Shaoqi e di Deng Xiaoping. Le alunne iniziano una virulenta campagna di attacchi contro la professoressa Bian accusandola di essere una controrivoluzionaria e di non rispettare Mao. Quest’ultima accusa si basa su un «incidente» accaduto durante una delle periodiche esercitazioni antisismiche. Mentre la docente fa evacuare la sua classe, un’allieva le chiede se non sia egualmente importante portare in salvo il ritratto di Mao. Bian «non risponde con il livello di entusiasmo adeguato», secondo la testimonianza di alcune ragazze, e questo le sarà rinfacciato come una macchia infamante. Al culmine di una serie di umilianti processi pubblici viene assalita e pestata a morte dalle sue studentesse. Il suo corpo è abbandonato in una carriola nel cortile della scuola, ricoperto di manifesti di insulti. Dopo molte ore qualcuno porta la carriola in ospedale. Quando il marito e la figlia maggiore accorrono, trovano il cadavere tumefatto e sfigurato, reso irriconoscibile dalla violenza delle botte. Il marito va a comprare un apparecchio fotografico per poter documentare in quale stato l’hanno ridotta.
Nessuno si prenderà mai la responsabilità di quella morte, che sarà archiviata come «decesso per cause ignote». La figlia di Deng è una delle leader delle Guardie rosse in quel liceo. Per una nemesi spietata, in seguito la famiglia del «moderato» Deng cadrà in disgrazia e si troverà dall’altra parte della barricata, tra i perseguitati. Il sinologo Jonathan Spence ricorda che in quel periodo episodi di violenza particolarmente efferati e morbosi hanno avuto spesso per protagoniste le ragazze, un fenomeno che è stato interpretato da più parti come una sorta di perversa esplosione di libertà sessuale in una stagione di puritanesimo repressivo. Il più delle volte, come nel caso della professoressa Bian, le aguzzine erano adolescenti istruite e benestanti, provenienti da ambienti privilegiati e dai vertici della nomenklatura.
Temendo che gli sfugga di mano la spontaneità movimentista delle giovani Guardie rosse, con un voltafaccia il Grande Timoniere scatena le forze dell’esercito regolare in una repressione feroce dei suoi stessi sostenitori. È il periodo della massima violenza e dell’anarchia, dei regolamenti di conti mortali tra le fazioni. Nelle foto dell’epoca si vedono assemblee di giovani con le teste fasciate e sanguinolente, braccia e gambe ferite e bendate, in mano lance e coltelli, gli strumenti di una guerra civile all’arma bianca. Ci sono i «criminali» arrestati dalle Guardie rosse, legati e in ginocchio, in attesa di esecuzione. Le immagini che arrivano sulla stampa libera di Hong Kong ritraggono orrende torture, cadaveri mutilati e sventrati e poi appesi agli alberi per «educare le masse», morti che galleggiano nel Delta delle Perle.
Tra le vittime ci sono personaggi illustri. Il segretario personale di Mao, caduto in disgrazia, si suicida nel 1966 senza che il capo muova un dito per proteggerlo. Tanti artisti famosi sono perseguitati, imprigionati, deportati nei lager, «suicidati», le loro opere proibite e bruciate in piazza negli autodafé. Fa una tragica fine l’ex presidente della Repubblica Liu Shaoqi, morto di malattia dopo le torture e sepolto sotto falso nome per negargli il funerale. Solo i politici e gli intellettuali precipitati nella disgrazia hanno lasciato qualche traccia, libri e proteste, e i loro discendenti hanno avuto gli onori di una riabilitazione postuma. Milioni di perseguitati restano nell’ombra.
Il bilancio complessivo delle vittime della Rivoluzione culturale? Solo nelle campagne muoiono per le violenze e le esecuzioni sommarie tra 750.000 e un milione e mezzo di persone, a seconda delle stime. Almeno altrettanti riportano ferite gravi, rimanendo spesso invalidi a vita. Trentasei milioni di cinesi saranno perseguitati per anni, per esempio attraverso i lavori forzati nei laogai. Tra questi il premio Nobel per la letteratura Gao Xingjian, che nel romanzo autobiografico Il libro di un uomo solo descrive il lavaggio del cervello a cui erano sottoposti i prigionieri politici dei laogai. «Fin dalle sei del mattino, al levare del sole, gli altoparlanti cominciavano a rimbombare e bisognava tutti alzarsi, in venti minuti lavarsi i denti e la faccia, per andarsi a piazzare in piedi davanti a un muro su cui era appeso il ritratto del Grande Leader, ad ascoltare le istruzioni del mattino, cantare le Citazioni messe in musica, e brandendo il Libretto rosso gridare tre volte “Diecimila anni!” [ovvero, lunga vita a Mao], poi andare al refettorio a bere la zuppa. Dopo, riunirsi per leggere ad alta voce per una mezz’ora le opere di Mao, e alla fine, la zappa sulle spalle, si andava a dissodare la terra.»
Tra le vittime illustri della Rivoluzione culturale c’è Deng: è stato perseguitato dalle Guardie rosse; ha un figlio martirizzato, reso invalido dai maltrattamenti e costretto sulla sedia a rotelle per tutta la vita. Il ricordo di quegli eventi è un trauma che lo insegue per il resto dei suoi giorni; contribuisce a spiegare la sua reazione paranoica contro la protesta di piazza Tienanmen molti anni dopo. Quando gli studenti manifestano per la democrazia durante l’estate del 1989, Deng è ossessionato dall’idea che stiano rinascendo le Guardie rosse, che quei ragazzi siano l’avanguardia di un movimento altrettanto pericoloso.
Eppure, dopo la morte di Mao nel 1976 e dopo il processo alla «Banda dei Quattro», l’ala radicale che aveva aizzato le violenze, la vittoria del moderato Deng coincide con un insabbiamento della verità storica. Lui non vuole regolamenti di conti. Tantomeno vuole condannare la figura di Mao. Pur avendo inflitto al proprio paese un bilancio di vittime superiore a quello di Stalin nell’Urss, Mao viene imbalsamato (letteralmente) e santificato come il padre nobile della patria. Deng sfodera in questo il cinismo – o il realismo? – che lo distinguerà anche in seguito. Non intende fare il processo alla Rivoluzione culturale perché troppi sarebbero i colpevoli; l’intera classe dirigente verrebbe decapitata.
Anche in seno alla società civile è difficile tracciare un confine chiaro tra i carnefici e le vittime di quella stagione. La decisione di Deng «copre» un’omertà che è collettiva. Sono rari i cinesi di quella generazione che accettano di ripercorrere il passato senza reticenze, di affrontare con schiettezza tutte le vicende angoscianti della Rivoluzione culturale. Tra i pochi che si prestano a questo esercizio traspare talvolta un atteggiamento da reduci, la rivendicazione di aver fatto parte di una «gioventù bruciata», un orgoglio ferito e amareggiato, il rifiuto degli stereotipi e delle semplificazioni. An Wenjiang, ex Guardia rossa diventato maestro di scuola media, ricorda lo shock subito di fronte ai suoi studenti molti anni dopo: «Una mia alunna in un tema scrisse che nei ranghi delle Guardie rosse erano tutti teppisti, facinorosi, picchiatori. Credette che scherzassi quando le dissi che io ero stato una Guardia rossa, addirittura il capo di una squadra. In quel momento capii l’importanza di stabilire la verità dei fatti, di restituire un ritratto autentico di quegli anni».
È una reazione condivisa dalla scrittrice Lu Xin.
Quando cominciò la Rivoluzione culturale io divenni immediatamente una Guardia rossa. Molte versioni sulle azioni delle Guardie rosse che ci...