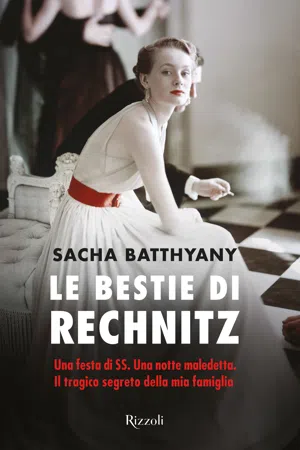![]()
Capitolo 1
Tutto era iniziato un giovedì di aprile, circa sette anni prima del mio viaggio a Buenos Aires. Allora lavoravo all’edizione domenicale del «Neue Zürcher Zeitung». Era mattina presto, in redazione c’erano poche persone e molto silenzio. Stavo scrivendo un articolo su un donatore di sperma olandese, quando una collega più anziana, che di solito non mi rivolgeva la parola, posò una pagina di giornale sulla scrivania e mi chiese: «Ma che famiglia hai?».
Alzai lo sguardo e le sorrisi. Solo in un secondo momento gettai un’occhiata all’articolo che aveva ritagliato apposta per me. Mi aspettavo qualcosa sul diciannovesimo secolo, che parlava di crinoline o magari di cavalli. Oppure di un qualche ponte intitolato a un mio antenato, un certo Ádám, Zsigmond o László Batthyány: il mio è un cognome famoso in Ungheria. I Batthyány erano conti, principi e vescovi. Nel 1848 uno fu eletto Primo ministro, e un altro, László Batthyány-Strattmann, fu beatificato per il suo impegno come medico a Roma da papa Giovanni Paolo II nel 2003. Si può ripercorrere la storia della mia famiglia fino alle campagne militari contro i turchi nel quattordicesimo secolo, ma qui da noi in Occidente il nome lo si conosce a malapena. E perché si dovrebbe, d’altronde? Lo si ritiene perlopiù un nome di origine tamil, con quelle ipsilon che ricordano lo Sri Lanka. Solo il giorno di Natale qualcuno mi fa qualche domanda al riguardo, quando alle undici del mattino, alla televisione, trasmettono la trilogia di Sissi, l’imperatrice interpretata da Romy Schneider che in una scena balla con un conte ungherese Batthyány, in uniforme celeste e con i capelli impomatati.
Mi aspettavo qualcosa del genere quando posai lo sguardo sul giornale, qualcosa di innocente. Invece il titolo recitava: La padrona di casa dell’inferno. Non capivo, ma la donna della foto la riconobbi subito: era zia Margit. A quanto sembrava, nel marzo 1945 era rimasta coinvolta nel massacro di centottanta ebrei avvenuto nella città austriaca di frontiera Rechnitz. Nell’articolo si diceva che durante un ricevimento nel suo castello si era ubriacata e a mezzanotte, tra un ballo e l’altro, aveva puntato la pistola alla testa di uomini e donne nudi e premuto il grilletto.
«Grazie» dissi, poi misi da parte il ritaglio e tornai a fissare il cursore lampeggiante sullo schermo. Mi restavano due ore per finire il pezzo sul donatore di sperma olandese.
Zia Margit? Quella della lingua?
Quando ero piccolo, tre volte all’anno andavamo a mangiare con zia Margit, e sempre nei ristoranti più costosi di Zurigo. Mio padre iniziava a imprecare appena salivamo sulla nostra Opel bianca e fumava una sigaretta dopo l’altra, mia madre mi ravviava i capelli con un pettine di plastica. Non la chiamavamo mai solo Margit, ma sempre zia Margit, come se «zia» fosse un titolo. Aveva sposato lo zio di mio padre, ma il matrimonio si era rivelato un disastro fin dall’inizio. Margit era una miliardaria tedesca discendente dei Thyssen, mentre lui era un conte ungherese decaduto. Era alta, con un busto enorme sopra due gambe sottili. Nei miei ricordi indossa sempre un tailleur abbottonato fino al collo e foulard di seta con motivi equestri, la sua borsa di coccodrillo è bordeaux con dettagli dorati, e quando racconta del capriolo che va in calore o delle sue crociere nell’Egeo, nelle pause tra una frase e l’altra tira fuori la punta della lingua, come le lucertole. Sedevo sempre il più lontano possibile da lei. Zia Margit odiava i bambini e mentre spiluccavo lo spezzatino di fegato di vitello mi voltavo in continuazione a guardarla. Volevo vedere quella lingua.
Dopo la sua morte, raramente in famiglia si parlava di lei e mi ero scordato quasi del tutto di quei pranzi fino al giorno in cui lessi nell’articolo di quella cittadina austriaca: Rechnitz. Di una festa e di un massacro. Di centottanta ebrei che prima di essere fucilati avevano dovuto denudarsi, così che i loro cadaveri si decomponessero più velocemente. E zia Margit? I giornali scrivevano che era coinvolta.
Chiamai mio padre e gli chiesi se ne sapeva qualcosa. Tacque e io sentii il rumore di una bottiglia che veniva stappata. Me lo immaginavo seduto sul divano consumato che mi piaceva tanto nel suo soggiorno a Budapest.
«Margit ha avuto qualche storia con i nazisti, almeno così si raccontava in famiglia.»
«Il giornale scrive che aveva organizzato una festa e che, al suo culmine, come dessert, aveva fatto rinchiudere centottanta ebrei in una stalla e distribuire le armi. Tutti erano ubriachi fradici e tutti potevano sparare. Anche Margit. È stata soprannominata “La padrona dell’inferno”. Sui giornali inglesi si parla di lei come della “killer countess”. E il “Bild” titola: La contessa Thyssen fa fucilare a una festa nazista duecento ebrei.»
«Sono solo chiacchiere. È stato commesso un crimine, non lo si può negare, ma mi sembra improbabile che Margit fosse in qualche modo coinvolta. Era un mostro, ma non certo in grado di commettere una cosa del genere.»
«Perché dici che era un mostro?»
Prima di quell’articolo su Rechnitz e zia Margit non mi ero mai interessato molto alla storia della famiglia. Le mie occasioni di venirvi a contatto erano ridotte al minimo. Se fossi nato in Ungheria, sarebbe stato diverso: là ci sono luoghi e monumenti che ricordano i miei antenati. Io, però, non sono cresciuto a Budapest, bensì in un appartamento di quattro stanze alla periferia di Zurigo, e quando compii otto anni ci trasferimmo un centinaio di metri più in là, in una tetra villetta a schiera che aveva la forma del cubo di Rubik, con cui allora, negli anni Ottanta, tutti si divertivano a giocare. Avevamo un tavolo da pingpong in giardino e un frigorifero gigantesco, come quelli americani, che i vecchi proprietari ci avevano lasciato in eredità. Quando veniva aperto, il freezer emanava un buon profumo ed era talmente grosso che ci si poteva infilare la testa fino in fondo, tra buste di piselli surgelati. Ancor meglio ricordo l’odore del distributore di benzina dove qualche volta la sera, di ritorno da alcuni amici a cui facevamo visita tutte le domeniche, i miei genitori si fermavano. Io e i miei due fratelli sedevamo stretti l’uno accanto all’altro sul sedile posteriore, e ogni volta mi auguravo che dovessimo fare rifornimento. Allora abbassavo il finestrino, chiudevo gli occhi e respiravo con il naso. La benzina, l’aria fresca e noi tutti insieme su quella macchina di ritorno a casa: in nessun’altra occasione mi sentivo più al sicuro. E quando arrivavamo a destinazione, facevo finta di dormire e mio padre mi portava nella mia stanza. La sua camicia sapeva di vino, di sigarette e d’estate: quella è stata la mia infanzia.
Come le balene che vanno a partorire in acque tranquille, i miei genitori si erano allontanati dal mondo e si erano stabiliti lì. Ma a differenza di quei mammiferi, che poi vengono di nuovo attratti dalle profondità dell’oceano, i miei erano rimasti incagliati in periferia.
Magari stavano fuggendo dal loro passato, dai ricordi del tempo trascorso in Ungheria, dalle immagini della guerra, della fuga e dei luoghi dove nascondersi. Può darsi che volessero semplicemente ricominciare da capo in questo posto incontaminato, non voltarsi più indietro e fare di questo angolo morto di mondo la loro casa. E ci è mancato poco che funzionasse.
La Svizzera era l’ideale per chi cercava un nuovo inizio lasciandosi alle spalle le difficoltà del passato, perché qui nulla ricordava Hitler o Stalin. Il nazionalsocialismo, il comunismo, i campi di concentramento e i gulag in questo Paese sono solo materia per i libri di storia. C’è a malapena un monumento che celebra le vittime della guerra, e sono poche le famiglie, eccetto quelle degli immigrati, la cui storia è legata a quegli orrori. Non si sente mai domandare: «Nonno, raccontami che cosa hai fatto in guerra». Nessuno è mai stato deportato o è finito nelle camere a gas. Non c’era nessun boccone amaro da digerire, niente sorti da risollevare, come invece scrivevano sempre i giornali quando si riferivano ad altri Paesi. Niente fallimenti collettivi, né crisi, all’infuori di quelle delle banche. La Svizzera ha conosciuto solo periodi di benessere, di sicurezza e di serenità, in particolare all’inizio degli anni Novanta, il periodo della mia adolescenza, quando tutto divenne più gioioso e nei fine settimana gli abitanti della periferia facevano gite in bicicletta lungo qualche lago.
Si potrebbe dire che un tale idillio influenzasse ogni cosa. Quella spensieratezza infondeva ottimismo nelle famiglie, ma non in tutte.
Mio padre e mia madre non si sentirono mai davvero a casa in questo Paese, il più ovattato d’Europa. Impararono lo svizzero tedesco, andarono a sciare, comprarono un tostapane quando tutti lo compravano, e in inverno mangiavano la raclette e gustavano il formaggio fuso sulle patate, forse solo con un po’ meno paprika degli altri. In realtà, però, presero parte alla vita di questa nazione solo quando non potevano farne a meno. Salutavano i vicini ma quando uscivano preferivano passare inosservati. Di nascosto, ridevano della Svizzera e dei suoi abitanti, almeno così mi pareva allora. Delle occasionali osservazioni xenofobe di altri residenti – che avevamo un cognome buffo, che parlavamo tedesco abbastanza bene per essere stranieri, che la nostra macchina arrugginita non faceva una bella figura – non si curavano, perché sapevano che non avrebbero mai messo radici lì. Per loro la Svizzera era un Paese finto, dove la vita non era genuina, dove non c’erano alti e bassi, non si gioiva e non ci si appassionava. Chi non ha perduto almeno un paio di parenti in guerra, chi non ha mai sperimentato la ferocia con cui una forza di occupazione straniera, non importa se russa o tedesca, rovescia ogni cosa, non può certo dire di aver capito la vita. Solo il dolore era tangibile, felicità e spensieratezza non contavano nulla. Il passato pesava sempre più del futuro, il vecchio era meglio del nuovo.
E così, probabilmente, in quella piccola casa alla periferia di Zurigo, in quel luogo senza ieri che mio padre aveva presto abbandonato, i miei genitori sognavano una vita diversa.
Due anni dopo la caduta della cortina di ferro, mio padre fece le valigie e se ne andò a Budapest. Anche mia madre se ne andò, senza dare l’impressione che le mancasse qualcosa, e io me la presi con lei. Di punto in bianco tutti e due se n’erano andati, lasciando a me quella sensazione di vivere in un Paese finto.
Io invece sono rimasto, forse solo per pigrizia; mi sono iscritto all’università, perché lo facevano tutti, e sono diventato giornalista. Ho iniziato scrivendo delle baby gang armate di Liverpool, ho dormito nella roulotte di uno dei capi del Ku Klux Klan in Texas, ho girovagato per giorni in un sobborgo di Zurigo dietro alla storia di una ragazzina di tredici anni vittima di uno stupro di massa e mi sono seduto sul divano di quel donatore di sperma olandese insieme a una coppia di lesbiche che desiderava un figlio. Sono rimasto a guardare mentre lui consegnava loro una scatoletta e una siringa, che suppongo una delle donne avrebbe usato per inocularsi il suo sperma. «Esco a comprare qualcosa» gridò lui mentre era già sulla soglia. «Cosa preferite? Coca-Cola? Patatine?» Mentre parlava, loro scuotevano la testa stupefatte. Coca-Cola? Loro volevano un bambino.
L’Ungheria era la terra dei miei genitori, non la mia, dunque perché avrebbe dovuto interessarmi? Avevo solo trent’anni, mi ero appena innamorato: la Seconda guerra mondiale e l’uccisione di centottanta ebrei non avrebbero potuto essere più distanti. Avevamo già i nostri problemi: migrazione, perdita di punti di riferimento, globalizzazione. Mi occupavo di cose come troppo consumismo, troppa pornografia, troppe opportunità.
Ma dopo quel mattino in cui mi ero imbattuto per caso nella storia della mia famiglia, riconoscendo in un articolo di giornale la mia prozia Margit, cominciai a fare ricerche e scrissi ad alcuni parenti a Vienna, Budapest e Monaco. «Salve» esordivo, «noi non ci conosciamo ma siamo imparentati con gli Ecken. Ha letto cosa dicono sia successo? Ne sa qualcosa?» Mi procuravo documenti sulla zia Margit e suo marito Ivan, il fratello di mio nonno, leggevo libri sui Thyssen, sulla storia dell’Ungheria, trascorrevo giornate intere negli archivi a Berlino e Berna, Budapest e Graz e parlavo in continuazione al telefono con mio padre. Zia Margit era la responsabile di questo mio viaggio nella storia, a causa sua mi ero interessato per la prima volta nella vita alle mie origini.
È stato il massacro di centottanta ebrei a riavvicinarmi alla mia famiglia.
![]()
Capitolo 2
Una domenica di primavera del 2009 mi recai per la prima volta a Rechnitz, per capire se e quanto la mia prozia fosse coinvolta nel massacro. Partii da Zurigo con il treno della notte e arrivai a Vienna il mattino presto; lì noleggiai un’auto e guidai per boschi e vigneti: i grappoli sui tralci erano ancora piccoli e duri. Rechnitz non è un gran bel posto. C’è un’unica grande strada affiancata da case basse con finestre strette e tende spesse. Non esiste un centro cittadino, una piazza del mercato, e il castello, che il ricchissimo imprenditore e collezionista d’arte tedesco Heinrich Thyssen nel suo testamento aveva lasciato alla figlia Margit, la nostra zia Margit, non c’è più. Nel 1945, i russi lo bombardarono e gli abitanti del luogo si appropriarono di ciò che restava dei mobili, dei quadri e dei tappeti.
Ogni anno l’associazione Refugius organizza una commemorazione in onore degli ebrei trucidati. All’ingresso del Kreuzstadl, un fienile ritenuto il luogo del crimine e divenuto oggi monumento commemorativo, si canta e si prega. È importante che la tragedia non venga dimenticata, fu detto anche nel discorso di quell’anno. Io me ne stavo in disparte, anche perché non conoscevo nessuno, e mi guardavo intorno: era una bella giornata di sole, i denti di leone erano in fiore, l’erba ancora un po’ umida arrivava a sfiorare le caviglie, e da qualche parte, lì sotto, erano sepolti centottanta teschi. La fossa comune non è ancora stata scoperta malgrado lunghi anni di ricerche.
La notte tra il 24 e il 25 marzo 1945 c’è la luna piena. Nel castello di Margit Batthyány-Thyssen, a Rechnitz, nella regione del Burgenland sul confine austroungarico, si sta svolgendo una festa. Importanti personalità della Gestapo e del Partito nazista, come Franz Podezin, caposquadra locale delle SS, Josef Muralter, Hans-Joachim Oldenburg si intrattengono con membri della Gioventù hitleriana e con il personale del castello, e bevono spumante. Per il Partito nazionalsocialista la guerra è ormai persa. I russi sono arrivati fino al Danubio, ma non per questo ci si deve guastare l’umore. Sono le otto di sera. La stazione di Rechnitz è affollata da circa duecento ebrei, lavoratori forzati provenienti dall’Ungheria, che sono stati impiegati per la costruzione del Vallo sudorientale, la gigantesca linea di difesa che dalla Polonia, attraverso la Cecoslovacchia e l’Ungheria, arriva fino a Trieste e che avrebbe dovuto arrestare l’avanzata dell’Armata rossa. Alle nove e mezzo l’imprenditore Franz Ostermann carica sui propri camion parte di quei deportati e li consegna poco dopo nelle mani di quattro uomini delle squadre d’assalto, le SA, che danno ai prigionieri delle pale e ordinano loro di scavare delle fosse a forma di L.
Gli ebrei ungheresi cominciano a scavare, ma sono stanchi e deboli e la terra è dura. Intanto nel castello di zia Margit si balla e ci si ubriaca. Più tardi, quella stessa sera, Podezin riceve una chiamata. Nel salone c’è troppo rumore e si deve spostare in una stanza attigua, dove il colloquio dura pochi minuti. «Sì, sì» risponde l’ufficiale, e chiude la conversazione dicendo: «Che maledetta porcata!». Incarica Hildegard Stadler, la responsabile della locale Lega delle ragazze tedesche, di riunire in una camera da dieci a tredici invitati. «Gli ebrei alla stazione» comunica loro «sono malati di febbre petecchiale e devono essere eliminati.» Nessuno replica. L’armiere Karl Muhr distribuisce agli ospiti armi e munizioni. Sono appena passate le undici. Nel cortile del castello attendono tre automobili, ma non c’è posto per tutti e alcuni vanno a piedi. D’altronde non è troppo distante.
Telefonai a mio padre. «Sapevi che zia Margit quella notte era là e sapevi anche del massacro» gli dissi.
«Sì.»
«Ma non hai mai pensato che potesse essere coinvolta?»
«È un interrogatorio?»
«Sto solo chiedendo.»
«Non ho mai pensato che potesse esserci un legame tra la festa e il massacro, come invece sostengono di recente i giornali. Aspetta un attimo.» Lo sentii tossire e dal rumore mi sembrò che prendesse una sigaretta dal pacchetto.
«Fumi troppo.»
«Come sta la piccola?»
«Ha messo il terzo dentino e inizia a gattonare. Perché non hai mai parlato con Margit della guerra?»
«Cosa avrei dovuto chiederle? Zia Margit, desideri un altro sorso di vino? A proposito, hai sparato a degli ebrei?»
«Sì.»
«Non essere sciocco. Erano visite di cortesia. Discorrevamo del tempo e lei spettegolava di alcuni membri della sua famiglia. “Un seme marcio” diceva quando parlava dei Thyssen e dei Batthyány, che a suo parere erano un po’ matti. “Un seme marcio”, questa era la sua espressione preferita. Ti ricordi ancora la sua lingua?»
Tra la mezzanotte e le tre del mattino Franz Ostermann percorre per ben sette volte il tragitto dalla stazione al fienile. Ogni volta trasporta venti o trenta ebrei che poi consegna ai quattro uomini delle SA. I prigionieri devono spogliarsi, deporre gli indumenti davanti alle fosse a forma di L e inginocchiarsi nudi sul bordo. Sia Podezin sia Oldenburg, fanatici nazionalsocialisti, assistono allo spettacolo. Sparano agli ebrei alla nuca. Josef Muralter, membro del Partito nazista, va avanti e indietro mentre scarica la propria arma, e grida: «Maiali, andate all’inferno! Traditori della patria!». Le vittime cadono all’unisono dentro alla voragine restando impilate l’una sopra l’altra. Al castello vengono stappate altre bottiglie di spumante mentre qualcuno suona la fisarmonica. Margit è giovane e le piace divertirsi. È la più benvestita. Un cameriere di nome Viktor nota che gli ospiti, che alle tre del mattino sono tornati ad affollare il salone, gesticolano vivacemente e hanno i volti arrossati. Podezin, il presunto organizzatore che ha appena ammazzato con un colpo in testa uomini e donne, si scatena ora nelle danze.
Quella notte non tutti gli ebrei furono giustiziati. Diciotto furono tenuti in vita con il compito di ricoprire di terra le fosse. Un compito da becchini. Dodici ore dopo, la sera del 25 marzo, per ordine dell’amante di zia Margit, Hans-Joachim Oldenburg, anche loro furono assassinati e sotterrati nelle vicinanze del mattatoio, nel campo di Hinternpillenacker.
Dopo la guerra sette persone furono accusate di omicidi multipli e di torture, in parole povere di crimini contro l’umanità: Josef Muralter, Ludwig Groll, Stefan Beigelbeck, Eduard Nicka, Franz Podezin, Hildegard Stadler e Hans-Joachim Oldenburg. Ma nel 1946 lo svolgimento del processo subì un arresto in seguito all’u...