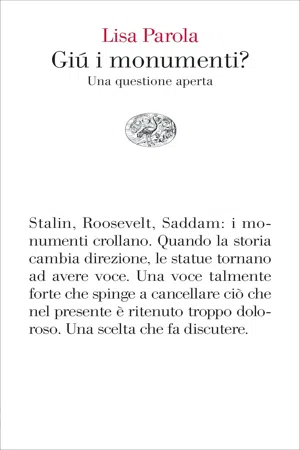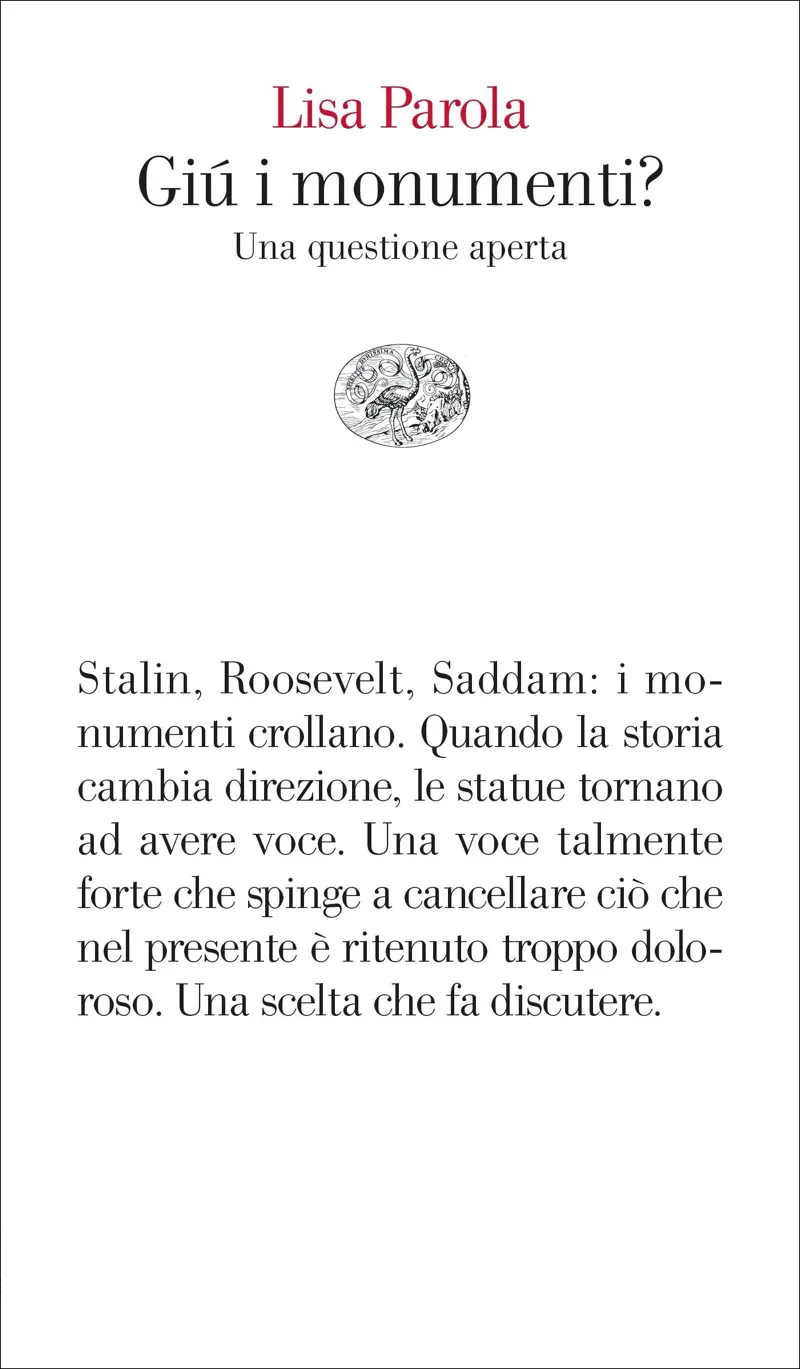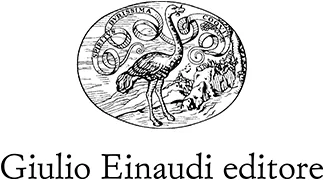Mentre state leggendo queste righe, molto probabilmente nel mondo, in uno spazio pubblico di qualche città, si sta iniziando a pensare di rimuovere una statua dal suo piedistallo. Un’azione che a volte avviene in modo improvviso con un atto di violenza, altre volte dopo una lunga riflessione e solo con l’assenso di una qualche istituzione pubblica.
Ovunque e comunque avvenga, è evidente che da tempo qualcosa si sta muovendo intorno alle statue ma ancora di piú intorno al loro significato e all’idea stessa di monumentalità.
Incuriosita dalle tante notizie di cronaca che con una certa ricorrenza tornano a occupare le pagine dei giornali, ho cercato di osservare quelle forme, ho raccolto informazioni: piccole e grandi storie di monumenti.
Nel primo capitolo proverò a indagare il “rovescio” del monumento: l’equilibrio ciclicamente instabile di statue di uomini – maschi – sul piedistallo, a partire proprio dal momento del loro rovesciamento, quello in cui le statue vengono rimosse o violentemente abbattute.
Il monumento non è solo un’opera d’arte ma anche, a volte soprattutto, un dispositivo comunicativo, per questo il secondo capitolo si apre con un interrogativo: Cosa sta accadendo alle statue? Di certo quelle forme che storicamente rimandano al potere stanno attraversando un momento d’incertezza, forse la loro autorità viene messa in discussione quando entra in dialogo con le tante comunità che disegnano il paesaggio urbano contemporaneo. E forse qui, in questo confronto, la loro aura, pian piano, inizia a scomparire.
Nel terzo capitolo, il monumento sarà indagato attraverso progetti e opere di artisti contemporanei, di Paesi e generazioni differenti, che hanno rivisitato l’idea di monumentalità in questi ultimi decenni e in un mondo globale, una monumentalità sempre piú soggetta a un processo, spesso critico, di rilettura quando non di radicale trasformazione.
In chiusura proverò a ragionare sul che fare di tutta quella memoria scomoda che parla di potere e sopruso cercando non tanto di dare soluzioni definitive ma di suggerire spunti per la continuazione di un dibattito che ancora fatica a trovare una conclusione.
Riflessioni che non hanno alcuna pretesa di esaustività rispetto a un tema cosí complesso, che coinvolge lo spazio pubblico, i musei e l’arte, e che si apre alla storia, alla politica, alla memoria, al genere e alle generazioni; questioni che si propongono quali strumenti per provare a osservare con maggiore attenzione un patrimonio diffuso ma quasi invisibile che però incontriamo ogni giorno, spesso distrattamente, camminando per strade e piazze delle città.
Un equilibrio sempre piú precario.
I monumenti hanno una data di scadenza? A osservare quanto sta accadendo negli ultimi decenni la risposta parrebbe positiva. Ma quando è emersa tutta questa violenza contro la statuaria? Cosa muove le diffuse azioni di distruzione di cui siamo spettatori?
Inserire un monumento nello spazio pubblico significa sempre, in qualche modo, rendere materiali i fatti, nominare, costruire, dare un’identità a un luogo, ma anche progettare uno spazio attraversato da molte persone, che il piú delle volte si definisce tramite una voce univoca; un “io”, verrebbe da dire, che può esistere solo evidenziando un “loro”. E la conseguenza di questa univocità è l’apertura alla possibilità di un destino incerto, imprevedibile.
Il basamento delle sculture come quello dei monumenti che incontriamo nelle piazze o nei giardini, di fronte alle università o ad altri spazi istituzionali è, secondo la critica d’arte Rosalind Krauss, una «soglia» 1, una mediazione tra lo spazio che il monumento occupa e il suo significato. Qualcosa che assomiglia a un limite e che definisce una difficile relazione tra un tempo bloccato e un tempo in movimento.
Il piedistallo riesce a elevare solo un fatto o un accadimento, è sempre troppo stretto per accogliere la pluralità e le posizioni che attraversano la scena urbana. Il monumento è anche la forma di una volontà di potere, un atto politico che dà spazio, voce e visibilità a un’unica storia. Ma se intendiamo la storia come un processo in continuo divenire, quell’unico fatto può ampliarsi, modificarsi, rovesciarsi. Potremmo allora pensare il monumento, e lo spazio che lo circonda, come una macchina visiva complessa nella quale si condensano ambiti e tempi differenti. Il monumento ha sempre a che fare con la sfera estetica e politica ma anche il tempo è un elemento centrale. Il monumento viene posato a memoria di un evento passato, il suo tempo è sempre un presente che deve parlare al futuro. Quando tutti questi fragili equilibri s’interrompono i monumenti perdono la loro autorità e la loro verticalità.
Per capirci meglio proviamo con un esempio noto. È un uomo adagiato e addormentato sul grembo di un monumento quello che Charlie Chaplin ci presenta nei primi minuti di Luci della città. Due anni dopo il crollo economico del 1929, in un Paese ancora immerso in una crisi profonda, i primi tre minuti di uno dei capolavori del cinema sono dedicati proprio all’inaugurazione di un monumento in un’ideale città americana d’inizio anni Trenta. Prima di un irriverente gioco di equilibri nel quale l’attore è sospeso tra le statue che rappresentano rispettivamente la Giustizia, la Pace e la Prosperità, quello che colpisce delle prime inquadrature è la descrizione precisa di tutti gli elementi e le figure che compongono lo spazio del monumento quando viene posizionato nella sfera pubblica. Di fronte al marmo ancora coperto e che rimanda a una forma astratta si estende una piazza. In primo piano, compaiono ben riconoscibili tutti i soggetti che definiscono il monumento. Sul palco, all’altezza del basamento, sono presenti il sindaco, la committente, l’artista e sotto, in buon ordine, la banda e la polizia. Sul fondo compare, ripresa di spalle come una massa indistinta, la folla di persone che assiste alla cerimonia di inaugurazione.
In un’evidente parodia del primo cinema parlato, ma anche della retorica del potere, attraverso sonorità sgraziate e tonalità metalliche, il regista fa intervenire e dà voce prima al sindaco, poi all’artista e, in chiusura, alla committente. In quest’atmosfera solenne e pomposa, man mano che con una certa difficoltà la statua viene svelata, lo spettatore si ritrova di fronte a un inciampo visivo che interrompe bruscamente l’ufficialità del momento. Steso sul grembo della Giustizia, che ha preso le sembianze di una giovane donna, si trova il corpo addormentato del Charlie Chaplin senzatetto e vagabondo. Dopo qualche secondo, lo stesso Charlot, sorpreso dall’accaduto e nel tentativo di uscire da quella imbarazzante situazione, prova a chiedere scusa alla folla ripetendo piú volte e in modo meccanico il noto gesto del saluto con la bombetta. Questo gesto si trasforma poi in una sequenza di movimenti simili a quelli di una marionetta che interpreta una danza sospesa, irriverente e ironica muovendosi in modo nervoso in mezzo alle figure che compongono la statua.
Tra lo stupore e l’indignazione della folla, dal palco si prova a ristabilire l’ordine incitando la banda a suonare e cercando di riprendere la parola. In questa breve sequenza è evidente una critica nei confronti delle istituzioni e della borghesia che, nonostante la povertà che la crisi ha causato nelle città americane, continua ad adagiarsi sulla forma del monumento quale strumento per la sua stessa rappresentazione, autorevole, retorica e rassicurante.
È all’interno di questa dissacrante cornice visiva che Chaplin decide di mettere in moto la macchina complessa del monumento evidenziando tutte le contraddizioni che abitano lo spazio pubblico e collettivo. Nel tentativo di destabilizzarne l’immobilità e la retorica, man mano che la statua inizia ad essere svelata, viene posto al centro delle riprese il corpo a riposo di un uomo per denunciare la diffusa situazione di povertà sociale che il monumento stesso vorrebbe simbolicamente provare a rimuovere. La scena si chiude solo quando, dopo numerose acrobazie, l’intruso scavalca una staccionata e se ne va.
Queste immagini, che al tempo devono essere apparse al pubblico e alle istituzioni ancora piú irriverenti e provocatorie, ci permettono però di riflettere sulla complessità che sempre abita un monumento e che ne stabilisce, nel tempo, la verticalità o l’orizzontalità.
Il destino delle statue sul piedistallo è un tema che inseguo da tempo, colpita e incuriosita dal fatto che quando la storia cambia direzione, o meglio quando il nostro sguardo cambia orientamento rispetto a fatti e avvenimenti, le statue tornano ad essere presenza e voce. E a volte quella voce è talmente alta che le persone, le comunità alle quali non è stato permesso di averla, sentono l’urgenza di distruggere o rimuovere quelle forme, quei corpi innalzati sul piedistallo, cancellando quello che nel presente è ritenuto troppo doloroso.
Invisibili magari per decenni, solo in quei precisi momenti le statue tornano a occupare lo spazio intorno e a far sentire la loro autorità.
In molti momenti della storia, da luoghi di commemorazione i monumenti si sono trasformati in occasioni di conflitto, portando alla luce rimozioni profonde legate all’arbitrarietà delle interpretazioni e delle narrazioni del passato e facendo riemergere la distanza tra i vinti e i vincitori. Uno scontro, questo, che avviene il piú delle volte nel centro delle città, lí dove la storia è rappresentata ma anche dove la pluralità degli attori sociali si compenetra e si sovrappone.
Napoleone Bonaparte, Francisco Franco, Iosif Stalin, Vladimir Lenin, François Duvalier, Saddam Hussein; e potremmo andare ancora piú indietro: gli imperatori Nerone, Domiziano, Gallieno, Aureliano, Probo, Geta e Macrino. La storia ha visto molti uomini rimossi dai loro piedistalli. Torniamo ora al presente. Di recente in Martinica la posizione di Victor Schœlcher, ricordato per molto tempo come una delle figure chiave della liberazione dalla schiavitú, è stata rivisitata e alcune sue statue abbattute; a Bristol il bronzo di Edward Colston, a lungo ricordato come benefattore, fin quando non emerse il suo coinvolgimento nella tratta degli schiavi, è stato buttato nell’acqua di un canale. Ad Anversa, un monumento in onore di Leopoldo II, il re belga che ha colonizzato il Congo, è stato trasferito in gran fretta nel magazzino di un museo dopo essere stato deturpato da un gruppo di manifestanti. Nel Sud degli Stati Uniti molte statue di soldati confederati e del presidente Jefferson Davis o quelle in onore di Cristoforo Colombo sono state abbattute e poi decapitate.
Ma di quale monumento stiamo parlando? Da molti anni raccolgo storie di statue. Ne ho trovate in Italia e all’estero, quando il mio lavoro di critica e curatrice d’arte contemporanea mi ha portato, sia pure per brevi periodi di tempo, negli Stati Uniti, in Ucraina, in Colombia. Altre ne ho rintracciate nell’immenso deposito di informazioni disponibili online. Storie, fatti, immagini e documenti che raccontano la difficile relazione che intreccia e confonde arte, storia e cronaca. Ho escluso dalle mie analisi l’architettura e tutto l’esteso campo di ricerca che riguarda gli edifici monumentali, che aprirebbe a molte altre riflessioni, e mi sono invece concentrata prevalentemente sulle sculture: esse parlano con l’unica voce di un potere dominante che riesce a mantenere e propagare l’autorità attraverso l’utilizzo di un complesso sistema visivo, e che si attiva quando una statua su un basamento viene posata nello spazio pubblico. Ma ho anche provato a osservare il processo contrario, cioè a ragionare su cosa muove la volontà di rovesciare quel tipo di rappresentazione. Ho poi finito chiedendomi cosa si possa fare di tutti quegli eroi, e se il nostro modo di osservarli stia cambiando.
Verticale o orizzontale, è tutta una questione di equilibrio.
Il monumento dalla sua posizione verticale può quindi essere colpito, abbattuto e poi rovesciato. È qualcosa che accade nello spazio limitato del basamento e nel tempo concentrato della rivolta. Un semplice ribaltamento da verticale a orizzontale. Si tratta di uno spazio e di un tempo minimi, che permettono però un repentino cambio di significato di quello che il monumento vuole comunicare. È un quasi nulla, un luogo d’azione piú che di parole. Quando il monumento verticale sta per cadere a terra si attiva un processo fuori dalla continuità, un atto che Deleuze e Guattari descriverebbero come «una biforcazione, una deviazione rispetto alle leggi, una condizione instabile che apre un nuovo campo di possibilità»2.
Lo spazio pubblico come la sfera pubblica è scena politica e simbolica. Negli ultimi decenni, anche a partire da riflessioni nate nell’ambito degli studi postcoloniali e femministi, si è evidenziato quanto si tratti di una dimensione abitata da una crescente complessità, che sempre di piú tende a sfrangiarsi per aprirsi all’imprevedibilità e all’inatteso.
In tal senso lo spazio del monumento è un’area attraversata da tensioni opposte, che mostrano come lo spazio pubblico possa essere contenuto, limitato, ma anche contestato e ridefinito. Ed è qui che possono riemergere tracce di un passato rimosso.
Secondo Alain Badiou, un evento accade quando la parte esclusa appare sulla scena, improvvisamente e drasticamente, per scardinare l’apparenza della normalità e aprire uno spazio per ripensare la realtà. Attraverso l’intensificazione, la contrazione e la localizzazione spaziale può infatti apparire il non visibile del visibile3, qualcosa che si potrebbe definire come una zona d’ombra. Anche nei monumenti quest’ombra sembra essere presente; ed emerge e si rende esplicita quando le tensioni opposte al procedere della storia entrano in conflitto tra loro. Quando cioè, nel tempo presente, il passato e il futuro si scontrano, quando la prospettiva storica sembra perdere la sua profondità e all’“altro”, per un momento, è permesso di prendere voce di fronte al monumento riuscendo a raggiungerlo per abbatterne la verticalità.
Si pensi alla Rivoluzione francese o agli scontri in molte città dell’Est Europa dopo la caduta del muro di Berlino o ancora, in tempi piú recenti, agli Stati Uniti e ad alcune città europee con eredità coloniali. Ogni volta che dal monumento traspare il non visibile, il non detto, lo spazio pubblico intorno assume una forza travolgente che scavalca, calpesta, danneggia i luoghi della rappresentazione del potere.
Se lo spazio pubblico è il luogo nel quale si materializza la storia dominante, in quelle forme qualcosa accade e la città non può piú essere vista come un pacifico agglomerato di edifici e monumenti.
La caduta del monumento mi pare in qualche modo vicina alla definizione che Deleuze dà del maggio francese (peraltro, un significativo momento di ribaltamento di monumenti): un campo di forze e segni mossi quando «il segno sensibile ci fa violenza»4.
Se il monumento in qualche modo scompare, il piedistallo rimane. Avete mai guardato il basamento di un monumento vuoto? A osservarlo bene ci appare come una domanda aperta sulla storia, un vuo...