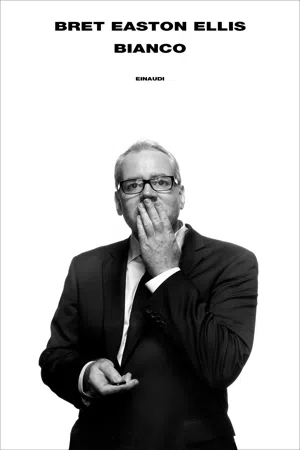Ricordo ancora una conversazione che ebbi con una cara amica nella primavera del 1986, quando facevo il secondo anno a Bennington. Stavamo ascoltando la radio in auto, mentre andavamo in città per vedere un film, e quando trasmisero Manic Monday delle Bangles mi allungai per alzare il volume, dicendo alla mia amica – era lei alla guida – che pensavo che il loro nuovo disco Different Light fosse davvero bello e che quel singolo, salito da poco al secondo posto in classifica nella Hot 100 di «Billboard», era un «pop barocco costruito in maniera impeccabile» – e se questa sembra una battuta che avrebbe potuto dire un personaggio delle Regole dell’attrazione, be’, quello è il libro che stavo scrivendo all’epoca. La mia amica arricciò il naso e mi disse che quella canzone la infastidiva perché sembrava cosí stupidamente femminile. Citò i versi «’cause it takes me so long | to just figure out what I’m gonna wear» come esempio della strada che le Bangles stavano imboccando nella loro nuova versione piú glamour, e sottolineò che era stato un uomo (Prince!) a scrivere la canzone. Ribattei che Manic Monday poteva essere interpretata come una canzone femminista visto che raccontava di una donna che lavorava indefessa per mantenere se stessa e il fidanzato disoccupato. Ma la mia compagna di viaggio alzò gli occhi al cielo, palesemente contraria a quest’interpretazione; a posteriori, mi resi conto che lei considerava quel pezzo un atto di appropriazione culturale trent’anni prima che questa definizione venisse usata per la prima volta. A lei piacevano i primi dischi delle Bangles, essenziali e diretti e lo-fi, mentre questo nuovo, superleccato e commerciale, la lasciava fredda e inoltre non le piaceva il modo in cui la cantante Susanna Hoffs – la cui immagine ormai veniva espressamente costruita per una gran figa dello star system – aveva esasperato il suo lato sexy. (Per i miei amici etero, le Bangles divennero la band di riferimento per il resto di quel decennio grazie alla Hoffs). Che quella cosa le desse tanto fastidio mi colse del tutto di sorpresa. Ci eravamo conosciuti da matricole, ed era una ragazza spiritosa, irriverente – com’era possibile una simile presa di posizione priva di senso dell’umorismo su una canzone delle Bangles? Pensavo che Different Light fosse un grande passo avanti per una band che mi piaceva da quando nel 1982 avevo comprato il primo ep, e in realtà quello era un disco pop perfetto, l’unico che avevo ascoltato su cassetta lungo tutto un tour di presentazioni in Inghilterra all’inizio di quell’anno. I miei ricordi del tour sono legati a quelle canzoni, e il testo della title track mi riporterà sempre a una tempesta di neve a Manchester.
La cosa che mi scioccò dell’affermazione della mia amica – e il motivo per cui ricordo quello che sarebbe potuto rimanere un banale disaccordo su un brano pop – fu che finalmente compresi che si poteva mettere in discussione Manic Monday o Different Light o le nuove Bangles da un punto di vista estetico. Ma non mi era mai passato per la testa che una donna intelligente ne fosse contrariata per una serie di altre ragioni: perché rifiutava la nuova immagine femminile che le nuove Bangles stavano proiettando; perché a lei quella canzone sembrava una pericolosa deviazione; perché confermava un aspetto dell’industria musicale che lei aveva sempre odiato. Non dimenticherò mai come storpiò la voce in baby-doll di Susanna Hoffs mentre attraversavamo in auto quella città piovosa e deserta: «I wish it was Sunday | ’cause that’s my fun day | my I don’t have to run day…» Avevo amato questi versi ascoltandoli quotidianamente per tre mesi dopo l’uscita del disco, e non riuscivo a credere che la mia amica avesse trovato in questa canzone dei motivi per fare delle osservazioni riguardo alle discriminazioni di genere. La sua reazione gelò in un istante il mio entusiasmo, e arrossii violentemente quando compresi la sua irritazione; non ero d’accordo, ma potevo capirne le motivazioni, e non aveva senso mettersi a difendere chissà cosa. Avevamo semplicemente due punti di vista diversi. Ciò mi fece anche interrogare su tutti i compiacenti stereotipi (lo erano davvero?) che andavano di moda sui gay, di cui ero stato testimone e che avevo dovuto ripetutamente rifiutare nel corso della mia adolescenza e del mio ingresso nell’età adulta, stereotipi che i miei amici e compagni di classe etero sembravano dare per scontati. Quello che sarebbe dovuto essere un episodio breve e fugace, invece me lo sono portato dietro per decenni: una persona a cui volevo bene si era sentita offesa da una cosa che amavo. Non posso piú ascoltare Manic Monday senza che mi ricordi quella conversazione con la mia amica mentre attraversavamo in auto le colline del Vermont per raggiungere quel cinema fatiscente sulla Main Street. Ma a dire il vero non sono mai stato bravo a capire quali siano le cose che possono offendere.
Sono stato giudicato e recensito da quando sono diventato un autore edito all’età di ventun anni, e nel corso del tempo mi sono completamente abituato a ricevere commenti positivi e negativi, a essere adorato e detestato. Questo è il mio habitat naturale, e non ho mai dato troppo peso alle opinioni che mi riguardano, che fossero pro o contro. La reputazione di scrittore che ne è emersa era basata sul numero dei recensori che avevano amato o no i miei libri, o da che cosa pensavano che io incarnassi. Queste sono le regole del gioco – e ci sta, direi. Tra gli scrittori ero un caso raro, nel senso che venivo apprezzato tanto quanto disprezzato. Al contrario dei miei colleghi, se a un critico o a una critica non piacevano i miei libri, questi non venivano educatamente ignorati – venivo massacrato. E dubito che altri scrittori della mia generazione abbiano ricevuto stroncature peggiori delle mie – e non mi sto vantando o lamentando, è la pura verità. Ma ricevere recensioni negative non ha mai cambiato il mio modo di scrivere o i temi che volevo indagare, non importa quanto certi lettori si sentissero offesi dalle mie descrizioni di sesso e violenza. Come figlio della Generazione X, rifiutare, o meglio ignorare lo status quo mi veniva facile.
Uno dei brani piú emblematici della mia generazione era Bad Reputation di Joan Jett, il cui ritornello proclamava quanto poco le importasse della sua reputazione e che non aveva paura di «nessuna deviazione». E la mia reputazione venne presa di mira dal pensiero di gruppo quando la casa madre proprietaria dell’editore per cui pubblicavo decise che non gradiva i contenuti di un certo mio romanzo per cui mi aveva fatto un contratto, e di conseguenza si rifiutò di pubblicarlo adducendo motivazioni di «gusto» – quel libro li aveva disgustati. Questa è una storia su cui tornerò piú avanti, ma si trattò di un momento spaventoso per le arti – anche se poi ha cominciato a sembrare normale: in realtà, un grande gruppo editoriale stava decidendo che cos’era permesso oppure no, che cosa si poteva o non si poteva leggere, che cosa potevi dire e che cosa non ti era permesso dire. La differenza tra allora (1990) e oggi sta nel fatto che all’epoca ci furono vibranti proteste e argomentazioni da entrambi i lati di questa contesa: le persone avevano opinioni diverse eppure ne discutevano razionalmente, guidate dalla passione e dalla logica. All’epoca l’idea di una censura da parte di una grande corporation non era cosí accettabile. Non potevi sostenere che un determinato spettacolo della Hbo non dovesse essere scritto, aggrappandoti al suo presunto (e tutto da dimostrare) razzismo. Non esisteva, ancora, una cosa come lo psicoreato – un’accusa oggi normale. Le persone inoltre si ascoltavano, e ricordo quello come un periodo in cui potevi essere fieramente convinto delle tue opinioni e apertamente critico senza essere considerato un troll e un hater da escludere dal mondo «civilizzato» se le tue idee erano diverse da quelle della maggioranza.
In un episodio di South Park del 2015, il personaggio di nome Cartman e altri suoi concittadini restano incantati da Yelp, un’app che consente ai clienti di valutare e recensire i ristoranti, e iniziano a ricordare ai maître e ai camerieri che posteranno i loro giudizi sulla qualità dei piatti. Questi Yelper minacciano di dare ai ristoranti solo una stella su cinque se non soddisfano tutti i loro desideri e se non fanno esattamente ciò che gli viene richiesto. Il risultato è che i ristoratori capiscono di non avere altra scelta che adeguarsi, e gli Yelper sfruttano il loro potere per avere portate gratis e suggerire come migliorare l’illuminazione. I dipendenti tollerano tutto questo con crescente rabbia e frustrazione – a un certo punto uno dei recensori di Yelp viene addirittura paragonato all’Isis – finché le due parti non arrivano a una tregua. Ma senza che gli Yelper se ne rendano conto, la vendetta del ristorante consiste nel contaminare i loro piatti con tutti i liquidi corporei immaginabili (e sottolineo tutti). Il succo dell’episodio è che i clienti ormai si sono collettivamente illusi di essere dei critici professionisti – vedi la frase «Tutti si fidano delle mie recensioni Yelp!» – anche se non hanno idea di che cazzo stanno dicendo. Ma nel raffigurare la vendetta del ristorante l’episodio ci dà anche un disarmante resoconto di quella cosa che oggi va sotto il nome di «economia della reputazione». Che siano i servizi oggi a giudicare noi a loro volta solleva la questione di come ci presentiamo online e sui social, e di come gli individui possano sia brandizzare se stessi sia venire brandizzati. Quando tutti pretendono di passare per specialisti e di avere una voce che ha diritto di essere ascoltata, ciò in realtà rende la voce di ciascuno meno significativa. Tutto quello che abbiamo ottenuto in effetti è di ritrovarci incasellati – per essere venduti, brandizzati, usati come target pubblicitari o fonti di dati. Ma questa è la logica conclusione della democratizzazione della cultura e del temibile culto dell’inclusione, che insiste sul fatto che tutti debbano vivere sotto lo stesso sistema di regole e regolamenti: un mandato che detta a tutti noi come dovremmo esprimerci o comportarci.
Molte persone di una certa fascia di età probabilmente hanno notato tutto ciò quando si sono iscritte al loro primissimo social creato e gestito da una corporation. Facebook incoraggiava gli utenti a usare i «mi piace», e dato che questa piattaforma è stata quella in cui le persone per la prima volta si sono autobrandizzate sul Web, il loro impulso naturale è stato seguire il verbo di Facebook e presentare un ritratto idealizzato di se stesse – in modo da apparire piú carine, piú amichevoli, piú melense. E questo fu il momento in cui nacquero i concetti gemelli del «mi piace» e di «relazionabilità», che messi assieme iniziarono a ridurre tutti noi, in definitiva, a una versione castrata di personaggi da Arancia meccanica asserviti all’ennesima versione dello status quo voluta da una corporation. Per essere accettati, dovevamo seguire un codice morale positivo secondo cui tutto doveva piacere e ogni voce doveva essere rispettata, e chiunque avesse opinioni negative o impopolari che non fossero inclusive – in altre parole, fosse portatore di un semplice «non mi piace» – sarebbe stato escluso dalla conversazione, e spietatamente umiliato. Dosi assurde di invettive venivano lanciate al presunto troll, al punto che a paragone di queste l’«offesa» o la «trasgressione» o la «battuta da insensibile testa di cazzo» o l’«idea» all’origine di tutto pareva una cosa da nulla. Nella nuova era digitale post-Impero ci siamo abituati a recensire gli spettacoli televisivi, i ristoranti, i videogiochi, i libri, perfino i medici, e in generale diamo giudizi positivi perché nessuno vuol passare per hater. E anche se non lo sei, è cosí che vieni etichettato se ti allontani dal gregge.
Ma allo stesso tempo, e in misura sempre maggiore, sono anche le corporation a recensire noi (vedi sopra). Aziende della sharing economy come Uber e Airbnb valutano i loro clienti e rifiutano quelli che non passano l’esame. E dato che opinioni personali e riscontri critici viaggiano in entrambe le direzioni, le persone hanno iniziato a preoccuparsi di essere all’altezza. Per un breve istante sono stato intrigato dalla possibilità che l’economia della reputazione potesse stimolare la cultura della gogna – rendendoci piú onesti e critici che mai – ma l’insipida idea propria della cultura aziendale, consistente nel farsi piacere tutto per proteggere se stessi, di risultare falsamente positivi cosí da non venire esclusi dal gruppo, si è solo fatta piú forte e piú pervasiva. Ciascuno continua a postare giudizi positivi nella speranza di ottenerne a sua volta. Anziché abbracciare l’autentica natura contraddittoria di noi esseri umani, con tutti i nostri difetti e mancanze e imperfezioni, continuiamo a trasformare noi stessi in robot virtuosi – o almeno in quello che da parte nostra riteniamo debba essere un robot virtuoso. Questo di conseguenza ci ha portati alla pessima idea – e al florido business – dei reputation managers, che vengono retribuiti per coadiuvare la creazione di un’identità piú piacevole e «relazionabile». Destinata a manipolare il sistema, questa nuova pratica è una forma di inganno, un tentativo di cancellare (curiosamente) sia la soggettività sia l’oggettività, di valutare qualsiasi cosa attraverso l’opinione di massa, il tutto a prezzi esorbitanti.
Come per praticamente ogni altra cosa, l’unico obiettivo di un’azienda che cura la reputazione online è fare soldi. Ci spinge a adottare l’insulso conformismo proprio della cultura delle corporation e ci obbliga a giocare in difesa riverniciando le nostre identità imperfette di modo che noi si possa vendere e comprare – perché chi vuole farsi dare un passaggio o affittare una casa o farsi curare da uno che non ha una buona reputazione online? La new economy dipende dal fatto che ciascuno mantenga un atteggiamento reverenzialmente cauto e assai pratico: tieni chiuse la bocca e le gambe, sii umile e non avere altre opinioni se non quelle espresse in quel momento dal pensiero di gruppo piú diffuso, cazzo. L’economia della reputazione è un altro esempio di come la nostra cultura venga resa insipida, anche se l’imposizione del pensiero di gruppo attraverso i social ha solo accresciuto l’ansia e la paranoia, perché coloro che approvano entusiasticamente l’economia della reputazione sono anche, va da sé, i piú spaventati. Che succederebbe se dovessero perdere quello che per loro è diventato il piú – se non il solo – prezioso patrimonio? Questo è un altro segnale inquietante di quanto siano disperate le persone da un punto di vista economico, e di come il solo strumento che abbiano per migliorare la loro condizione sia una reputazione scintillante e ottimista con la sua superficie fintamente perfetta – cosa che accresce la loro incessante preoccupazione, il loro bisogno inestinguibile di ottenere «mi piace», «mi piace», «mi piace». Ciò che le persone sembrano dimenticare tra questi miasmi di narcisismo fasullo, e nella nostra nuova cultura dell’ostentazione, è che l’autoaffermazione non deriva dal mettere un «mi piace» a questo o a quello, ma dall’essere fedele al tuo incasinato e contraddittorio io – il che talvolta, in realtà, significa essere un hater.
Esistono limiti nel mettere in mostra le proprie qualità piú lusinghiere perché, per quanto genuini e autentici possiamo pensare di essere, stiamo sempre e solo fabbricando un concetto per i social, al di là di quanto davvero sia o appaia accurato. Ciò che viene cancellato sono le contraddizioni che appartengono a ciascuno di noi. Chi di noi rivela difetti e incoerenze o dà voce a idee impopolari improvvisamente terrorizza quelli intrappolati nel mondo di conformismo e censura sociale delle corporation, che rifiuta chi ragiona con la propria testa e gli anticonformisti, spingendo tutti ad armonizzarsi con la concezione di ideale di un altro. Sono rare le persone che desiderano solo essere negative o complicate, ma che succede se proprio queste caratteristiche sono appannaggio di persone autenticamente interessanti, affascinanti e fuori dal comune – in tal caso, allora, non può esserci un vero dialogo? Il crimine piú grande commesso in questo nuovo mondo è quello di stroncare la passione e ridurre al silenzio l’individuo.
Quando nell’autunno del 1989 stavo terminando la stesura di American Psycho, mostrai alcune pagine del romanzo alla persona con cui all’epoca mi ero ritrovato ad avere una relazione, un avvocato di Wall Street con qualche anno piú di me, originario della Virginia, di bell’aspetto e non dichiarato – il che significava che, siccome nemmeno io ero ancora ufficialmente gay, ci presentavamo semplicemente come amici, anche se, è ovvio, le persone a noi vicine sapevano come stavano le cose, ma non necessariamente i tizi con cui lui lavorava da Millbank, Tweed, Hadley & McCloy. Dato che stavamo assieme da un anno, Jim naturalmente era curioso di sapere a che cosa stavo lavorando, e visto che non avevo fatto leggere a nessuno nemmeno una parola del libro da quando avevo iniziato a scriverlo due anni prima, pensai che non ci fosse nulla di male se gli permettevo di dare un’occhiata. In minima parte aveva influito sulla creazione di Patrick Bateman, anche se si trattava innanzitutto di un romanzo che esprimeva la mia intima sofferenza nello sforzo di accettare – senza riuscirci – l’ingresso nel mondo degli adulti in quei perduti anni yuppie alla fine degli Ottanta. Dopo aver letto due capitoli che avevano attirato la sua attenzione, Jim si voltò verso di me – stavo correggendo il manoscritto seduto sull’altro lato del letto – e mi disse: – Stai per cacciarti nei guai –. Ricordo molto distintamente la mia fitta di panico, e anche il vortice di smarrimento che mi avvolse mentre mi giravo verso di lui, alzando gli occhi dalle pagine che stavo correggendo, e gli chiesi: – Che cosa intendi? – Lui aveva appena terminato la parte che introduceva il primo stupro, e il successivo omicidio, di una donna – il pranzo con Bethany e quel che segue – e mi disse solo: – Stai per cacciarti nei guai, con questo –. Io subito mi irritai e minimizzai, perché niente di simile mi era mai passato per la testa. Avevo scritto la maggior parte di quella scena piú di un anno e mezzo prima, e solo di recente avevo aggiunto i dettagli piú violenti; avevo iniziato a pensare ad American Psycho come a un libro cosí stilizzato da sfiorare il romanzo sperimentale, e che a malapena avrebbe trovato qualche lettore. Se il libro fosse stato preso cosí, come avrei potuto cacciarmi nei guai?
Ma allo stesso tempo capii che se Jim – un tipo tranquillo, equilibrato, laureato a Princeton, sempre calmo e umile, mai propenso a far drammi – la pensava cosí, automaticamente la cosa aveva un peso, soprattutto considerando il modo obiettivo con cui me l’aveva detto. Lo squadrai e gli chiesi: – Con chi dovrei cacciarmi nei guai? – E lui rispose: – Con tutti –. Si mise a leggere ad alta voce alcune righe sullo stupro che in modo rapido e selvaggio diventa un omicidio – di una violenza brutale, certo, ma si trattava di una cosa che per me era giustificata nell’ambito di quel contesto, di chi e di che cosa stavo scrivendo. Sentire Jim estrapolare quelle righe isolate mi fece pensare che sí, avrebbero potuto offendere qualcuno, ma non la storia nel suo complesso. Quella era la scelta estetica del ritratto che stavo cercando di dipingere – con quei colori, quel pennello – e sentivo che le esplosioni di violenza erano necessarie al mio scopo. Questo era ciò che mi diceva il mio istinto drammatico. Non c’erano regole. – E se, – dissi, – fosse tutto nella sua testa? – È cosí? – mi chiese Jim. – Non lo so, – ricordo di avergli risposto. – A volte penso che sia tutto nella sua testa, e altre volte no –. Jim diede un’occhiata alle pagine che stava leggendo, e poi tornò a guardarmi. – Non ha importanza, – disse. – Ti caccerai nei guai comunque –. Sul momento il giudizio iniziale di Jim non ebbe alcun impatto sul libro – non cambiai nulla in seguito alle sue parole – ma mentre terminavo di correggerlo e riscriverlo la sua reazione continuò a girarmi per la testa, anche dopo che consegnai American Psycho al mio editore quel dicembre e il romanzo iniziò l’usuale percorso verso la pubblicazione. Tuttavia, quando venne letto e rivisto dal mio editor, e poi messo in bozze, e quindi passato ai grafici, iniziarono i mal di pancia. Alla Simon & Schuster ci fu chi lo ritenne offensivo. A sentirsi offese erano innanzitutto le donne, ma con il suo miscuglio di violenza, sesso e umorismo nero il libro finí per risultare misogino in modo scioccante anche per alcuni uomini. I media iniziarono a raccogliere indiscrezioni sul disagio all’interno della S&S, che premeva – la copertina era già stata disegnata e approvata – per fissare la data di pubblicazione a gennaio, a cui ormai mancavano pochi mesi. E, proprio come aveva previsto Jim un anno prima, a notte fonda nel suo loft di Bond Street, mi ero decisamente cacciato nei guai.
Il libro venne cancellato nel novembre del 1990, due mesi prima della data di pubblicazione annunciata da Simon & Schuster la primavera precedente. Erano state fatte circolare delle bozze rilegate, e alcuni dei primi lettori difesero (che l’avessero letto o no) il romanzo che credevo di aver scritto – una farsa macabra con un narratore inattendibile – ma tutto questo non importava: gli strepiti di coloro che si riten...